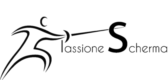Il fioretto questo sconosciuto.
Il primo maestro non si scorda mai
Quando le divise erano solo bianche
Un vero optional : la sacca delle armi
Quando le stoccate erano a vista
Campionati, trofei, coppe e similari
Il Gran Premio Giovanissimi
Il Gran Premio Giovani e il dopo
Introduzione
Scrivere di Storia, anche limitatamente ad una disciplina sportiva, non è impresa facile: il rischio incombente (la famosa spada di Damocle sopra la testa, tanto ad hoc per noi schermitori!) è quello di scadere nel… Ora non è più come prima, ai miei tempi sì che….!
Eppure è comune asserzione che historia docet, cioè che la storia insegni; ma la condizione essenziale tuttavia è quella che ci sia un buon insegnante, oltre naturalmente ad altrettanto buoni allievi.
Per evitare il pericolo di eventuali divisioni manichee tra bene del passato e male odierno, cercherò quindi di astenermi quanto più è possibile da commenti personali, tralasciando anche, per non far torto a nessuno, nomi di atleti e società che pur hanno fatto grande la nostra disciplina in quel decennio che va dalla metà degli anni sessanta alla metà degli anni settanta.
Al di là della diatriba tra la concezione eraclitea del pantha rei e quella della ciclicità della storia di vichiana memoria, credo che per ogni persona, soprattutto per quelle che fanno parte di un movimento, sia molto importante e formativo sapere chi c’era prima e quali fossero i precedenti costumi, regole e connotati vari.
Prendo volentieri questo tentativo sulle mie spalle anche perché dal decennio che cercherò di raccontare ai nostri giorni il mondo della scherma indubbiamente è cambiato e non di poco: i giovani schermitori d’oggi probabilmente stenteranno a credere a certe cose, come i miei figli si sono stupiti quando ho raccontato loro che da piccolo giocavo a pallone per le strade della mia Firenze.
Saranno toccate direttamente o indirettamente molte sfaccettature del nostro ambiente: da quelle tecniche, a quelle agonistiche, da quelle culturali a quelle di costume, da quelle ambientali a quelle, lato sensu, sociologiche. Insomma lo shaker sarà ricolmo!
Confesso al lettore che probabilmente scrivo non solo per raccontare, ma anche e soprattutto per ricordare: sto provando una strana sensazione a scoprire che riesco ancora ad aprire files nascosti nella mia mente da decenni; nascosti, ma mai cancellati.
Cercherò anche di abbondare nel frivolo sarcasmo che mi deriva dai miei natali fiorentini: lungi da me il cercare di commuovere; voglio anzi tentare con le mie storie di far increspare il più possibile le vostre labbra.
Montiamo quindi sulla famosa macchina del tempo scaturita dalla fervida ed alacre fantasia del romanziere H.G.Wels, tiriamo la cloche, ovviamente all’indietro, e preparatevi a vederne delle belle.
Stefano Gardenti
a Firenze, nell’ottobre del 2009
Il fioretto questo sconosciuto
Venne qualcuno a scuola, ero in prima media.
Non fu organizzato un corso o una presentazione come è in uso oggi; non ci fu mostrato nemmeno un fioretto od una maschera per adescarci maliziosamente, ci fu solo chiesto se volevamo iscriverci ad un corso gratuito di scherma della durata di alcuni mesi.
Gratis… parola magica, che allora, differentemente dai giorni odierni, non nascondeva alcun tranello, alcun celato inganno. Gratis voleva dire assolutamente gratis!
Ricordo tutto e anche molto bene.
Sono accanto a mia madre che stava stendendo i panni sul balcone: Sai mamma potevo provare a fare scherma, ma dovevo iscrivermi entro oggi; pazienza.
I casi della vita, lo sappiamo tutti, sono misteriosi ed arcani: mia madre aveva visto alcuni anni prima alla televisione una trasmissione sulla scherma e ne era rimasta affascinata, forse addirittura folgorata.
Stefano va; non perdere quest’occasione, potresti non averla mai più.
Siccome i consigli della mamma non tradiscono mai, da figlio ubbidiente, rintuzzato il timore di violare il tassativo termine temporale che il severissimo professore di ginnastica aveva posto, chiesi e ottenni l’iscrizione tardiva (fortuna audaces iuvat!).
La storia, è noto, non si fa con i se ed i ma, tuttavia il dubbio resta: se non avessi accettato l’esortazione di mia madre come avrei fatto senza la scherma e chi sarei oggi senza tutto il bagaglio di esperienze di vita di cui sono debitore alla nostra disciplina?
Sicuramente non avrei baulate di ricordi (e quindi non potrei ora intrattenervi!) e non conserverei impressi nella mia mente innumerevoli volti di amici e di maestri.
Bastava che dimenticassi per il secondo giorno consecutivo il “file” corso di scherma.
Da qui una certezza: l’importanza dei cosiddetti peli nel mondo! Proprio per un pelo potevo perdermi tutto.
Avrei potuto approdare ad altri lidi, non so, il tennis, la pallacanestro, il calcio e magari oggi vi scriverei di terra rossa (pardon, di sintetico), di parquet e di manto erboso.
E se non avessi trovato la nave giusta?! Se non avessi fatto un bel niente nell’ambito sportivo, come era frequente in quegl’anni?!
Meglio non pensarci!
Cominciò quindi la mia avventura tra le lame, per desiderio e scelta indotta della mamma, come spesso capitava in quel tempo e come capita ora (l’influenza delle mamme sui figli è evidentemente una rilevantissima costante storica).
Non è che l’idea mi dispiacesse in sé per sé, solo che non avevo pulsioni particolari, tipo io dopo le scuole medie voglio iscrivermi al liceo scientifico o io da grande voglio fare il vigile, l’ingegnere, l’avvocato….
Figuriamoci praticare un’attività sportiva!
Non c’erano ancora i fenomeni trainanti come Alberto Tomba, Juri Chechi, Alessandra Pellegrini, Vezzali e Montano. C’era sì la Fiorentina con Hambrin e Montuori, ma non c’erano le, diciamo, pressioni che esistono oggi.
Comunque per me fu l’inizio.
Eravamo una cinquantina, tutti compagni della stessa scuola; ci presentammo il primo giorno all’indirizzo convenuto con molta curiosità.
Il luogo era un palestrone lungo e largo dove ci fecero correre, saltare la cavallina, fare capriole e altre amenità del genere.
Commentando tra noi, qualcuno disse: ma questa è la ginnastica che facciamo a scuola!
In effetti nessuna traccia delle spade (il temine più noto a noi profani) o di duelli (il termine assalto non faceva ancora parte del nostro vocabolario; per l’assalto era quello che facevano alla diligenza nei film western).
Della presenza di pedane, macchine per registrare le stoccate o quant’altro non ci preoccupammo affatto per il semplice motivo che non ne conoscevamo nemmeno l’esistenza.
La ginnastica continuò per un tempo indefinito ed in una cinquantina, quanti eravamo, facevamo proprio, con licenza verbale, un bel casino.
Poi comparve un signore: era vestito da civile senza nulla che potesse attirare su di lui una particolare attenzione; si presentò e da quel momento cominciò un’oceanica lezione di scherma collettiva.
Ci fece piegare le gambe in una posizione scomodissima e anche le braccia, una alzata dietro ed una allungata in avanti, cominciarono ben presto a pesare.
Quella davanti era giusto tenerla così (prima o poi avremmo impugnato un’arma), lo capivamo anche da profani; ma quella dietro perché metterla così in alto (per tenere la lanterna quando si duella al buio, aveva detto il maestro con uno strano sorriso sulle labbra; d’accordo, ma allora quando c’era il sole la potevamo tenere giù?!).
In quella posizione ci sentivamo buffi e, guardandoci l’uno con l’altro, sghignazzavamo sotto i baffi, pardon la scomoda peluria che a undici anni comincia ad apparire sopra il labbro superiore.
E chi poteva sospettare che in quella postura avrei passato ore, giorni, mesi e anni. Dopo un paio d’anni di scherma avrei potuto prendere anche thè e pasticcini in guardia! Ma chi se lo poteva minimamente immaginare durante quelle prime volte.
Insomma questo piccolo battaglione, abbastanza compatto, andava ora anche avanti e indietro e ad una battuta di mani si doveva allungare in una posizione quasi allucinante, l’affondo ci disse il maestro.
Speriamo che ce ne faccia fare pochi di questi cosi, disse sottovoce, sbuffando dalla fatica, un nostro compagno un po’ paffutello.
Già era difficile stare in guardia, figuriamoci metterci in quest’altra posizione assurda tutti stirati in avanti.
E poi non andava bene mai nulla: o era il piede davanti a esser messo male o quello dietro; no così il braccio non va; il peso del corpo va distribuito su tutte e due le gambe(!); tira su le spalle (ma come questo qui sta attento anche alle spalle?!).
Le cose andarono avanti per parecchie volte nello stesso modo: sempre avanti, indietro, affondo e passo avanti affondo (ora sapevamo fare anche questo).
Dopo poche lezioni della cinquantina iniziale restammo circa in venti (capii al liceo che si trattava della famosa selezione naturale di Charles Darwin).
Nessuno osava dire che la scherma era una schifezza, quelli erano tempi di estrema riservatezza di opinioni: piuttosto c’erano i compiti da fare (ma guarda un po’!), faceva male un po’ la pancia (molto improbabile per i pochi dolciumi che a quell’epoca riuscivamo ad arraffare), da accompagnare la mamma a fare la spesa (ma come sei diventato gentile!) e altre più o meno spudorate bugie.
Ma c’era chi le bugie le sapeva dire e chi no! Ed il professore di ginnastica, il promotore dell’iniziativa parascolastica, faceva a scuola degl’interrogatori di terzo grado, anche se non aveva a disposizione la famosa lampada dei film polizieschi.
Quindi la squadra dei venti sopravvissuti era indotta a resistere eroicamente alla ginnastica e ai soliti spostamenti; ormai c’era solo la forza della rassegnazione.
Poi un giorno il cuore cominciò a batterci più forte: il maestro ci disse che finalmente avremmo presto usato il braccio armato con il fioretto (noi comunque nelle nostre teste continuavamo a volere la spada di Zorro, quel signore con i baffetti, che poi in verità, almeno nei telefilm della televisione, impugnava una sciabola!).
A questo punto cosa ti aspetti: scintillio di lame, cozzar di brandi, acciaio da tutte le parti… invece il maestro ci fa spostare il braccio da una parte, dall’altra, in su e in giù; ci raccomanda anche di essere attenti e precisi perché queste posizioni sarebbero state importantissime.
Capito, capito! Ancora di armi vere (!) non se ne sarebbe parlato.
E pretendeva anche che imparassimo i nomi: prima o mezzo cerchio (meno male che col nome doppio ce n’era solo una!), seconda, terza e quarta.
Niente di più facile, se le posizioni fossero ruotate consecutivamente in senso orario oppure in senso sinistrorso; invece le denominazioni erano state date apparentemente a casaccio, in ordine sparso, probabilmente per rendere difficile una cosa facile! Un’inutile complicazione della vita, un genuino prodotto dell’ufficio complicazioni affari semplici, che ho ben conosciuto negl’anni che ho lavorato in banca.
Anche se erano solo quattro posizioni, furono dolori.
Mio padre in quel periodo stava prendendo la patente per la macchina ed io associavo le posizioni da imparare alle marce dell’automobile, che peraltro aveva il cambio a cloche vicino al volante. Mio padre cambiava marcia ed io ripassavo le posizioni!
Altri tre allenamenti passati così e restammo in sette: il professore di ginnastica, messo in minoranza, si era rassegnato anche lui.
In quel periodo ero stato al cinema ed avevo visto (due volte di seguito com’era consueto all’epoca) “I magnifici sette” un film dove dei poveri peones messicani, taglieggiati da una banda di pistoleros, ricorrono all’aiuto di altri pistoleros, però buoni e, alla fine della storia, redenti.
Aristotele con la sua associazione d’idee ha sempre fatto miracoli: i magnifici sette fummo noi e giurammo di non smettere mai di fare scherma; tra l’altro avevamo sentito dire in giro che era meglio essere pochi, ma buoni (bella consolazione!)
Roba da film! E tutti sanno che purtroppo i giuramenti durano quanto durano e di spergiuri è pieno il mondo.
Restammo in cinque.
Un giorno era un allenamento come un altro, quando vedemmo arrivare il maestro con un fascio di ferri che teneva insieme con una mano; in fondo avevano dei pezzi luccicanti di forma tondeggiante.
Un tuffo al cuore (vero), ci sono le spade!
E il maestro disse, ragazzi oggi finalmente vi ho portato i fioretti!
Ero giovane, molto giovane, ma cominciai a capire con quest’episodio l’importanza dell’attesa e della relativa necessaria pazienza, che erano la necessaria anticamera per un incontenibile gioia finale.
Formula: patire (si fa così per dire) prima per godere dopo; non tutto e subito!
Era arrivato, inaspettato, il grande giorno: il fioretto non era più per noi uno sconosciuto.
Cinque belle armi in mano a cinque ragazzetti palpitanti; dovevamo essere una bella scenetta, quasi da appendice al libro Cuore.
Il maestro ci disse come impugnare l’arma e finalmente ci sentimmo più veri.
Ora tutto era più logico: la guardia, gli spostamenti, l’affondo e soprattutto le famose prima, seconda, terza e quarta.
Ci fece sedere su una panca, tutti e cinque e, ad uno ad uno, ci chiamò per fare la nostra prima lezione individuale; sì, ognuno da solo con e contro di lui.
Ovviamente nessuno di noi voleva andare per primo, ma bastò un secondo richiamo del maestro che uno dei miei compagni, quello più vicino a lui, un po’ rosso in viso si alzasse e si mettesse in guardia: era il noto e povero agnello sacrificale.
Inequivocabilmente la nostra era una generazione di timidi e in quella palestra ce n’era una degnissima rappresentanza.
Nulla andava bene al maestro, che probabilmente aveva ottimi rapporti con il famoso ciclista Gino Bartali, noto per il celebre detto è tutto sbagliato, è tutto da rifare.
Come se non bastasse ogni tanto vibrava tremende mazzate (o almeno ci parevano tali) sulla nostra lama con la sua, dicendoci per di più a gran voce di tenere il fioretto solo con tre dita e senza metterci forza.
Beh, almeno è simpatico e si diverte a scherzare, pensammo; lui invece ci stava abituando alla stretta in tempo.
Mi accorsi, quasi con orrore, di essere l’ultimo della fila e mi misi quindi di buona lena a seguire le lezioni dei miei compagni per essere più preparato quando fosse giunto il mio turno.
La voce del maestro mi giunse, assieme al suo sguardo tagliente: Stai molto attento, perché tu che sarai l’ultimo dopo tutti gli altri dovrai fare una lezione perfetta”.
Ebbi allora la prova inconfutabile che i maestri sapevano leggere nella mente degli allievi e quel pomeriggio imparai di conseguenza un’altra cosa: che lo schermitore doveva per forza essere un pensatore.
Mano a mano sfilarono via tutti i miei compagni ed avendo avuto il permesso di andarsene al termine della lezione (grondavano sudore e sangue), mi ritrovai nel palestrone solo davanti al maestro.
Ma questa parte della storia merita un capitoletto tutto suo, quindi voltiamo pagina.
Il primo maestro non si scorda mai
Io e il maestro da soli, silenzio assoluto tutt’intorno a noi.
Ora se una qualsiasi paperetta, aprendo per la prima volta i suoi occhi e vedendo un signore dai capelli e dal pizzetto bianco (tale l’etologo Conrad Lorenz), pensa e prorompe nell’imprinting mamma.
In quale luce credete che io abbia visto il maestro di fronte a me?!
Appunto: il primo maestro non si scorda mai.
Indossava un piccolo giubbino bianco trapuntato davanti e si capiva subito che era lì che si dovevano indirizzare i nostri colpi, le stoccate non gli avrebbero fatto male; i pantaloni invece erano normali, di quelli che si usano per la strada, pensai.
Comunque la cosa che colpiva di più era quello che aveva in testa: mi precisò non un elmo, ma una maschera (sino a quell’istante per me le maschere erano quelle di carnevale!).
Era di ferro o qualcosa del genere: di occhi ne abbiamo due soli ed è meglio starci attenti, mi disse (era un responsabile antesignano delle norme di sicurezza che tanto ci assillano oggi).
Non vedevo la sua bocca, ma sentivo chiaramente la sua voce e la sensazione era quella che mi parlasse un manichino: le parole uscivano dalle maglie scure e talvolta, a seconda della luce, mi sembrava anche d’intravedere gli occhi ed il volto.
Con la maschera si diventa invulnerabili pensai, proprio come Achille. A scuola stavo studiando il primo poema omerico e neanche a dirlo era il mio eroe preferito (bella forza: vinceva sempre e perse solo a tradimento.
Le prime parole che udii furono: non ti preoccupare di niente, almeno per ora! La lezione è una cosa tra me e te! Non dovrai combattere contro di me, ma contro gli altri, tutti gli altri e io te lo insegnerò. Voleva rassicurarmi, ma io ero teso come la corda di un violino, anzi di un’arpa.
Cominciò a muoversi e mi disse adattati.
Ma che vuol dire, pensai.
Invece subito dopo le mosse, che assieme ai miei compagni avevamo ripetuto quasi sino all’ossessione nel vuoto e senza nulla in mano, cominciarono mano a mano che la lezione progrediva ad avere un senso compiuto.
Il passo avanti o indietro li utilizzavo a seconda dei casi per mantenere la stessa distanza dal maestro, l’affondo per poter raggiungere il suo bersaglio; ed ecco a cosa servivano quelle quattro posizioni attorno al mio corpo.
I suoni che le lame producevano scontrandosi tra loro li avevo uditi anche prima, quando a fare la lezione erano i miei compagni; quello che invece sentivo ora per la prima volta era una strana sensazione nella mano: stavo impugnando un’arma.
Tutte cose nuove, quante cose nuove!
Una strana posizione piegati sulle gambe (quasi buffa) – il fioretto che si sposta da tutte le parti, ma non così a caso: deve fare proprio una strada precisa e si deve fermare proprio lì, non prima e non oltre – se l’affondo non basta, allora ci si può aggiungere prima un passo – la cavazione (ma che strana parola) eccetera, eccetera.
La mia prima lezione finì, ma quante altre prime lezioni m’impartì il mio maestro!
E tutte le volte c’era la ripetizione di tutto quello che avevamo fatto prima. La scherma è come la matematica, diceva, se non ti ricordi, e bene, quello che c’è prima non puoi andare avanti e, se lo fai, costruisci molto probabilmente qualcosa di sbagliato.
Poi un giorno una grossa novità: tutto quello che prima potevo, anzi dovevo fare piano e tranquillamente, così, quasi di punto in bianco, mi fu chiesto di farlo velocemente, più velocemente, ancora di più.
Insomma davo tutto me stesso, ma sembrava non bastasse mai.
Poi il maestro disse “abbastanza bene”.
Ma come abbastanza bene! Era il mio massimo ed ero bagnato fradicio di sudore.
Come potevo capire, allora, quella che è una delle componenti più affascinanti della nostra disciplina (e ce ne ho messo del tempo!): nella scherma la perfezione e la velocità massima non esistono, ma si possono solo rincorrere e, arrivati ad una certa soglia, essa svanisce come un miraggio per ricomparire un po’ più in là.
No! Quel maestro non potrò mai più scordarlo: è lui che è riuscito ad accendere in me un fuoco degno della più premurosa e attenta vestale; è lui che mi ha fatto capire che la scherma (più di ogni altra disciplina sportiva) è coreograficamente il mezzo più idoneo per cercare onore e gloria; è lui che ha temperato con intelligenza questa ricerca di affermazione con il principio che vincere è bello, ma ancor più bello è combattere per cercare di vincere.
Oggi so cosa mi stava trasfondendo di lezione in lezione quel mio primo maestro: non solo la tecnica, ma anche e soprattutto la passione per la scherma.
La vita però talvolta divide: io, a differenza delle lepri, non ero stanziale e spesso dovevo cambiare il mio territorio. Mio padre era dirigente di banca ed i suoi amministratori delegati sembrava che non avessero altro da fare che farci cambiare residenza ogni due o tre anni.
Lasciai quindi il mio primo maestro e ne ebbi altri, tanti altri, forse troppi.
Ma Giano è bifronte e, se una faccia piange, l’altra sorride.
Ogni volta, da buon beduino, dovevo smontare la mia tenda per rimontarla altrove, ma così facendo entravo in contatto con nuove realtà, nuovi compagni e soprattutto nuove scuole di scherma.
Indubbiamente il continuo e ripetuto confronto tra concezioni schermistiche diverse mi è stato molto utile: ciò che ho perso sul piano affettivo e sentimentale, l’ho indubbiamente acquistato nella natura forzatamente cosmopolita della mia formazione.
In questo mio fatal andare, obtorto collo, ho dovuto anche più volte cambiare specialità in funzione delle caratteristiche dei vari circoli ai quali mano a mano approdavo.
E questo fatto mi ha insegnato anche un’altra cosa, ormai per me importantissima e fondamentale.
Spesso la chiedo come risposta ad una domanda che pongo ai miei allievi: Qual è tra fioretto, spada e sciabola l’arma più bella?
Ebbene per me la risposta non può essere che: la scherma!
A questo punto chiedo scusa se ho parlato un po’ troppo della mia personale avventura, ma del resto ci tenevo a presentarmi un po’ e farvi partecipi dei risvolti della mia vita schermistica.
Nel mio piccolo sono stato un modesto Ulisse e ho potuto vedere cose quasi incredibili per chi, al contrario, non ha mai varcato la soglia, oltre la propria, di altre sale di scherma.
Sono stato sia al Sud, sia al Centro, sia al Nord, in tempi in cui questo voleva dire entrare in contatto con marcate differenze culturali e non solo di segno schermistico.
In quegl’anni, con pochissime eccezioni, la spada era diffusa soprattutto nel settentrione, la sciabola ed il fioretto nelle altre parti d’Italia. Addirittura la scelta del tipo di manico era collegata al parallelo geografico dove tiravi di scherma.
Oggi è tutto più, diciamo, globalizzato; e questo non solo nella scherma, ma anche e soprattutto nella cosiddetta società civile.
Qui di seguito comincio volentieri ad aprirvi gli archivi della mia memoria affinché possiate, se proprio lo volete, fare paragoni con i tempi attuali.
Sta a voi e solo a voi prorompere in meno male che le cose sono cambiate oppure in peccato che questo non ci siano più.
Il manico dimenticato
Vi ho già detto come eravamo tutti eccitati il giorno che vedemmo il nostro primo fioretto.
Ci credo! Dopo tutta quell’attività senza nulla in mano anche un bastone ci sarebbe sembrato la Durlindana di Orlando o Excalibur di re Artù.
Prima di poterlo impugnare, lo guardammo con avida curiosità.
Al di là della magia, il manico era, come dire… simpatico: la lama trapassava un piccolo scudo, che era fissato lateralmente tramite una stanghetta trasversale con due archetti curvi simmetrici.
Il maestro ci disse che quello era il manico italiano e passò a spiegarci minuziosamente tutte le sue parti: lo scudino si chiamava in realtà coccia, la parte piatta della lama dove dovevano essere posizionate le nostre dita era il ricasso, il segmento perpendicolare alla lama era il gavigliano, la parte in legno zigrinato era il manico (proprio lo stesso nome di quello della scopa che usavano le nostre mamme), il grosso dado tondo finale era il pomolo e i due archetti laterali si chiamavano semplicemente archetti (meno male, un nome in meno da ricordare!).
Bello a vedere sì, ma quando si trattò d’impugnarlo cominciarono i guai e soprattutto i dolori: guai perché il maestro in pratica ci faceva tenere tutto il fioretto con tre sole dita (e chi se lo immaginava allora che questo fosse uno dei segreti del portamento dell’arma!), dolori perché il dito medio doveva fare forza sul gavigliano e a lungo andare faceva male da urlo.
In verità non possedevamo ancora il guanto, ma anche con questo sarebbero stati comunque dolori…da calletto.
Il proverbio recita: o schermitore, fammi vedere il dito indice che hai e ti dirò se usi l’italiano che ti fa dire ahi, ahi.
Comunque questo tipo di manico, l’italiano, era il nostro vanto nazionale, in quanto l’altra scuola con la quale eravamo in lizza, quella francese, adottava un’altra impugnatura, neanche a dirlo denominata con sfrenata fantasia francese.
Un giorno il maestro, in vena di reminiscenze storiche, ci raccontò di epici cimenti tra queste due scuole (una specie di moderna Disfida di Barletta): avvenivano addirittura negli stadi, il pubblico era pagante e sull’esito finale venivano scommesse cifre da capogiro. Oggi (che era allora!) siamo proprio caduti in basso, disse.
Permettetemi di presentarvi un fioretto italiano, eccolo qui accanto: bello, o dico bugie?!

Invero c’erano anche le spade a manico italiano, ma in cinquant’anni che frequento le sale di scherma ne ho viste solo un paio: una, tutta arrugginita, in una bacheca di un qualche mio club, l’altra in mano ad uno schermitore che partecipava qualche anno fa ad una selezione regionale.
Deve averla ereditata da suo nonno e deve aver battuto il capo per portarla in gara, è stato l’ironico commento di un mio collega toscano.
Per vedere una manico francese fu necessario trasferirmi al nord dove potei ammirare e toccare anche l’attuale diffusissimo manico anatomico, che in pratica monopolizza il campo.
Il primo in pratica era solo un tubetto che usciva dalla coccia, l’altro invece era buffo, strano, tutto contorto.
Impugnando un francese mi sembrò di avere un bastone in mano, impossibile fare scherma sentenziai subito (da perfetto ignorante!); impugnando un anatomico (che fortunatamente era calibrato per la mia mano) ebbi subito al contrario una gradevole sensazione di comodità e di potenza.
Avevo in pratica firmato la domanda di prepensionamento per il mio primo fioretto italiano, che, da vecchietto, stava accusando tutti i suoi anni e malanni.
Comunque non preoccupatevi per lui: mentre sto scrivendo questa storiella lui (il mio numero uno), assieme alla mia prima sciabola e ad una maschera, mi guarda dall’alto della parete del mio studio: tutti insieme fanno proprio una bella panoplia.
Capii anni addietro cosa era successo circa il manico e ve lo voglio raccontare, perché troppo spesso ci facciamo trascinare dagli eventi senza comprenderli sufficientemente a fondo.
La nostra disciplina stava subendo una grande trasformazione, una di quelle che ho potuto vivere in prima persona, da atleta, direttamente sulla pedana: la componente atletica della prestazione dello schermitore stava prendendo sempre più piede.
Erano lontani, tanto per intendersi, i tempi dei trattati come quello del celebre Masaniello Parise, dove sulla pedana si stava piegati in una guardia eccessivamente bassa e larga, a sedere strascicante tanto per intendersi; per giunta tempi in cui, a giudicare dalle illustrazioni dei trattati dell’epoca, per fare scherma sembra fosse necessario avere i baffetti e stare in sala a torso nudo.
La tecnica di base ruotava prevalentemente sulla predominanza assoluta del lavoro del braccio armato rispetto a quello delle gambe, le quali recitavano sì un ruolo importante, ma sempre subordinato.
C’è gente pronta a giurare che prima gli schermitori erano così veloci di pugno, che potevano uscire di casa anche senza ombrello: in caso di pioggia era sufficiente muovere la loro lama sopra la testa e restavano completamente asciutti (insomma, una specie di frullatore Girmi!).
La velocità di spostamento, estrinsecabile prevalentemente tramite la frecciata, mano a mano prese il sopravvento e contribuì a dare una nuova configurazione statistica allo sviluppo tecnico del match: azioni molto più semplici rispetto a prima, movimenti dell’arma più approssimativi nelle loro traiettorie ed anche maggiore frequenza di situazioni di corpo a corpo caratterizzate dal combattimento ravvicinato, che spesso veniva a crearsi per la grande foga dell’incontro.
L’attrezzo fioretto italiano aveva prestazioni che non si adattavano più alle nuove contingenze: lavorare di cesello con precisione millimetrica (quasi da frate medievale miniaturista) non serviva più a nulla e nel combattimento ravvicinato risultava estremamente difficile spezzare il segmento del braccio armato al fine di ridurre la sua estensione per riuscire a toccare a stretta misura .
Fu la sua fine e al suo posto salì sul trono il manico anatomico, cioè quello che, rispettando la conformazione dell’arto, creava specifici alloggi per ogni singolo dito. Tra l’altro esso garantiva un uso più potente e sicuro del manico in occasione di prese di ferro, di battute e parate.
La presa più sicura a piena mano ha comportato tuttavia delle controindicazioni (ancora una volta è stato appurato che nella vita non c’è nulla di perfetto!).
Il tasso di forza fisica applicato sulle pedane è cresciuto e si è andato a sommare con quell’irruenza dello spostamento di cui abbiamo già fatto cenno alcune righe sopra.
La conseguenza è che lo schermitore per ovvi motivi di sicurezza si è dovuto sempre più barricare dentro la sua divisa e tutto il materiale ha dovuto parametrarsi a questa importante esigenza, facendo crescere (e non di poco) i costi.
Anche il manico francese non è andato molto lontano, almeno nel caso del fioretto; per la spada invece è necessario fare un discorso un po’ più tecnico.
Un’impugnatura, cosa ovvia forse per molti ma forse non per tutti, non limita il suo ruolo al tipo di contatto che instaura con la mano dello schermitore: questa è solo la punta dell’iceberg, mentre il grosso sta sott’acqua.
Con la francese, così per dire, si fa la scherma alla francese: innanzitutto si può variare il tipo di rapporto col manico, optando, a seconda delle contingenze, tra presa a piena mano o mano allungata, guadagnando in quest’ultimo caso preziosi centimetri in lunghezza del braccio armato – si può tirare all’occasione il colpo volante – nel combattimento ravvicinato le dita, non essendo imprigionate nei precisi alvei dell’anatomico, possono lasciare meglio la presa e raccorciare più velocemente e agilmente il braccio, eccetera, eccetera.
Con l’anatomico si hanno indubbiamente minori possibilità di variazione, essendo il rapporto molto più indotto.
Qui l’aspetto, come potete immaginare, diventa culturale: o conosco entrambe le scuole e le propongo ai miei allievi, ai quali, neanche a dirlo, spetta l’ultima voce in capitolo nella scelta; oppure, conoscendone solo una (solo questa o quella, poco importa), la propino direttamente senza tener conto del famoso e caro libero arbitrio.
A voi, cari lettori, la famosa ardua sentenza.
Comunque mi sono accorto che il discorso si è fatto un po’ troppo tecnico e impegnato; non è questo l’intento dell’intrattenimento che vi ho proposto, quindi ricorriamo subito ai ripari.
Vi racconterò (o vi ricorderò a seconda della vostra età) delle fasce e dei cinghietti.
Già in voga per i cosiddetti fioretti italiani, questi aggeggi non erano altro che sotterfugi per assicurare meglio l’arma alla mano. Ma, mentre nel caso dell’italiano andavano, come abbiamo visto, oculatamente a supportare una presa abbastanza incerta, nel caso dell’anatomico rappresentavano, almeno a mio parere, un assurdo doppione perché il manico era già per suo conto più che ospitale nei confronti della mano dello schermitore..
Per questo scopo la stanghetta laterale presente all’altezza del pollice era leggermente più allungata ed arcuata in fuori: essa ospitava i vari passaggi di una fascia (lunga che non finiva mai!) che serrava manico e polso. Se sfortunatamente ti rompevi il polso non era nemmeno necessario andare a farti ingessare il braccio!
Ricordo anche il particolare di un mio compagno che imprigionava la parte terminale di detta fascia tra indice e anulare (ma non gli dava noia?!).
Chi sceglieva il cinghietto si era invece munito di un manico in cui nella suddetta stanghetta era stato fatta una fessura per il passaggio appunto della striscetta di cuoio.
Bei furbi!, sentenziò una volta un mio maestro, “Sicuramente ogni mattina mangiano pane e faina!”.
In effetti contro quel tipo di avversario m’insegnò a cercare di entrare sotto misura, dove, quasi indisturbato, potevo fare quello che volevo, mentre loro gestivano male il loro braccio armato che era un pezzo unico.
Altro fugace ricordo: questi tipetti, quando volevano riprendere un po’ di fiato o magari interrompere una serie negativa di stoccate prese, non dovevano nemmeno fare finta di riallacciarsi una stringa delle scarpe… chiedevano di risistemarsi il polso: sfascia e rifascia, passava così tanto tempo che talvolta il presidente di giuria andava al bar a prendersi un caffè!
Ora che ho raccontato la tua storia e la tua gloria passata ed il lettore, che magari non sapeva nemmeno della tua esistenza, ora sa tutto, sei più contento, vecchio manico?!
Quando le divise erano solo bianche
Al giorno d’oggi il colore, pur timidamente, è alquanto presente sia nelle sale di scherma, sia sui luoghi di gara: pantaloni blu, rossi, verdi – calzettoni con strisce dell’intera gamma dell’iride – scarpe di ogni foggia – guanti dal dorso rosso, blu, viola – addirittura qualche maschera istoriata da qualche spavaldo burlone.
Prima non era così: a voler sintetizzare in due parole la scherma era in bianco e nero.
Bianche le divise degli allievi, nell’eterna lotta tra la maggior parte delle mamme che tendevano quasi a candeggiarle ed i ragazzi che ricercavano quella vaga tonalità grigiastra che concorreva a dar loro un certo tono di vissuto (il famoso bianco stanco dei caroselli di una volta). Offesa delle narici a parte, questa era il trend schermistico.: parfum eau d’éscrimeur!
A questo proposito era da evitarsi in modo assoluto la partecipazione a gare con divise appena lavate: le due ipotesi maggiormente accreditate erano, una che il tessuto tendesse a restringersi un po’ nel lavaggio ed avesse quindi bisogno di un certo rodaggio per essere al cento per cento (un po’ come i piloti di formula uno che devono portare a temperatura i loro pneumatici); la seconda, più di natura metafisica (!), per una questione d’ordine puramente scaramantico.
Detto fra di noi la Superstizione era ed è tuttora una delle dee più venerate dagli atleti, schermitori in specie.
Nere invece le divise dei maestri e anche qui per un duplice possibile intento: il primo che fosse possibile a colpo d’occhio rendersi subito conto di chi comandava in sala, il secondo evidentemente a testimoniare un’astuta mossa delle mogli probabilmente non molto propense a frequenti lavaggi (la lavatrice era ancora un elettrodomestico per pochi).
Scherzi a parte varie sono le teorie che stanno alla base della preponderanza del bianco nelle attrezzature: esso richiama il colore delle camicie che i duellanti indossavano nello svolgimento dei loro cruenti scontri al fine di evidenziare quanto prima una perdita ematica da ferita; qualcun altro indica il candore dell’animo dello schermitore ideale; e chi più ne ha più ne metta!
Fatto sta che nelle sale di scherma, allora più che oggi, sembrava di stare in una vera e propria corsia d’ospedale.
Meno male che c’era la possibilità di sfogare tutta la propria fantasia nei colori delle tute, o come qui a Firenze vengono chiamate nei tony.
Beh, si fa così per dire!
Agl’inizi la mia tuta, da indossare sopra la divisa o nelle pause tra un girone e l’altro, sembrava proprio quella di un metalmeccanico, ovviamente con tutto il rispetto del caso: di un blu notturno, con uno scomodissimo zippino al collo lungo meno di dieci centimetri (per facilitare l’ingresso dei celebri testoni!) e felpata in modo tale da sconsigliarne l’uso nelle mezze stagioni (quelle che climaticamente ormai non esistono più), in pratica da usare solo nei mesi di grande freddo siberiano. Pena era una cottura lenta da sauna finlandese.
Era questa l’epoca in cui chi riusciva ad entrare in nazionale aveva la famosa tuta azzurra; per fortuna il nome, che è bellissimo, è restato ancora oggi.
C’era poi una cubitale scritta “Italia”, che spesso ti partiva dalla gola e ti arrivava sino al cavallo, ma non si doveva andare ad una sfilata di moda sportiva, si doveva solo difendere i colori della propria nazione.
Poi qualcuno adocchiò l’affare e, almeno nelle tute, cominciò uno sfarfallio di colori, qualcuno giura di avere visto anche l’indaco, che in pratica, arcobaleno a parte, è un colore introvabile!
Ogni Circolo di scherma si dotò di una propria tuta e, almeno alle gare (in sala la tuta veniva oculatamente risparmiata), trionfò il colore, sia all’appello che durante gl’intervalli tra un turno e l’altro.
Era bello vedere queste chiazze sparpagliate di colore ed era una cosa anche pratica: percepivi subito dove si erano appostati i tuoi compagni di sala o, per contro, era facile ritrovare un amico – nemico se ne conoscevi i colori sociali.
Ricordo anche con soddisfazione che uno dei Circoli dove sono stato iscritto forniva anche asciugamano e accappatoio.
Al di là della sciccheria in sé, devo dire che quest’indumento era l’ideale da indossare tra assalto e assalto: la tuta richiedeva più tempo per essere infilata e sfilata, soprattutto a causa dei pantaloni che il più delle volte erano stretti (veri tubi di stufa alla lord Brummel), mentre l’accappatoio con le mezze maniche era gestibile in pochissimi secondi e ti teneva caldo al punto giusto.
Ma ho fatto un bel salto storico in avanti: per anni, come del resto la maggioranza dei miei compagni di allora, alle gare andavo… senza un bel niente!
Del resto erano tempi in cui a noi ragazzi i cappotti venivano comprati a crescenza, ovvero in modo tale che durassero almeno un paio d’anni. Non eravamo poveri (comunque i veri poveri c’erano anche allora, come oggi: i poveri ci sono sempre), era solo la mentalità del risparmio e dell’oculatezza, che poi, per rigetto e rigurgito culturale, ha fatto accogliere in seguito senza colpo ferire quel mostro distruttivo che è la cultura dell’usa e getta (l’Avaro di Molière evidentemente non ha insegnati nulla a nessuno).
Quindi andando alle gare sopra la divisa ci si metteva o proprio un bel niente che abbiamo appena ricordato poco sopra o un cappottino, se il freddo lo richiedeva
Io era fortunato perché avevo un bel golfone usato da mio zio Piero, che invece di buttarlo via l’aveva regalato a me (forse uno dei primi esempi di riciclo). Grigio antracite (ma che differenza ci sarà con la litantrace?!) con bordi di un bel rosso vivo, apribile sul davanti con un paio di bottoni o forse tre; non aveva la dignità della giacca di una tuta, ma qualcuno me lo invidiava lo stesso.
Comunque era un’ingiustizia bella e buona: sia il maestro che quei signori anziani che sapevo essere i dirigenti della mia società mi ripetevano che prima di tirare per me dovevo tirare soprattutto per difendere i colori del Circolo… ma quale colori del Circolo! Io avevo solo il mio golfino nero usato!
Poi le cose cambiarono alquanto: cominciarono ad arrivare le tute colorate, anche se si dovevano pagare di tasca nostra, come se i succitati colori fossero della propria casata.
Ma il colore tirava e ormai tutti avevano la tuta; l’ebbi anch’io.
La ricordo benissimo, perché la indossavo tantissimo, in casa o dove potevo. Con lei addosso mi sentivo libero dentro e fuori, non so come descrivervelo meglio.
Di cotone un po’ grossolano, color verde scuro, finalmente con una comodissima cerniera lampo sulla giacca che permetteva di aprirla totalmente; unico neo le tasche, così piccole che non c’entrava niente e quello che c’entrava rischiavi di perderlo dopo una decina di passi.
Fortunatamente sin da piccolo mi hanno ripetuto in forma quasi ossessionante il noto proverbio chi si accontenta, gode!
Toccavo il cielo con un dito: ero diventato elegante e soprattutto sentivo cromaticamente di appartenere al gruppo; potenza della tuta!
Già! La tuta, la tuta e la tuta. E la divisa?!
Qui non siamo nel superfluo (leggasi tuta) del buon Tommaso d’Aquino, qui ne va della nostra sicurezza.
La mia prima divisa era di cotone e nemmeno troppo spesso. Sulla giacca in corrispondenza del petto c’erano sì degli strati sovrapposti trapuntati che disegnavano una serie di piccoli rombi regolari, ma la restante superficie era poco più che un velo, quasi un burka.
Tutte le volte che l’indossavo mi sentivo un po’ torero, quello per intenderci che ci mette un’ora a vestirsi (e lo devono anche aiutare!).
I pantaloni avevano una chiusura di sicurezza un po’ buffa: infilate le gambe, dovevo per prima cosa congiungere, serrando un paio di bottoni nei pressi dell’ombelico, due fasce di stoffa che mi cingevano i fianchi; poi dovevo tirare su tutto il davanti (come quando i castelli alzano il loro ponte levatoio) e chiudere altri bottoni alla mia destra e alla mia sinistra.
La giacca aveva invece al suo interno un paio di nastri da unire con un fiocco (per fortuna avevo imparato da poco a fare quelli delle scarpe!) prima di essere chiusa sul lato opposto a quello della guardia da una serie interminabile di bottoni, naturalmente anch’essi bianchi.
Questa era la divisa per i fiorettisti sino a dodici anni; poi, a partire dalla categoria allievi, si sarebbe sovrapposto il cosiddetto giubbetto elettrico, pardon elettrificato.
Invece per gli sciabolatori niente aggiunte tecnologiche, la mise prima descritta restava invece totalmente nature.
Per gli spadisti il discorso era diverso perché la sezione triangolare e più estesa della lama metteva in preventivo stoccate più energiche: la giacca della divisa era fornita di un allungamento che, passando tra le gambe (come una specie di pannolino infilato in modo diverso da quello usato per i neonati), si serrava dietro la schiena, come del resto si usa ancora oggi per tutte e tre le specialità.
Impugnando la spada passai anche dal morbido e soffice cotone alla ruvida tela olona, che mi dissero essere lo stesso tessuto usato per le vele delle barche, almeno quelle dell’epoca, visto che la celebre Luna Rossa avrà senz’altro utilizzato qualcosa di più tecnologico.
Ricordo a questo proposito con scarso affetto uno dei tanti miei maestri, che, essendo io passato dalla sciabola alla spada, mi diceva quotidianamente: ora che sei passato alla tela olona, ti voglio vedere veleggiare e volare in pedana.
Al terzo mese della solita battuta osai sbuffare e mi andò peggio: quel giorno sentii la squallida battuta per ben due volte e beccai anche una frustatine nelle gambe, tanto come corroborante per la formazione della mia personalità.
Il telefono azzurro non lo avevano ancora inventato, ma se ci fosse già stato sarebbe stato intasato da noi schermitori in erba!
Ma torniamo alla tela olona, che forse è meglio: il suo uso aveva anche qualche leggera controindicazione (ma nel materiale schermistico non era previsto, come nelle medicine, il bugiardino). Durante il lavaggio il tessuto tendeva terribilmente a ristringersi e le manovre per infilarmela dopo la pulizia erano simili a quelle che usano certe ragazze per infilarsi blue jeans di due taglie inferiori alla propria: a confronto gl’insaccati sono meno compressi nella pelle e le acciughe sott’olio stanno larghissime nelle loro scatolette!
La natura grezza e grossolana del tessuto procurava per i primi assalti un certo fastidio, facendo le funzioni di un vero e proprio cilicio. Con un po’ di fantasia potevamo essere dei cavalieri cristiani alle Crociate per la liberazione del Santo Sepolcro.
Per fortuna, dopo qualche stoccata la divisa tornava a calzare bene ed effettivamente i colpi più violenti si avvertivano meno.
Eravamo tutti felici e sofferenti quando comparve il lastex, misteriosa fibra che a dispetto della sua conclamata leggerezza e impalpabilità garantiva, a dire della Federazione Internazionale, maggiori garanzie di sicurezza.
Un velo invece di una corazza (potevano scoprirlo prima!)
E fu il lastex.
Quando indossai la mia prima divisa fatta con questo nuovo materiale ricordo benissimo di sentirmi come dire… nudo: una sensazione bellissima che deve essere stata la stessa provata da coloro che dopo l’avvento delle armi da fuoco buttarono alle ortiche le corazze, divenute ormai inutili orpelli.
Nessun peso addosso, massima libertà di movimento soprattutto del braccio armato: un sogno, rispetto a prima.
Ma non è tutto oro quello che luccica, ammonisce il proverbio (e i proverbi sono la saggezza degli schermitori, ancor prima dei popoli): dieci, quindici stoccate e si cominciava a sudare copiosamente più del dovuto.
Il fatto era che il tessuto era totalmente sintetico e garantiva una traspirazione prossima allo zero assoluto (un sacchetto di plastica del supermercato sarebbe stato più permeabile!).
Lo schermitore in pratica cuoceva a fuoco lento, quasi come a bagnomaria.
Si sentiva arrivare sul corpo anche qualche botta più di prima: imparammo a nostre spese che le corazze ingombrano, ma in fin dei conti hanno una loro bella funzione.
Soffri e non accusare il dolore del colpo, faresti la figura di una donnicciola, ci diceva con gli occhi persi nel vuoto un maestro, inseguendo non so quale fantasma mentale; ma lui aveva fatto la guerra 15-18 e noi no! O forse aveva la tessera per un club sado-maso.
Con le femministe che si stavano sempre più organizzando proprio in quegl’anni la morale che stava dietro a quel detto non poteva durare! E non durò!
I tempi sono cambiati, ma i colpi violenti dati e presi sulle pedane caserecce o digara, no.
Pragmaticamente i giovanotti schermitori d’oggi, fregandosene altamente di essere rudi guerrieri, sempre più spesso si dotano di una corazzetta di plastica dura da indossare sul petto sotto la giacca della divisa (ma perché dopo il fuoco e la ruota ci hanno messo così tanto tempo per questa scoperta!).
Invero a quei tempi c’era la famosa (non so quanto) conchiglia: una protezione metallica che aveva la funzione di tutelare la virilità di noi maschietti. Ma era pochissimo usata, soprattutto per pudore, perché configurava sopra la divisa una specie di imbarazzante marsupio (come direbbe il comico Panariello).
A questo proposito mi sia consentita una digressione a luci rosse, magari un po’ affievolite.
Oggi le nostre compagne d’armi indossano un’ampia corazzetta a tutela del loro petto ma prima questa funzione era svolta dalle mitiche coppette; mitiche per noi maschietti che un po’ prima, un po’ dopo i quindici anni pativamo per i primi pruriti sessuali.
In pratica le giubbe delle donne avevano due sacchette, posizionate al posto giusto, dentro le quali venivano immesse due semisfere metalliche. Altro che vergine Camilla virgiliana, che come racconta il Foscolo si fa asportare uno dei seni per combattere meglio!
Nel mondo esterno, soprattutto in quello della moda e dello spettacolo, imperavano in quel tempo le famose donne grissino (mia nonna avrebbe detto secche come un chiodo) come Twiggy, mentre in sala di scherma le nostre compagne per i motivi sopraesposti emulavano le procacissime Sofia Loren o Jane Mansfield.
E noi quindicenni ci grattavamo sempre di più!
Chiusa questa castissima pagina erotica, torniamo alla nostra divisa bianca, che invero vede comparire per la prima volta qualcosa d’insolito: l’etichetta della ditta produttrice.
Naturalmente il marchio è colorato e ben visibile perché deve permettere la verifica della sua omologazione (i famosi newton di oggi). Tanto è che il famoso fisico inglese è oggi più famoso tra gli schermitori più per le divise che per la celebre mela.
Ma ormai il gioco è fatto: l’originale e uniforme candore della divisa da scherma è irrimediabilmente violato e perduto per sempre; tutto questo per un malcelato intento di… pubblicità.
Ma né io, né gli altri ce ne accorgemmo e alla cosa non fu dato alcun peso: eravamo la generazione del Carosello televisivo, eravamo già irrimediabilmente intossicati dalla pubblicità.
Ma quasi scordavo una cosa che ha una sua importanza formativa: con queste divise, dicevo prima, si beccavano anche delle belle sventole. Ma l’insegnamento dei maestri era quello di lasciar correre, almeno nei limiti del possibile.
Non era bello mortificare l’avversario per un colpo che, magari per errore, gli era sfuggito, perdendo per un attimo il portamento dell’arma.
Eh sì! I maestri ci avevano fatto chiaramente intendere che ogni colpo portato con forza rallentava il colpo stesso: ergo, tutte le volte che ci arrivava addosso una mazzata dall’avversario non ci arrabbiavamo, ma eravamo contenti, perché facendo così lui aveva sbagliato.
Perversione del ragionamento!
Poi c’era l’altra versione magistrale, un po’ più responsabilizzante per lo schermitore: l’avversario ti ha fatto male? Bene, la prossima volta preoccupati di parare il suo colpo!
E così facevamo, ma avremmo preferito dirgli: ma sei scemo (in italiano), pirla (in lombardo), scimunito (in siciliano), belinone (in ligure) o bischero (in toscano).
Così ora potete dedurre in quali regioni italiane ho vissuto e tirato di scherma.
In tal modo si forgiavano gli schermitori di un tempo: muti martiri.
A proposito di stoccate prese c’è un aneddoto che vorrei raccontarvi: la statura morale e sportiva del maestro protagonista dell’episodio è fuori discussione e si ricollega al suo carattere guascone, estroverso e simpatico.
Se me lo consentite vorrei per commemorarlo.
Ai miei tempi era un grosso signore dai fluenti capelli bianchi, ancora molto agile per la sua età; portava un’aderente giacca di tuta celestina, parlava sottovoce nella sua lingua straniera ed era in possesso di un italiano pessimo, quello fatto di verbi all’infinito e strafalcioni grammaticali da far venire l’orticaria ad un professore d’italiano.
Seppi solo dopo mesi che prendevo da lui lezione di sciabola che tanti anni prima aveva vinto un titolo olimpico; ma non fu lui a dirmelo e a vantarsene, cominciando a far capire a un giovane come me cosa fosse il valore umano di un vero campione.
Sappiate, come vedremo più avanti nel corso di questo racconto, che negli anni di cui vi narro nella specialità della sciabola non c’era ancora all’epoca la segnalazione automatica delle stoccate e la loro materialità era demandata alla buona vista di quattro assessori e di un presidente di giuria.
Ebbene il maestro, commentando una sciabolata da vero macellaio da cui ero stato appena raggiunto, mi disse di contare sino a tre prima di fare ahi ahi e toccarmi la parte colpita e di aspettare almeno, che gli assessori che dovevano sorvegliare il mio bersaglio ,si fossero già espressi; altrimenti avrei suggerito loro il giudizio ai miei danni.
Perché non ho dubbi sullo spirito guascone (come ho detto poche righe sopra) con cui il messaggio era stato lanciato? Perché lo stesso maestro in più di un’altra occasione c’invitava ad accusare la stoccata valida ricevuta (il famoso touché).
Credi che i tuoi giudici siano ciechi”, ci gridava, non fargli perdere tempo, se sai che hai torto.
Non lo scorderò mai perché, come ho capito solo tanti anni dopo, con lui non imparavo solo a fare scherma, apprendevo anche come fare a cercare di tenere a bada il mio super ego.
Ma, tornando alle candide divise, non crederete mica di essere arrivati alla fine della storia!
Evidentemente no, se oggi vestiamo tutti in pedana un altro tessuto.
Scoppio un’altra rivoluzione: il lastex fu mandato in esilio a Sant’Elena e sul trono si assise il kewlar, l’attuale imperatore; un tessuto capace di resistere alla pressione di 800 newton (sempre lui!).
Leggermente meglio come traspirazione e, avendo una maglia un po’ più spessa, le stoccate pesanti si sopportavano molto meglio.
Rimettemmo quindi mano al portafoglio (poi vogliono far credere che la scherma non è uno sport molto costoso!) ed ci vestimmo di kewlar, ci dicono lo stesso tessuto dei giubbotti antiproiettile della Polizia (esagerati!).
Ma eccola, quasi in concomitanza, la vera rivoluzione, quella cromatica: pantaloni non più bianchi, ma blu – verdi o rossi, strisce sulle maniche e marchi di fabbrica a tutta randa.
I puristi della Crusca a schiumare di rabbia, gli esibizionisti (magari daltonici) a gioire; tutti gli altri, la solita maggior parte come insegna la storia, a fregarsene e a continuare a fare la cosa più importante: tirare di scherma.
El portava i’ scarp del tennis
Jannacci, quel cantautore milanese un po’ strano, cantava appunto questa canzone, che a quei tempi aveva la valenza di un’indagine sociologica: le scarpe da tennis le portavano, come dice la triste storia, solo i barboni.
Noi sportivi per definizione eravamo naturalmente esclusi da questo costume sociale un po’ classista.
Oggi Jannacci non potrebbe scrivere una canzone con questi testi e non solo perché le scarpe da tennis le mettiamo tutti e tutti i giorni, ma anche perché certi prezzi farebbero impallidire un viso già di per sé pallido (potenza incontenibile di una firma famosa).
Ma perché normali scarpe da tennis e non scarpe da scherma?
Ma forse ho capito.
Se mia madre avesse chiesto a quei tempi della scarpe da scherma, il commesso le avrebbe sicuramente risposto: Signora, abbiamo solo scarpe da tennis; mia madre, che è una persona intelligente, non volendo perdere e far perdere tempo, tagliava corto e chiedeva subito: Scarpe da tennis, per favore.
C’erano già le vere scarpe da scherma, ma erano, probabilmente a torto, reputate un optional per lo schermitore.
Si andava al sodo nelle cose: non ricordo bene, ma forse nelle automobili non esistevano nemmeno gli optional, mentre oggi se non monti questi accessori quasi nemmeno riesci ad uscire dalla concessionaria.
E le scarpe da scherma erano sicuramente un optional per 99 schermitori su 100 (o forse anche di più), garantito, vissuto e visto con i miei occhi.
Ecco perché nella mia vita di schermitore ho posseduto solo un fioretto non elettrificato, un fioretto elettrificato francese, una sciabola e quattro spade.
Come abbia potuto fare una decina d’anni di gare con questo scarso arsenale, resta un mistero gaudioso.
C’è comunque da dire che molte Società per le quali tiravo mi prestavano qualche arma, ma erano nella maggior parte dei casi così usate da poter svolgere solo la funzione di estrema riserva.
In verità devo confessarvi che un giorno non ce l’ho più fatta e a mia figlia Carlotta, che è stata per ora l’unica schermitrice di famiglia, gliele (mele) ho finalmente comprate queste benedette scarpe da scherma!
Ma tornando alle amatissime e usatissime scarpe da tennis, devo dire che il loro uso era estremamente flessibile, flessibilissimo: ci si poteva fare di tutto, come andare per funghi nel bosco, andare in barca o usarle semplicemente come ciabatte caserecce
Io talvolta ne facevo l’uso più lessicalmente corretto: giocavo a tennis.
La prima volta che ne feci un uso polivalente, appunto tennis – scherma, accadde un episodio increscioso.
A quei tempi si giocava sulla terra rossa, mentre in genere i pavimenti delle sale erano di tutt’altro colore.
Avete già intuito: un giorno vedo il maestro, faccia a terra, che segue delle orme per terra e arriva dritto fino a me. Se mi dai la racchetta, te la tiro in testa, mi disse; e la mia faccia diventò rossa più della terra su cui avevo giocato.
Fu così che mia madre scoprì che anche le scarpe da tennis si possono lavare in lavatrice.
Ed ora una pubblica confessione, anche se in pratica è un segreto di Pulcinella: mia madre dopo avere acquistato le scarpe da tennis andava subito dal calzolaio.
No! Non avete capito! Non erano scarpe usate da raccomodare; erano scarpe nuove (concedetemi almeno questo!).
Il punto era che il mio modo di produrre l’affondo ancora oggi non è perfetto (alzi l’arma chi riesce a farlo!): il piede dietro, non riuscendo a mantenere la suola attaccata al terreno, leggermente caracolla all’interno e struscia su quell’autentica grattugia che sono sempre state le pedane di scherma.
Dopo circa un mese appariva sulla tela offesa un piccolo forellino, che mano a mano si allargava sempre di più; poi si bucava il calzettone sotto e poi arrivava infine alla mia pelle.
Ecco perché mia madre faceva applicare subito un pezzetto di tosta pelle nella giusta posizione. Questa tecnica non l’aveva inventata mia madre, ma l’aveva mutuata da qualche altra mamma con i figli schermitori più grandi.
Scarpe nuove già con le toppe: roba da pazzi!
Poi, quando avevo martorizzato comunque queste scarpe in sala ed erano giunto il momento di un nuovo acquisto, non le buttavo: le indossavo in casa come ciabatte e nei primi anni della contestazione giovanile ci uscivo coraggiosamente e baldanzosamente anche fuori, ostentando la mia povertà ricca.
In quell’epoca abitavo per l’appunto a Milano: forse avrei dovuto chiedere a Jannacci la partecipazione ai diritti d’autore!
Il corredino
Dopo tutti i sotterfugi che vi ho raccontato circa le scarpe da tennis non vorrei rattristarvi più di troppo con la restante parte del materiale schermistico, cioè con passanti, guanti, maschere e così via.
Oggi è un altro mondo rispetto a prima: in pedana ti devi presentare con doppia arma, doppio passante, doppio di tutto.
In effetti il tempo è denaro e chi lo fa perdere deve pagare una multa, cioè un cartellino (meno male che siamo rimasti nel diritto amministrativo!).
Mi raccomando ancora con voi: non piangete per noi! Non eravamo poi così poveri, eravamo solo un po’ meno attrezzati; non proprio come l’armata Brancaleone, ma giù di lì.
Eppure in un certo modo era bello essere disperati perché il passante di fioretto, che sino ad un istante prima funzionava lapalissianamente in modo perfetto, ora faceva accendere il bianco sulla macchinetta e ad ogni suo scatto (che speravi sempre che tutte le volte smettesse) ti diceva: ma non vedi che sono rotto? Cambiami!
Oppure quando l’avversario da vero pignolo (il presidente di giuria non ci pensava nemmeno) andava a provare il suo fioretto sotto le ascelle o vicino al collo del giubbetto elettrico, dove c’era quel bel colore verderame prodotto dal sano sudore di schermitore: e si accendeva la luce bianca o tutt’e due.
La rottura della lama era per sua natura senza prova d’appello: ho avevi un’arma di scorta nella sacca e andavi trepidante (perché magari era la tua ultima chance) a prenderla oppure cominciavi a cercare affannosamente con lo sguardo qualche tuo compagno che in quell’istante non era impegnato in pedana (anatomico, francese… chi se ne fregava, bastava fosse un fioretto).
Sotto quest’aspetto i mancini, che sono sempre stati una minoranza, hanno sempre sofferto di più (ben gli sta!).
E qui sì che ci sarebbe da piangere, De Coubertin in testa!
In effetti qualche volta il materiale te lo prestava lo stesso avversario, quello che avevi di fronte in pedana o magari quello che avresti affrontato poco dopo nel corso del girone all’italiana.
Talvolta era lo stesso presidente di giuria che come un padre premuroso (o forse per farla finita prima!) perorava la tua causa presso gli altri.
Io ho prestato ed ho avuto in prestito; quegl’istanti non li ho ancora scordati.
Ma ci pensate, la punta di un tuo fioretto che tocca proprio te!
Cose da altro mondo, senz’altro un mondo disordinato, arruffone, un po’ pezzentello, ma che mondo fantastico.
I cartellini multicolori (copioni!) non c’erano ancora. C’erano sì le ammonizioni del presidente di giuria, ma o si faceva finta di niente e si risolveva la questione in casa (vedi prestiti pro tempore sopradescritti), o al massimo ti davano una pena sopportabile, come gli arresti domiciliari tanto di moda oggi. Tanto oggi a te, domani a me o viceversa.
Due cosette prima che riscappino dalla memoria: breve storia dei guanti e breve storia delle maschere.
Il guanto con il quale ho esordito era poco più di un panno o giù di lì: era di un colore giallo acceso ed era talmente morbido che sentivo distintamente addirittura gli angoli retti del ricasso. Inutile dire che al termine anche di un solo assalto avevo le dita alquanto indolenzite.
Vuoi per colpa sua, vuoi come ho già ricordato altrove per il tipo d’impugnatura, il mio dito medio della mano armata (e di tutta la mia generazione) è stato martorizzato e tuttora, dopo tanti anni che si è scordato delle sue sofferenze, è un po’ storto e presenta ancora un lieve e sospetto strato calloso tra la falangina e la falangetta.
Tra vecchi schermitori (sigh!) il mostrarlo è quasi un vanto; come fanno (o meglio facevano) ad Heidelberg gli universitari, ostentando una cicatrice da taglio di sciabola sul proprio volto.
Transitai velocemente dalla similpelle color grigio sporco (probabilmente scelto apposta per non essere mai lavato) e giunsi finalmente al guanto di pekary: era proprio un signor guanto, morbido e resistente allo stesso istante, aveva una guaina elasticizzata che copriva come da regolamento parte dell’avambraccio e, miracolo della scienza e della tecnica contemporanei, un striscia di velcro, che permetteva una velocissima chiusura per tutta la sua longitudine.
Fu un piacevole sollievo non dover più spingere la mano con veemenza per riuscire a forzare la strozzatura nei pressi del polso, come invece si doveva fare in precedenza; stesso tipo di sforzo quando il guanto doveva essere sfilato dalla mano.
Invece d’infilarsi degli stretti stivali era come mettersi ai piedi delle pantofole.
Stessa goduria per il passante, che invece di essere infilato in un forellino laterale del guanto, ora poteva essere serrato dal velcro, vera benedizione del Cielo.
Purtroppo in seguito si ritornò alla stoffa (apparentemente più resistente), alla similpelle o a suoi scadentissimi derivati: questione di costi ci dicevano le case produttrici di materiale schermistico; io invece ho sempre creduto alla longa manus di Brigitte Bardot, che ce l’aveva con l’uso della pelle animale (su questo punto, comunque, sono d’accordissimo).
Per le maschere l’evoluzione è stata, con grande rammarico di Darwin, molto più modesta.
Il ferro o qualche suo derivato dominano tuttora, anche se la mania di fare tutto con la plastica (non bastava quella delle bottiglie d’acqua minerale!) sta conquistando molti consensi.
Così i contendenti si possono guardare negl’occhi (e se uno è timido!), così il pubblico può leggere sui volti degli schermitori le loro emozioni (e se interviene il garante della privacy!)
Mah!
Lo schermitore per natura è un riservato o almeno gli conviene esserlo: dicono che il volto sia lo specchio dell’animo e quindi in uno scontro è decisamente più conveniente celarlo alla vista dell’avversario.
Le emozioni personali sono indiscutibilmente un patrimonio personale e, anche se le fortune di numerosi talk-show si basano sulla loro quasi impudica esibizione pubblica, ognuno avrebbe il diritto di poterle gestire autonomamente.
Un discorso a parte merita la storia della maschera di sciabola.
E’ sempre stato così in quanto una cosa è sopportare una puntata, un’altra è beccarsi una sonora sciabolata (ai miei tempi si diceva in gergo tranvata)
Nei tempi andati a questo proposito c’erano due possibilità, dalle quali potevi tranquillamente dedurre la classe sociale dello schermitore: maschera da ricchi e maschera double – face per meno ricchi (un po’ ricchi si doveva comunque essere, altrimenti non avremmo praticato la scherma).
Nel primo caso, oltre ad appositi rinforzi laterali, campeggiava sulla sommità della maschera una specie di tettino di vero cuoio color marroncino chiaro (l’attrice Brigitte Bardot, che ho già citato, faceva ancora solo l’attrice!). Il celebre cimiero con pennacchio rosso di Alessandro Magno dava sicuramente meno nell’occhio!
Il bersaglio sopra diventava così invitante ed allettante che era quasi impossibile non essere irretito dal suo richiamo: in effetti credo che statisticamente non si sia mai parato tanto di quinta come in quel periodo.
Poi c’era la maschera double – face, quella meno costosa, ideale per: i bi-arma, per gl’indecisi o per quelli che non si potevano permettere due maschere.
Il segreto, vero uovo di Colombo, era incentrato in un cinghiolone lungo quanto il perimetro ovale della maschera: si faceva passare tutto attorno, si serrava con una piccola fibbia ed ecco che si era più protetti dalle sciabolate; almeno così sembrava.
Per di più non c’era il tettino invitante e si poteva anche parare meno di quinta.
Un flash veloce, veloce: c’era anche la gomitiera, squisito vezzo da intenditore, come un foulard annodato al collo o il fazzoletto bianco nel taschino della giacca.
Per evitare i colpi al gomito i più raffinati (per qualcuno i più fifoni, per qualcun’altro di opposta scuola i più previdenti indossavano una protezione di cuoio, una specie di cono fissato al braccio miracolosamente tramite appositi cinghietti.
Per far pendant a questo punto allo sciabolatore perfetto mancava sono un bel paio di mocassini di pelle in tinta!
Tutte le cose di cui abbiamo sin qui disquisito fanno parte, più o meno, dell’attrezzatura necessaria affinché lo schermitore possa scendere sulla pedana in sala o in una competizione, piccola o grande che sia.
Personali, prestate, fregate alle gare, trovate all’ultimo tuffo sono tutte cose indispensabili, irrinunciabili.
Ci dobbiamo ora spingere oltre il puro concetto di necessità ed entrare nel superfluo, come amava teorizzare dottrinalmente Tommaso d’Aquino: parlo della sacca delle armi; ma l’argomento è così ricco e particolare da essere degno di un capitoletto tutto suo.
Un vero optional : la sacca delle armi
Il termine appare subito riduttivo, come se assieme all’acciar dei cavalieri (come dice il Carducci) non fosse invece utile metterci dentro anche una maschera, una divisa, se di caso dei giubbetti elettrici, un guanto, dei passanti, un paio di calzini, almeno un cambio di biancheria, un asciugamano e un accappatoio, bagnoschiuma e shampoo, scarpe, ciabatte, generi di primo conforto come acqua (d’integratori al tempo non ce n’erano), zucchero o glucosio, biscotti o salatini o tutt’e due e… chi più ne ha, più ne metta.
In effetti il giorno che ti fai il primo completino da scherma non ti viene nemmeno in mente di comprare una valigia da scherma: la divisa la indossi, come la maschera ed il resto, l’arma la impugni e pensi di essere quindi a posto.
Ma nei tuoi conti non hai pensato al giorno in cui magari ti dovrai portare tutto dietro per andare ad una gara (lungi ancora da te l’idea di andare a guerreggiare su pedane lontane). O, se magari hai pensato alla sacca, te la dimentichi subito dopo essere svenuto quando ti hanno fatto un primo conto sul solo materiale necessario: divisa, corazzetta, arma…
C’è caro pensare che nemmeno Paperon de’ Paperoni (anche con tutto quel suo nuotare tra i soldi) potrebbe comprarsi subito, così a sangue freddo, anche la sacca delle armi oltre a tutto il resto.
Sacca delle armi! Ma quale sacca delle armi!
Siamo partiti da una cosuccia da nulla, neanche di pelle, e ai giorni nostri siamo arrivati quasi ad un camper!
Ma, come ormai è nostro costume, procediamo con calma che in questo caso di strada ne abbiamo da percorrere
Chi ancora non è stato alla seconda gara logicamente non si è ancora mai posto il problema: dico alla seconda perché in genere alla prima si partecipa, prima e durante, in una specie di trans commotiva.
In genere, a meno di distanze siderali del luogo di gara, ci si presenta già vestiti di tutto punto (ah! Ci sono anche gli spogliatoi!): maschera sotto braccio e arma (almeno) non impugnata, ma tenuta per la lama (il guanto per prudenza l’abbiamo già infilato per essere già pronti).
Poi, in genere dopo le prime sonore sconfitte, cominciamo a prendere coscienza, a riprendere contatto col mondo esterno e, guardandoci attorno, scopriamo l’esistenza di questo meraviglioso e comodo accessorio dello schermitore, la sacca.
Gli altri ce l’hanno, noi no.
La voglio anch’io, decidiamo infantilmente e se c’è lo stand schermistico ce la compriamo, così non pensiamo più alla figuraccia che abbiano appena fatto sulla pedana.
Naturalmente scegliamo la più bella, la più grossa e conseguentemente la più costosa; poi ci mettiamo dentro l’unica spada che possediamo, che quindi ci sciaborda clamorosamente dentro.
Ma abbiamo fatto un balzo temporale troppo repentino e ci siamo persi il più bello; torniamo quindi indietro.
Il mio prima porta oggetti schermistici era un contenitore in voga in quegl’anni, l’antenato degli zaini, che poi hanno preso il sopravvento: abbastanza alto da contenere i due terzi del mio fioretto, veniva serrato alla sommità da una cordicella che, tirata, ne chiudeva l’ingresso a mo’ di cappio.
Beh! Era una sacca delle armi fai da te, ma faceva la sua figura.
Per la strada mi accorgevo che attirava l’attenzione della maggior parte dei passanti e mi gloriavo che capissero che ero uno schermitore; ma quelli vedevano solo un pezzetto di ferro e chissà cosa pensavano (se mai pensavano).
Frequentando l’ambiente mi accorsi che come per le autovetture si poteva spaziare dalla Cinquecento alla Macerati, così anche per nell’ambito delle sacche c’era un minimo e c’era un massimo.
La Cinquecento era costituita da una sacchina piccina, piccina che aveva la possibilità di ospitare al massimo un paio di armi e con un buon gioco d’incastro anche la maschera. Roba da Puffi o giù di lì, ma comunque sempre meglio di nulla.
Con varie cilindrate si arrivava poi all’ammiraglia, la sacca dei sogni: di colore blu intenso aveva le bordature in pelle chiara; un genio della portata di Einstein aveva ben pensato di ricavare due contenitori cernierati esterni, uno verticale appositamente per le scarpe, un altro orizzontale e più capace per ammennicoli vari. Un cernierone laterale spalancava lateralmente tutta la sacca per rimpinzarla sino alla strettoia del suo vertice, mentre un’altra, posta alla base del manufatto, spalancava un contenitore riservato alla parte nobile dell’attrezzatura, fioretti, sciabole e spade.
Una comoda cinghia che, partendo dalla parte bassa arrivava quasi sino alla sommità, consentiva di portare il tutto a tracolla, mentre un maniglione laterale paurosamente sbaricentrato ne consentiva, pur sconsigliandolo, il trasporto in orizzontale.
Chi ha avuto la fortuna di possederne una si ricorderà senz’altro che chi optava per il trasporto a spalla doveva camminare in sintonia con la sua oscillazione impressa dal movimento delle gambe per non subire ad ogni passo una bella botta sul posteriore della coscia del lato sfortunato.
Era il massimo, ma poi qualcuno (intelligentemente) riscoprì la ruota, o meglio importò il comodo sotterfugio nel nostro mondo.
Dalla vecchia forma vagamente piramidale, la sacca delle armi, per ovvi vantaggi di sfruttamento di volume, si tramutò in un parallelepipedo mobile: un maniglione per il trascinamento, mentre due zipponi sulla dorsale superiore e un paio di borsette laterali per le minuterie garantivano una ricettività al limite dell’inverosimile, quasi come le tasche di Eta Beta o la borsa di Mary Poppins. Si vocifera addirittura che qualcuno non sia più riuscito a trovare qualcosa che aveva messo dentro!
Per noi schermitori di una certa età il dubbio è forte: come abbiamo potuto andare alle gare senza questo carretto?!
Comunque c’è anche in corso una reazione di segno decisamente contrario, diciamo pauperista o bohemienne se vi piace di più. Perché siete romantici.
Tutto deve essere nato dal fatto assolutamente fortuito che il figlio di un elettricista si è affacciato al mondo della scherma: come spiegarsi altrimenti l’uso di una canalina di plastica per cavi di corrente come fodero per le armi.
Invero c’è anche la pista del giardiniere, visto che qualcuno, comunque la minoranza, usa anche un pezzo di canna per annaffiare.
Una sbirciatina ad Arnold Schwarzeneger nel film Conan il barbaro e ad Antonio Banderas nel film la maschera di Zorro ed ecco che nasce anche l’arma portata a tracolla: idea fai da te semplice, geniale, di grande effetto coreografico e soprattutto molto risparmiosa.
Formula matematica = radice di sacca delle armi.
In cantina
E’ di dominio pubblico il fatto che le cantine servano a conservare in modo ottimale vino ed olio, oltre a consentire di ammonticchiare cose che prima o poi (o molto probabilmente mai più) potranno essere riutilizzate.
Ebbene ai miei tempi le cantine avevano un altro scopo: quello di ospitare le sale di scherma.
Ovviamente erano pulite, senza ragnatele o scarafaggi di sorta, erano ben areate e ben arredate, ma sempre cantine restavano.
Interrate totalmente o parzialmente erano sottosuoli fuori della portata del sole e della luce diretta.
Eppure all’epoca ero nell’opulento e ricco nord, dove tutto è gigantesco e di più rispetto alle altre parti d’Italia; tutto, tranne le sale di scherma, in cui, anche nei pressi delle Alpi, gli schermitori vivevano come delle talpe, signore talpe, ma sempre talpe.
Sotto quest’aspetto la scherma era a quei tempi uno sport ricco, ma povero: ricco nel senso che certamente non costava poco il praticarlo, povero nel senso che l’ambiente che frequentavi non era certo né esclusivo, né proporzionato alla spesa, né tantomeno conforme alle aspettative.
Ma nessuno si scandalizzava e chiedeva di più: si viveva lo stesso felici, da tartufi.
La fine della guerra e la susseguente ricostruzione non erano così lontani ed il sudore della fronte dei nostri padri (e madri) stava appena allora producendo quasi per tutti qualch’effetto (il famoso boom economico): le prime lavatrici casalinghe, i primi frullatori, la seicento Fiat per tutti (o quasi) e, da lì a poco, persino il secondo canale della TV nazionale.
Ma ogni regola ha la sua eccezione (altrimenti che regola sarebbe!).
Un giorno, da schermitore peregrinus quale sono stato, cambio per l’ennesima volta residenza e mi trasferisco con la mia famiglia in un’altra città.
Mi presento al dovuto numero civico della tal via e chiedo della palestra, perché, così a vista la trovo affatto: è al terzo piano, mi ripose un signore, che risultò essere il custode.
Terzo piano?! Cosa da vertigini, pensai!
Scusi c’è l’ascensore? (ero giovane, ma pigro), domandai; ma l’uomo, pensando di essere preso in giro, non mi rispose nemmeno.
Ebbene sì, ho fatto scherma in una specie di grattacielo (!), dove, ricordo benissimo, che ad una certa ora bisognava tirare giù le serrande perché il sole ci abbagliava, rifrangendosi sulla griglia delle nostre maschere.
Alle gare d’inverno ci chiedevano: ma siete stati a sciare, siete così abbronzati! No, siamo stati in sala a tirare.
Che sensazione! Mi sembrava di essere nel paradiso degli schermitori!
L’attuale benessere mi aveva già fatto scordare che nei primi anni mi cambiavo nei bagni della scuola che ci ospitava: niente pedane per terra, ma sano e scivoloso parquet; niente macchine per le stoccate e rulli, ma sane discussioni per chi aveva toccato e al massimo in già ricordato touché; niente bibite o sollazzi del genere, ma sana acqua bevuta direttamente dal rubinetto.
Di seggiole, sedili, panche o similari non c’era quasi nulla; c’era solo una scomodissima asse di equilibrio, sulla quale le nostre terga si squadravano procurandoci una certa sofferenza; in fin dei conti stavamo meglio in piedi (come del resto faceva anche Cassius Clay tra una ripresa e l’altra).
E le pedane? Già le pedane.
Quando cominciarono ad apparire nelle sale che via via frequentavo ce n’erano solo un paio, forse tre.
Che guerre per accaparrarsele!
I più forti erano ovviamente per la legge del chi vince resta (furbi!), mentre gli altri (forzatamente democratici) erano per la legge dei due assalti consecutivi, poi uno doveva comunque uscire e lasciare il posto agl’altri.
Poi c’erano le ragazze, che all’epoca (più di ora) facevano comunella e volevano tirare solo tra di loro di fioretto.
In fin dei conti, soprattutto in certi giorni e a certe ore, era più il tempo che aspettavi che quello che effettivamente utilizzavi per tirare o fare comunque attività: file lunghe come alle casse dei supermercati nelle ore peggiori.
Poi arrivava talvolta il maestro che diceva: ragazzi domenica Tizio e Caio hanno la gara, lasciate una pedana a loro.
E noi?!
Dopo tutti questi anni ho capito comunque una cosa: la scherma è lo sport delle attese!
Aspetta di poter tirare su una pedana, aspetta che il maestro sia libero per la lezione, aspetta che una doccia sia libera, aspetta il tram per tornare a casa… meno male che il Leopardi ha capito che la gioia sta nell’attesa!
Ma voglio farvi una confidenza: con senno del poi e dopo l’esperienza di tanti club in tanti anni, mai baratterei una piccola sala con un grosso club.
Chi ha avuto la fortuna di andare ad Assisi, entrare nella chiesa di Santa Maria degl’Angeli e vedervi dentro la Porziuncola restaurata con le proprie mani da San Francesco può capire meglio: una cattedrale, grande e splendente, può valere meno di una chiesina che trasuda amore e passione.
Ora non fraintendetemi, non ho detto che piccolo è senz’altro bello e grande è sicuramente brutto; quindi non invito nessuno ad andare ad iscriversi alla scalzi e gnudi di un paesino della Val Brembana, del monte Amiata o della Sila!
Volevo solo sottolineare che oltre le pedane in una sala quello che conta è soprattutto l’atmosfera che si respira in sala e che comunque in tutti i casi ci sono pro e contro.
Il re della sala
Quando entrammo in sala (che poi, se ricordate, non era una vera e propria sala di scherma, ma un enorme palestrone da bowling) capimmo subito di trovarci in un regno simile a quello dei sette re di Roma, che avevamo appena studiato a scuola: era lui solo a comandare, il maestro.
Non aveva nemmeno bisogno di chiedere rispetto ed ubbidienza, ma tutti eseguivano in fretta ogni sua disposizione, lieti di compiacerlo.
Anche gli allievi più grandi di noi sembravano pendere dalle sue labbra: entrava, dava loro precise disposizioni e noi neofiti venivamo inquadrati e suddivisi in diverse attività; lui girava tra i gruppi, correggeva, spiegava, ci mostrava come i vari gesti dovevano essere eseguiti.
Quando passava ad un altro gruppo, finalmente potevamo respirare a pieni polmoni.
Eppure la sua non era una presenza ostile, solo che c’imbarazzava e non poco.
Intendiamoci, non vessava nessuno, non alzava mai la voce più di tanto, ma si vedeva da un chilometro che il capo era lui, un vero re (forse anche imperatore!).
E i re si devono salutare sempre: sia quando entravamo in sala, sia quando uscivamo per tornarcene a casa.
Non era poi una salutino tipo ciao ciao o dammi il cinque, ma una fortissima stretta di mano (quasi una morsa) e molto spesso era accompagnata da frecciatine o qualche rara volta da zuccherini, tipo cavallo: oggi non mi sei piaciuto proprio, a parare mi sembravi uno sbandieratore del palio di Siena, dì a tua madre di preparare per cena le patatine perché sei proprio un bel pollo, non sei rosso eppure devi essere un gambero perché certe volte invece di andare avanti nella preparazione vai indietro e amenità del genere; oppure (apriti cielo), finalmente vedo che dopo cento volte le capisci le cose, bravo; era l’ora che tu capissi cosa volevo da te; io ci ho messo il mio sale grazie a Dio tu stai cominciando a mettere il tuo pepe.
Probabilmente il maestro soffriva d’insonnia e occupava le ore notturne di forzata veglia a coniare queste frasi sarcastiche e pungenti.
Insomma mai una carezza, tutt’a più qualche gioviale ceffoncello.
Ma nella cerimonia dei saluti in entrata e in uscita la cosa più snervante era l’attesa: sappiamo tutti che più una persona è importante più è necessario attenderla… figuriamoci un re!
Con l’esperienza avevo elaborato una mia personale scaletta di situazioni: mai andare a salutarlo mentre stava facendo in pedana una paternale ad un mio compagno (venivo coinvolto e me ne prendevo anch’io da incolpevole la mia buona razione), mai disturbarlo mentre stava parlando con qualche mamma soprattutto se mi rendevo conto che era una bella signora, mai cercarlo mentre era seduto da solo a riprendere fiato perché cominciava a chiederti di come andava con la scuola, con le ragazze e altre intimità inviolabili (non si riusciva a mentirgli ed il terrore era che fosse una spia dei nostri genitori).
La cosa migliore era prenderlo in tempo e il concetto me lo aveva proprio insegnato lui sulla pedana per battere i miei avversari: dovevo beccarlo quando stava finendo un qualcosa e cominciandone un’altra; in questo modo veniva sorpreso e quindi non aveva alcun tempo per organizzare una reazione.
Ma era evidentemente dotato di poteri soprannaturali, perché un giorno mi disse: ti stavo aspettando, bel furbetto, vieni qui a scambiare qualche parolina con me.
E recuperò in un sol colpo tutto quello che ero riuscito via via ad evitare (altro che recupero a fine partita di calcio).
Inoltre il potere del maestro era sconfinato.
Era il promulgatore delle leggi e con Luigi XIV avrebbe potuto tranquillamente dire La salle (l’Etat) c’est moi: oggi non si fa solo lezione (e allora cosa siamo venuti a fare, pensavamo noi); oggi ginnastica (evviva!); oggi le ragazze tirano solo tra loro (ma perché?); oggi assalti controllati davanti a me (e ognuno pensava, accidenti a me a quando sono venuto in sala oggi!); oggi pre – schermistica (dolori garantiti!); oggi gironcino all’italiana tra tutti (grande maestro!).
E questi editti non erano nulla! Ce n’era qualcuno che, probabilmente studiava a tavolino per ore ed ore, ispirandosi a Quinto Fabio Massimo, detto il Cunctator.
Contestare era impossibile e inutile, anzi produceva l’effetto contrario; quindi al massimo avevamo il diritto al mugugno, come in Marina, ma per esperienza era meglio evitare anche questo.
Tuttavia, nonostante tutte queste sostanziali torture, avevamo la massima fiducia in lui e sapevamo in cuor nostro che tutte le sofferenze (o presunte tali) cui ci sottometteva, avevano lo scopo di costruirci sia come schermitori, sia come uomini.
A molti (quasi tutti, me compreso) di questo non gliene importava all’epoca assolutamente niente; ma certe cose non si possono capire atro che dopo (molto dopo!), quando sei cresciuto e vivi la tua vita.
Per questo sono sicuro che molti di noi non abbiano ringraziato a sufficienza i propri maestri per quanto ci hanno dato. Forse non in tutti i casi, ma diciamo nel 99,99 per cento degli stessi.
Stavo dimenticando un altro concetto della massima importanza: il maestro godeva di uno status extra legem, cioè al di fuori della legge (l’immunità parlamentare i politici devono averla scimmiottata dalle sale di scherma).
Volete un esempio?
Eccovi serviti!
Questo mio maestro fumava e anche se in quei tempi non c’erano leggi e leggine che vietassero il fumo in pubblico, pareva acquisito il fatto che almeno in una sala di scherma non lo si dovesse fare.
Invece lui non solo fumava tranquillamente, ma lo faceva anche mentre stava impartendo la lezione; avete capito bene, dando lezione!
La situazione surreale era pressappoco questa: interruzioni frequenti delle frasi schermistiche per precisazioni che anche ad un principiante sarebbero apparse come banali scuse per tirare un paio di boccate – fumo che usciva dalla maschera quando se la calava e… nebbia il Val padana.
Per di più questo maestro ripeteva in continuazione: tira la botta dritta quando vedi il bianco dei miei occhi.
Un giorno con inaspettato coraggio chiesi: maestro, ma come faccio a vedere il bianco degli occhi, se lei ha la maschera e con tutto questo fumo?
Risposta secca: Questo è un dettaglio, vedi di risolverlo tu; comunque di fumo io non ne vedo.
Anche questo maestro non è più sulla nostra Terra; era un po’ burbero, ma non gli ho mai visto fare un torto a nessuno.
Chissà se ora farà lezione all’arcangelo Gabriele, che, come si desumedoalle immaginette di chiesa, ha la spada più bella del Paradiso; ma quello che veramente spero di tutto cuore è che dov’è ora non manchino i tabaccai.
I maestri in genere oltre il potere legislativo detenevano anche quello esecutivo: tu oggi tiri di fioretto e non di spada (ma perché?); se ti vedo parare ancora di quarta non ti do la stoccata (accidentaccio, ma in pedana ci sale lui od io?!); andate a fare gli esercizi su quella pedana finché non cascate per terra (No! Per favore, gli esercizi no!); ora tu sali in pedana e fai solo azioni di filo, capito?! (Odio il filo con tutte mie forze!).
Il potere giudiziario lo esercitava in modo NON illuminato (altro che Salomone): il solo resistergli in giudizio, già gli procurava fastidio; l’appello era sempre giudicato inammissibile, per forma o per sostanza poco c’importa; la sentenza, appena pronunciata, passava direttamente in giudicato e… chi si è visto, si è visto!
La famosa contestazione? …roba da Marte o Saturno! Il famoso ’68 c’era nelle scuole e per le strade, non nelle sale di scherma.
Il controllo di Polizia anch’esso era nelle sue mani: altro che ronde della Militar Police! Altro che informatori e spie (FBI o KGB, a seconda dei gusti politi dell’epoca), Altro che manganello, lui era… armato (la sciabola per la sua nota flessibilità era la più usata).
Ricordo come fosse ora una paio di staffilate sulle mie gambe (scrivendo, risento proustianamente quasi il noto bruciorino) e alle mie più che legittime proteste verbali mi sono sentito rispondere burlescamente: tanto non è bersaglio valido!
Aspettate un momento: riaffiora dalle nebbie della mia memoria un episodio, come faccio a non raccontarvelo.
In quegl’anni mi trovavo in un club un po’ particolare: accanto alle pedane c’era un tavolo da ping pong, un calcio balilla e addirittura un flipper, sì un flipper, il gioco più elettronico che ci fosse in giro.
Sembrava più di essere in una Luna Park che in una sala di scherma!
Domanda retorica: un ragazzo preferisce fare scherma o intrattenersi con gli unici tre giochi che sino a quegl’anni la Società civile e le parrocchie avevano partorito per i giovani?!
Per giunta erano gratis e mi trovavo a… Genova!
Preferisce giocare gratis; risposta esatta!
Ebbene il maestro (e col famoso senno del poi, faceva anche bene) era di avviso contrario e molto civilmente ci spiegò il suo punto di vista.
Si presentò sulla porta della saletta con una sciabola in mano (ahi, ahi!) e senza proferir parola si mise ad inseguirci attorno al tavolo da ping pong.
Un nostro compagno, il più lento (lo era anche sulla pedana), fu raggiunto dalla sibilante lama ed ebbe una reazione verbale spontanea: Maestro, ma è scemo!
Chiudemmo gli occhi…
Ma torniamo alle istituzioni schermistiche: in quei tempi un maestro non poteva fare il presidente della sala dove lavorava;…ma cosa gliene importava, lui era il re!
Se poi le dimensioni della Sala per numero d’iscritti supera una certa soglia non c’era più un solo re, ma due ed era diarchia, alla foggia di quella vigente a Sparta.
Ci sono sale in cui si giunge al triumvirato (come i due celebri della storia di Roma) o addirittura al quadrunvirato.
Ma ora, sempre parlando dell’assetto politico delle sale di scherma, vi debbo raccontare un’altra cosa importante nell’evoluzione dell’establishement delle sale di scherma, qualcosa paragonabile alla scoperta dell’agricoltura e dell’allevamento del bestiame, che come ben ricordate traghettò l’umanità dal paleolitico al neolitico.
Un bel giorno il re si vede spuntare in sala un altro personaggio, il preparatore atletico.
A parte le persone intelligenti che hanno subito capito che nell’interesse degli allievi più si va nello specifico e più è necessario che ognuno svolga le proprie peculiari mansioni, le parole furono pressappoco queste: maestro = ma chi è questo che non sa nulla di scherma e viene romp….; preparatore atletico = ti faccio vedere come si fa, tutto quello che fai fare ai ragazzi è tutto sbagliato, è tutto da rifare (riecco Bartali!).
Ci sono voluti anni perché queste reciproche stime mutassero i propri contenuti e si giungesse ad una fattiva collaborazione, anche se credo, almeno per quel che so, che ancora manchi un vero e proprio raccordo tra le due dimensioni di lavoro.
Che ci piaccia o no, il futuro è rappresentato dalle specializzazione., nella scherma e in tutte le attività umane. Sono lontani i tempi dei Montesquieu, dei Diderot e dei D’Alambert, che giocavano a fare gl’enciclopedisti.
Questo ovviamente è capitato (e capita tuttora) nelle sale più grosse; invece in quelle più piccole, quelle di più limitati mezzi, è ancora il maestro che gioca in doppio ruolo e a lui tutta la gloria e la fatica.
Il re incontrastato è ancora lui.
L’allenamento in sala
Vive la liberté mi suggerisce il titolo del capitoletto da svolgere. Ma devo subito precisare che non sempre la libertà fa approdare ai lidi migliori.
Cosa intendo dire?
Presto detto (scritto!): parlo della cosiddetta preparazione atletica in genere.
Nel decennio in esame solo un paio della decina di club che ho frequentato curavano oltre che l’aspetto tecnico anche quello fisico degli atleti.
Eppure da duemila anni o poco meno risuonava nei timpani il paritario detto: mens sana in corpore sano!
Troppo di difficile comprendonio per qualcuno che, leader dei conservatori, credeva solo nella lezione e nella lezione e nella lezione e per finire… nella lezione!
Come potevamo capirlo da soli alla nostra età, quando si andava in sala solo per divertirsi (leggasi tirare d’assalto).
L’unica meta esistente a quell’epoca era vincere una gara (la più importante possibile), prendere una coppa ed una medaglia (il più delle volte o questa o quella) e… arrivederci e grazie; alla prossima.
In effetti una delle punizioni disciplinari più severe temute all’epoca da noi schermitori era quella sentenziata, senza possibilità d’appello, dal maestro: per una settimana non tiri più. Devi fare solo… lezione.
Miracolosamente ci soccorreva un compito in classe di latino o di matematica o un fugace mal di gola e così potevamo scontare la pena agl’arresti domiciliari, non andando in sala. Ma di solito, avendo il maestro una memoria formidabile (alla Pico della Mirandola, tanto per intendersi), con tale comportamento non si otteneva nulla in quanto la pena slittava semplicemente nel tempo.
Per controbattere la nostra naturale pigrizia giovanile bastava farci capire (in verità come ogni giovane eravamo un po’ poco disponibili) l’utilità della ginnastica, termine più in voga all’epoca, quando ancora non era sopraggiunto il vezzo di ribattezzare con nomi più roboanti (preparazione atletica o termini anglosassoni come circuit training e similari) la stessa identica cosa: fatica, molta noia, sudore e doloretti muscolari vari per alcuni giorni (la cosiddetta attività defaticante, se mai esiste, è un’invenzione abbastanza recente).
Ma onestamente, vista l’età media più che rimarchevole, era chiedere un po’ troppo alla classe magistrale e dirigenziale di quel decennio.
Poi, come nelle migliori rivoluzioni, accadde tutto e subito
Quindi in genere la vita di sala era questa: arrivavi, ti cambiavi subito per tirare, montavi sulla pedana e ci restavi per quanto più potevi, sperando che la maschera ti garantisse nei confronti del maestro un certo anonimato.
A questo proposito vorrei raccontarvi un piccolo aneddoto: avevamo appena quindici anni, ma, rotti all’esperienza, avevamo già capito il meccanismo.
Tu, vieni a fare lezione diceva il maestro, appena aveva finito di torturare un altro tuo compagno.
Bene!
La sala che frequentavo aveva numerose colonne, non tante come la sala ipostila di Menfi fatta erigere da Ramsete il Grande, ma comunque abbastanza ricca d’ingombranti strutture.
Quindi tiravamo, ma con la coda dell’occhio monitorizzavamo la lezione del maestro.
Appena percepivamo dal saluto con l’arma che stava per finire, balzavamo dietro alla più vicina colonna e con molta non chalance ritornavamo sulla pedana appena un altro malcapitato era stato pescato: vieni tu!
La cosa andò avanti per un bel pezzo, ma poi un giorno, quando sghignazzanti c’eravamo appena eclissati, una voce ci fece trasalire.
E voi cosa ci fate dietro le colonne!
Era l’altro maestro, neoassunto da pochi giorni, che era appena uscito dal suo spogliatoio.
Bomba libera tutti, disse un mio compagno più coraggioso per smorzare l’atmosfera che si era creata.
La lezione di quella sera per noi durò un’eternità e di affondi ne avremo fatti almeno un milione (altro che piegamenti sulle braccia dei marines americani!).
Il dilemma della preparazione dello schermitore sta, a mio parere, tutto qui: sin dalla più tenera età si deve far comprendere che lo scontro sulla pedana è totale, è globale.
Tutto (almeno tutto ciò che è lecito) serve per giungere alla vittoria; che poi sia quella di un campionato del mondo, di un campionato nazionale o sociale, poco importa: oltre che di carismi si tratta anche di scelte consapevoli, ovvero di libertà e di cultura insieme.
Chi ha tenuto in mano un’arma bianca sa che prima dell’avversario deve battere se stesso e per farlo servono una ben dosata autostima e un’adeguata preparazione grandangolare, cioè tecnica, fisica, tattica, strategica, eccetera, eccetera.
Questo è il suggerimento e la chiarificazione che vanno subito sussurrati all’orecchio di ogni neofita: poi a lui la scelta, è lui che si deve dimensionare e dare dei traguardi. Gli ordini che dai a te stesso possono essere più severi ed autorevoli rispetto a quelli che ti arrivano dagl’altri.
Da giovani, in genere e per fortuna, si sprizza energia da ogni poro delle pelle e queste attività collaterali non sono da sottovalutare: ampliamento della resistenza alla fatica, affinamento della coordinazione motoria, potenziamento muscolare, gestione della forza esplosiva tanto utile alla nostra disciplina.
Eppure qualcosa di embrionale di tutto questo c’era anche in quelle sale dove, diciamo una volta ogni morte di papa, veniva rispolverata la pre–schermistica a mo’ di ginnastica.
Termine odioso, vagamente oscuro e per taluni addirittura maligno, che veniva evocato dal maestro improvvisamente senza alcuna programmazione, così dal nulla, ad una certa ora di un imprecisato giorno.
Probabilmente l’evento era legato a fattori imponderabili come ad esempio un piatto più leggero consumato dal maestro a tavola, una temporanea diminuzione dei suoi dolori (caratteristici dell’età avanzata), dalla presenza di qualche mamma un po’ più carina delle altre su cui poter far colpo o altre balzane idee degne della più impenetrabile cabala babilonese.
Tutti in guardia, rigorosamente senza arma, a fare il gioco delle belle statuine: passo avanti, passo indietro, affondo; vai di qua, vai di là con lunghe sequenze degne, a seconda dei gusti, dell’indimenticabile ballerino russo Nureyev o del più popolare Fred Astaire.
Che bello!
Belle statuine all’inizio, ma quando l’acido lattico veniva munto fresco fresco dai nostri muscoli cominciavano i guai, che non erano tanto quelli che pativi sul momento (fatica, sudore e similari), ma quelli che avvertivi quando tornavi a casa e soprattutto il giorno dopo: ti sembrava di avere attaccata alle gambe un’intera muta di cani, magari quelli della più esclusiva caccia alla volpe in terra inglese.
Saluti alla Regina!
Più davi segno di essere stato massacrato e di essere fisicamente a pezzi, più chi aveva condotto le danze (sicuramente si era ispirato alla celebre morte del cigno!) era sicuro di averti fatto un bene.
Eppure dall’esterno (sottolineo dall’esterno) doveva essere bello vedere questa massa di giovani vestiti di bianco muoversi alacremente e all’unisono su comandi brevi e concisi.
C’erano poi i maestri d’origine circense.
Quello fissato nel lancio dei cerchietti, che dovevi infilzare al centro con la tua punta, magari dalla guardia di sciabola! Un giochetto tranquillo e bellino che ti faceva fare delle figure da bischero, come si dice qui a Firenze.
Quello che aveva attaccato con un filo al soffitto una pallina da tennis, che dovevi colpire al volo calcolando il periodo di oscillazione.
Un giorno un mio compagno disse: maestro, lo abbiamo fatto a scuola, questo è il pendolo delle oscillazioni isocrone di Galileo!
Zitto e colpisci, rispose il maestro, che evidentemente non aveva fatto Fisica a scuola.
Un giorno un mio compagno portò ironicamente in sala una racchetta da tennis; ma preferisco non darvi i particolari della reazione magistrale. D’altra parte non siamo anglosassoni ed il nostro tasso di capacità di apprezzare l’humor non è scarso, ma praticamente inesistente.
Ancora: quello che lanciava guanti da prendere al volo in frecciata. Fate come gli uccelli; volate, disse il maestro. Dal nostro gruppo si senti chiaro un cip – cip.
Risultato, un’ora abbondante di pre–schermistica da appello alla Croce Rossa Internazionale e in sala di uccellini non ci fu mai più traccia.
Quello maniaco del salto della corda.
Le nostre compagne, naturalmente, ci umiliavano; indubbiamente a vederci saltare venivano in genere le lacrime agl’occhi, mentre al maestro veniva il voltastomaco.
Scene degne di Oggi le comiche.
C’è gente che, vergognandosi, si esercitata prima di andare a dormire e la mattina presto prima di andare a scuola; altro che la nuotatrice Novella Calligaris, che nuotava all’alba per ore come dicevano i giornali.
Quello pazzo per le capriole.
Ma maestro in pedana le capriole non si possono fare, osservò argutamente e coraggiosamente qualcuno.
Non ti preoccupare, rispose, a me le capriole piacciono.
Ermetico peggio di Ungaretti!
Quello che aveva giocato troppo poco da piccolo e ci faceva fare per ore, a quindici anni suonati, il gioco della bandierina.
Unica consolazione avere una compagna di sala carina da acchiappare, cosa comunque molto rara a quei tempi.
Quello che s’incaponiva ad inventare giochetti a suo dire simpatici, ma che in realtà erano talmente cervellotici da divenire talvolta incomprensibili anche a lui che li aveva ideati.
Beh per oggi può bastare così, si affrettava a dire quando nessuno ci capiva più nulla.
Quindi in sintesi una preparazione atletica molto da bricolage, non c’è che dire; ma a difesa della classe magistrale c’è indubbiamente da osservare che, tranne pochissimi casi di maestri – professori di educazione fisica, tutti gli altri non ne sapevano assolutamente nulla, dico proprio assolutamente nulla.
Siate quindi felici, o giovani schermitori: oggi tutto è più scientifico, pianificato e mirato… almeno si spera!
Cuccatevi la ginnastica (tanto di questo si tratta) e fortificate il vostro fisico ed il vostro spirito.
Lo specchio
Che tra gli schermitori ci sia un alto tasso di vanità è cosa ormai appurata: d’altra parte lo richiede la stessa necessità di esibirsi su una pedana sotto gli occhi di tutti, esposti ad ogni genere di giudizio. E se magari qualcuno si distrae momentaneamente, alla fine di ogni stoccata vincente, emettiamo un urletto più o meno intenso per richiamare la sua attenzione e farci notare.
Questa malcelata pulsione narcisista portava ai miei tempi ad istallare in sala uno o più specchi, di quelli grandi, immensi, da sartoria di alta moda.
Intendiamoci nessuno di noi ne faceva un uso normale, diciamo quotidiano: le ragazze non ne approfittavano per riassettarsi i capelli o i ragazzi per vedere se avevano qualche brufoletto sparso qua e là.
Davanti allo specchio ci si metteva in guardia!
Ma come?! Da soli in guardia davanti allo specchio?!
Proprio così.
Ma perché?
Perché anni prima un maestro in una qualche sala aveva pronunciato una delle frasi più vere e taglienti che mai mente umana abbia partorito nella storia del suo pensiero: lo specchio sono gli occhi dell’avversario.
Elementare: mentre a quelli nostri, soprattutto a quelli di un vanesio o di un superficiale, tutto sembra a posto, agl’occhi degli altri nulla sfugge e magari riescono nell’impresa apparentemente impossibile di trovare il famoso pelo nell’uovo!
Ti credevi messo bene in guardia e invece guardati lì: sedere in fuori e ginocchia storte; in affondo, ancora peggio; andavi in quarta o in terza e ci mancava poco che il braccio armato battesse contro le pareti della sala!
E allora, ogni giorno, intendiamoci per non più di cinque minuti, ognuno interrogava lo specchio: specchio, specchio delle mie brame chi è lo schermitore più bello del reame?
E ci autocorregevamo, alla stregua del controllo ortografico di cui gode la videoscrittura che sto utilizzando per scrivervi la mia storia.
Tutto questo non tanto per rincorrere la perfezione stilistica, ma soprattutto per risparmiarci le solite paternali dei nostri maestri: ma guarda come stai in guardia, sembri un quadro astratto! – riesci a tenere il braccio un po’ più su o ti ci vuole una gru! – se fai un affondo così rischi di far morire di risate il tuo avversario!
Lo specchio era solo un rito, una specie di consuetudine collettiva; almeno sino a quando un maestro mi svelò il suo segreto (da giovincello qual’ero sino allora mi pareva tale): lo specchio, Stefano, ti permette di controllare da solo, senza l’aiuto di nessuno, se rispetti i principi delle posizioni.
Fu un pomeriggio importante per me, perché capii che le posture che lo schermitore deve assumere nelle varie contingenze non sono ispirate a canoni puramente estetici, ma, attraverso essi, a norme di carattere essenzialmente pragmatico.
Così dietro l’eleganza di una guardia c’è l’ottimale distribuzione degli equilibri delle singole parti corporee; così dietro un’idonea postura del braccio armato c’è la migliore geometria per sviluppare un’azione d’attacco o di difesa; così dietro un armonioso spostamento sulla pedana c’è tutto il segreto della misura schermistica.
Da quel giorno non vidi più nello specchio della sala un’ordinaria e generica suppellettile, utile solo a rituali scaramantici; vidi piuttosto un prezioso strumento per la costruzione ed il controllo del mio sistema-schermitore, vidi un amico sincero di cui potevo fidarmi ed accettare qualsiasi critica.
Ora, più consapevolmente, potevo ripetere la solita frase: specchio, specchio delle mie brame sono o non sono lo schermitore più bello del reame?
Il bersaglio
Oltre lo specchio ogni sala di scherma che si rispettasse aveva il suo buon bersaglio appeso al muro.
Direte voi giovani: ma come un bersaglio! Non siamo mica degl’arcieri! Per giunta le nostre armi, in specie quelle con il manico francese, per Regolamento non si possono nemmeno lanciare.
Calma! Molto semplice!
Si tratta di un bersaglio sul quale indirizzare i nostri colpi, siano essi di linea, di affondo o di passo avanti affondo. No, la frecciata no! Altrimenti ci si spiattella contro il muro a cui è appunto appeso il bersaglio.
Invero, pensandoci bene, attaccandolo al soffitto sarebbe stato possibile fare anche la frecciata; insomma tipo giostra del saracino fatta non a cavallo, ma a piedi.
Strano che nessuno ci abbia mai pensato!
Dunque il bersaglio era attaccato al muro; doveva essere di un cuoio durissimo perché a occhio e croce le stoccate che aveva ricevuto dovevano essere qualche milione, ma lui non si era scomposto più di tanto.
Un giorno il maestro mi porto davanti a lui e me lo presentò: ecco il bersaglio, Stefano, tiragli addosso quante botte vuoi.
Fosse dipeso da me non ne avrei tirata neanche una! Io venivo in sala per stare con i miei compagni, mica per fare compagnia ad un aggeggio sul muro.
Questi ovviamente erano solo i miei reconditi pensieri; mi misi subito all’opera con una serie di affondi ed il maestro mi disse: bravo.
Si giro per tornare sulla pedana da lezione ed io diradai i colpi: ero di animo gentile e non volevo infierire su quel coso!
Come solitario avrei preferito farne uno con le carte da gioco.
Eppure colpo su colpo percepivo, in tutta la solitudine in cui ero sprofondato, una strana sensazione sulla mano.
La superficie estremamente rigida del cuoio rimandava al mittente, come un boomerang, la forza da me usata per vibrare il colpo e mi obbligava ad aumentare la presa sul manico per poter continuare a governare bene l’intera arma.
Che sia appunto questo uno dei casi in cui è necessario cambiare la forza della mano? Dissi, fra me e me.
Era uno di questi casi.
Avevo scoperto, in solitaria, una delle cose più importanti nel maneggio delle armi: la stretta in tempo.
Grazie, vecchio bersaglio.
Quando le stoccate erano a vista
Lo schermitore d’oggi (sfruttando i migliori ritrovati della scienza e della tecnica) non ha alcun problema circa la segnalazione delle stoccate che tira (la famosa materialità del colpo), o meglio non li ha se la sua attrezzatura è efficiente.
Ma, ovviamente non è sempre stato così: più si va indietro negli anni e più si doveva ricorrere agli uomini e non alle macchine.
A questo proposito vi siete mai chiesti come mai nelle nostre competizioni l’arbitro è chiamato presidente di giuria?
Ma quale giuria se è più solo di un lupo solitario!
Ebbene, se non lo sapete già, ora lo capirete.
Nel decennio di cui sto narrando, grosso modo le vicende della segnalazione automatica delle stoccate riguardavano la spada in toto ed il fioretto a partire dalla categoria allievi compresa.
In altre parole la spada era in pratica tel quelle ad oggi, mentre nel fioretto c’erano già giubbetto elettrificato e passante, ma la cosa non riguardava gli schermitori in erba.
Questioni tecniche, questioni economiche o questioni tradizionali che fossero, questi ultimi dovevano aspettare l’età giusta, come fanno i giovani d’oggi per prendere il patentino per il motorino o, successivamente, per la macchina.
Ma quindi per questi mini-fiorettisti e per gli sciabolatori tutti come si faceva a giudicare le stoccate?
Eccoci alle giurie, di cui il presidente ne era il coordinatore.
Immaginatevi una pedana sulla quale stanno di fronte due schermitori: due giurati, detti anche assessori, stavano da una parte e due dall’altra alle loro spalle (due al di là della pedana e due al di qua), mentre il presidente stava da un lato, al centro di questo immaginario parallelepipedo che conteneva fisicamente i due contendenti.
Le rispettive posizioni, che erano dinamiche ovvero si spostavano in sintonia con lo spostamento dei due schermitori in pedana, consentivano: al presidente di giuria di avere una visione dalla postazione centrale dello svolgimento dell’azione; mentre a ciascuna coppia di giurati di sorvegliare i bersagli del contendente, che si trovava loro di fronte, uno per i suoi bersagli interni (petto e ventre) ed uno per quelli esterni (spalla e fianco).
Ecco un bel disegnino per capire ancora meglio:

In esso figurano anche altri personaggi, che oggi (come purtroppo capita spesso di questi tempi) hanno perso il loro posto di lavoro grazie all’evoluzione della tecnologia.
Sono il cartellonista, l’addetto alla macchina segnalatrice e il cronometrista.
Andiamo a conoscerli.
Il primo, come suggerisce direttamente la sua denominazione, era incaricato di trasferire l’esito degli assalti del girone all’italiana su un grosso tabellone pieno di chiodini o comunque di caselline posto nelle vicinanze della pedana.
Una V, di colore rosso, era auspicabile in quanto indicava una propria vittoria, mentre una S, oppure una D di colore nero, era da evitare il più possibile in quanto testimoniava una propria sconfitta.
L’arcano D sta per defaut, che in lingua francese, quella ufficiale per la nostra disciplina, vuole dire sconfitta.
Una volta tanto: anglofobi 0, resto del mondo 1!
L’addetto alla macchina segnalatrice, presente solo nelle competizioni più importanti, aveva un compito semplice, ma fondamentale: dopo ogni stoccata doveva azzerare il colpo e riarmarla.
Il cronometrista teneva ovviamente il tempo e faceva in pratica l’orologio del presidente.
I componenti della giuria, come già ricordato poco sopra, avevano compiti differenziati.
Al presidente spettava (come oggi) la conduzione generale dell’assalto: l’a-voi e l’alt, la ricostruzione delle azioni nelle armi convenzionali, la gestione delle sanzioni, l’attribuzione della stoccata. Inoltre aveva anche il compito di vigilare sulla materialità delle stoccate, cioè constatare se una stoccata colpiva e dove colpiva. Insomma era un tuttofare carico d’impegni.
I giurati invece erano svolgevano il ruolo solo di sensori: in pratica al posto delle lucine colorate e bianche della macchina segnalatrice dei colpi c’erano i loro otto occhi puntati, chi di qua e chi di là, chi sul davanti, chi sul dietro.
Presupponendo sempre la buona fede (!), capirete che comunque gli errori erano all’ordine del giorno.
Prudentemente già duemila anni fa, mettendo le mani avanti, dicevano errare humanum est. Erano anche così arguti che introdussero il noto correttivo concettuale sed perseverare diabolicum (alla faccia di chi voleva fare il furbo, trincerandosi dietro l’imperfezione umana).
L’animus dei contendenti e soprattutto degli accompagnatori non teneva quindi in nessun conto i limiti percettivi umani e il più delle volte ognuno, a turno, credeva di essere vituperata vittima dei più spregiudicati brogli (altro che quelli perpetrati nei seggi delle elezioni politiche).
Come negli stadi di calcio, dove il tifoso ha la mente offuscata ed una capacità pressoché inesistente di percepire in una dimensione oggettiva i reali accadimenti: se un difensore avversario solleticasse il centravanti della sua squadra con una piuma, giurerebbe su sua madre di avergli visto in mano una mazza da baseball; mazza da baseball che miracolosamente ridiventa una piuma se è invece un difensore della sua squadra che interviene, massacrandolo, su un attaccante avversario.
I famosi fischi per fiaschi! Con la relativa perdita di ogni minima dignità intellettuale.
Appare invece più che legittimo richiamare premurosamente l’attenzione del presidente di giuria, cercando di esercitare, molto interessatamente, tutto il proprio ascendente per influenzare nelle armi convenzionali la sua interpretazione soprattutto circa la priorità dell’attacco.
Da qui sceneggiate degne del miglior Mario Merola: quasi dopo ogni stoccata portata a segno da entrambi gli schermitori si girano verso di lui e con vari atteggiamenti corporei (chi con pugno serrato, chi con armi alzate, chi piegandosi sulle ginocchia, chi avvicinandosi…) producono urla selvagge degne delle più dotate tra le scimmie urlatrici della celebre rocca di Gibilterra.
Lo schermitore ha sempre urlato: ai miei tempi cercavamo invano di emulare Claudio Villa o Massimo Ranieri a seconda dei gusti; oggi c’è molto più da sbizzarrirsi con i metallari, i rockettari, i rap e chi più ne ha, più ne metta.
Il decibel, l’unità di misura dell’intensità del suono credo sia stata fissata per le urla degli schermitori!
E per la mimica? Merola, citato poche righe sopra, è un dilettante allo sbaraglio! I paragoni con fiorettisti e sciabolatori si fanno a partire da Marlon Brando e Paul Newman, che hanno frequentato a New York sulla 44 strada l’Actor’s Studios.
Forse esagero un po’, ma poi mica tanto, vero?!
Fossi un presidente di giuria, assegnerei la stoccata a chi è più silenzioso!
Quanta tensione nervosa si accumuli, lo so io e lo sanno tutti coloro che hanno calcato a qualsiasi titolo una pedana di scherma, ma qui c’è il pericolo della sordità permanente!
Ma come si svolgeva materialmente la procedura per l’assegnazione della singola stoccata?
Non è impresa facile, comunque mi cimenterò con questo meccanismo invero un po’ farraginoso (siamo sul livello della teoria della Relatività, quella semplice per fortuna).
Dopo l’a – voi del presidente di giuria, quest’ultimo dava l’alt (insieme naturalmente a tutte le altre situazioni) quando presupponeva che durante lo svolgimento di un’azione almeno uno dei due contendenti avesse toccato una parte del corpo dell’altro, bersaglio valido o non valido che fosse; l’assessore, se vedeva un colpo, poteva solo alzare la mano e quindi era solo e comunque il presidente che poteva interrompere l’azione per la successiva verifica corale.
Una volta dato l’alt, quest’ultimo procedeva a ricostruire l’azione: “l’attacco parte da qui… sull’attacco c’è un tempo… c’è una parata….c’è una controparata…”
Fatto questo passava a raccogliere il giudizio dei singoli giurati, il cui singolo valore era di un’unità, mentre il valore del presidente di giuria era di un’unità e mezzo (primus non inter pares, avrebbero chiosato i nostri padri latini).
Le risposte che poteva dare il giurato erano: tocca, non tocca, tocca ma in bersaglio non valido, mi astengo (quando non era riuscito a seguire il colpo e quindi non poteva avere un’opinione fondata sull’accaduto).
Ed ora mescoliamo un po’ le carte e facciamo alcuni esempi per capire meglio la procedura di giudizio nella pratica, presupponendo sempre che il presidente di giuria abbia già fornito la ricostruzione dell’azione.
Primo caso.
Cosa fa l’attacco? Entrambi i giurati dicono tocca = un punto a testa fa due punti, per cui il giudizio del presidente, che, lo ricordiamo ancora, vale un punto e mezzo, è ininfluente. Quindi la stoccata è assegnata a chi ha sviluppato l’attacco.
Secondo caso.
Cosa fa l’attacco? Entrambi i giurati dicono non tocca = idem come sopra, il presidente non influisce sul giudizio finale; quindi l’attacco non tocca e si passa di conseguenza a consultare gli atri due giurati e così via di seguito.
Terzo caso.
Cosa fa l’attacco? Un giurato dice tocca, l’altro non tocca (o comunque sono in disaccordo sul bersaglio valido o meno).
Qui il seguito può avere due possibilità: o il presidente di giuria si esprime e quindi prevale tale giudizio (per un totale quindi di due punti e mezzo), oppure si astiene e quindi con due opinioni difformi di uguale valore (entrambi un punto), nel dubbio, si blocca il giudizio sull’azione e si rimettono in guardia i due schermitori con un nulla di fatto.
Quarto caso.
Cosa fa l’attacco? Se i due assessori e il presidente si astengono tutti e tre (ma dove erano? Al bar?!) anche in questo caso nessuna stoccata viene aggiudicata per il beneficio del dubbio.
Naturalmente se il primo colpo della ricostruzione dell’azione fatta dal presidente di giuria non tocca, si passa al secondo, poi al terzo e così sino all’ultima stoccata che ha composto il fraseggio schermistico.
Detto questo, v’immaginate bene cosa poteva succedere!
Uno poteva, ad esempio, staccare letteralmente la testa dalle spalle dell’avversario con una sciabolata e giurati e presidente potevano candidamente pronunciare il non tocca!
Oppure, all’inverso, colpi di punta che si fermavano a dieci centimetri dal petto venivano dati per arrivati sul bersaglio.
Ma, sempre prescindendo dalla cattiva fede (che era esclusa a priori perché gli schermitori sono sempre ottimisti!), alla fine non dico dell’incontro, ma della gara, si faceva poggio e buca, come si dice da noi in Toscana: all’incirca tante te ne toglievano, tante te ne davano.
Questo ci dicevano i nostri maestri, ma nessuno credo sia mai riuscito a dimostrare questo teorema.
Ciò che invece era certo è che in queste gare si correva sempre il pericolo di prendersi un bel torcicollo: era tutto un girarsi e rigirarsi a destra e a sinistra alle proprie spalle per seguire le sentenze dei propri assessori; mentre quelli dell’avversario te li ritrovavi direttamente davanti.
Fasi convulse, veloci se c’era affiatamento nella giuria o lente se non c’era; interrogazioni, precisazioni, chiarimenti e altro, poi alla fine una delle due braccia del presidente di giuria alzate, dalla tua parte o dalla parte opposta; quindi gioia o dolore.
Già, ma a questo proposito non possiamo tacere sulla rivoluzione culturale che è ha stravolto il nostro mondo, una rivoluzione da oscurare addirittura quella copernicana.
Da tempi immemorabili la stoccata vincente era segnalata, sia visivamente sulla macchina della pedana che sul supporto cartaceo, come ricevuta da uno dei due contendenti; in parole povere il succo era: tu ti sei beccato il colpo e segno a te la stoccata presa. Chi viene colpito per X volte perde il match.
Probabilmente chi ha impostato le cose in questi termini, infierendo psicologicamente sul toccato, era un grande sadico oppure, più semplicemente, un invidioso che non voleva dare completa soddisfazione al toccante.
Nessuno saprà mai. La verità.
Invero, poi, appare più logico e diretto dire sono stato toccato io che dire lui mi ha toccato.
Fatto sta che un bel giorno qualcuno si sveglio di traverso, maldisposto verso il mondo intero, e suggerì così di punto in bianco di cambiare il sopra con il sotto, il chiaro con lo scuro, la sinistra con la destra: d’ora in poi si sarebbe segnalato, anche sulle macchinette delle pedane, il colpo di chi toccava e non più di chi era toccato.
Eureka! Sembra abbia prorotto il moderno Archimede.
Se è stato fatto per rendere più comprensibile la nostra disciplina al grande pubblico, ovvero a quello della televisione visto che alle gare ci sono sempre stati i due soliti gatti (detto per inciso, anche loro hanno fatto sapere che non ne possono più!), credo sia tutto tempo perso: il grande pubblico non capirà mai… nulla di scherma.
Alle prime gare comunque (ma anche in sala) non è stato semplice, anzi, absit iniuria verbis, è stato proprio un bel casino!
Aumento del consumo delle pillole contro il mal di testa, errori marchiani, urla, pianti, ma, per fortuna, assenza di suicidi.
Gente che esultava e poi invece era stata toccata; gente chiamata invano sulle pedane al turno successivo, perché, credendo di essere stata eliminata, se n’era andata via; gente che ti batteva le mani ed invece avevi perso e le batteva al tuo avversario.
Tutto ciò naturalmente riferito al fatto di toccare od essere toccati; per la ricostruzione dell’azione invece allora come ora o, se preferite, ora come allora.
Beh! A dire il vero non proprio come ora, perché almeno alle competizioni più importanti il Regolamento contempla ai giorni d’oggi la fruizione del replay secondo precise modalità di richiesta dei contendenti e del presidente di giuria.
Di televisione ne vedevamo così poca che l’abbiamo anche importata nella nostra disciplina!
I più perspicaci a questo punto avranno intuito una cosa di fondamentale importanza (e qui il discorso si fa molto interessante): quanto è cambiata l’applicazione della tecnica schermistica in funzione della segnalazione automatica delle stoccate.
E come poteva essere diversamente: oggi un colpo si può vibrare anche ad una velocità superiore a quella della luce (Einstein permettendo!), tanto c’è un marchingegno che la registra, l’occhio umano con i suoi limiti è ormai sorpassato.
Prima il concetto era completamente ribaltato: la stoccata andava tirata in modo tale da poter essere visibile a coloro che guardavano l’assalto. Quindi, a prescindere dalla velocità esecutiva dell’azione, la stoccata finale si doveva letteralmente stampigliare sul bersaglio e incollarcisi sopra per evitare possibilità di travisamento.
Ne discende che il colpo doveva essere soprattutto tirato con traiettorie rettilinee o curvilinee ben chiare: il fuetto tanto per citare un caso, oltre a non essere percepito, avrebbe solo suscitato l’ilarità della giuria.
Tanto per intendersi la piattonata, quella tirata dal lato flessibile della lama, era non valida nella sciabola
Un altro aspetto importante, limitatamente al fioretto, è quello della quantità minima di pressione da esercitare per la registrazione della stoccata: come si fa a misurare con la sola vista 500 grammi!
L’arco descritto dalla lama piegata poteva essere un certo indice, ma quante volte, tirando con il fioretto elettrificato, questa configurazione non fa accendere l’agognata lucina, perché l’angolo d’impatto è infelice e non consente di vincere la resistenza regolamentare della molla.
Poi è anche successo che la Federazione internazionale per limitare l’abuso del fuetto ha proceduto ad allungare il periodo minimo d’impatto e di permanenza sul bersaglio; una specie quindi di ritorno all’antico, una specie di autovelox schermistico.
Utilizzare un marchingegno meccanico per i tuoi problemi è legittimo (e siamo fortunati che la tecnologia ce lo consenta), ma fondamentale è come venga tarata la macchina.
Queste a mio parere le motivazioni che, al contrario di oggi, imponevano più ordine, più calibratura alle azioni, più convenzione: altrimenti, non solo non ti davano le stoccate, ma ti guardavano anche male!
L’avvento della segnalazione automatica, risolvendo finalmente in modo oggettivo come abbiamo anche sopra ricordato la materialità della stoccata, ha indubbiamente influito sul modo di tirare il colpo: non doveva più essere percepito dalla giuria, ma semplicemente arrivare a bersaglio; evidentemente un bel sollievo per chi calcava le pedane, ma foriero di ineluttabili cambiamenti tecnici.
A questo proposito mi tornano in mente gli scambi di stoccate che talvolta, quando la sala era particolarmente piena, ci scambiavamo ai bordi delle pedane senza poterci attaccare ai rulli.
Era come entrare in un’altra dimensione: sapevi che per ottenere il riconoscimento da parte dell’avversario le tue stoccate dovevano essere nette, al di là di ogni dubbio e dovevi concentrarti soprattutto sulla pulizia dell’azione e della scelta del bersaglio.
A quei tempi, tirando talvolta in questo modo in sala, ti vergognavi a non accusare la stoccata netta ricevuta, anzi ti affrettavi a farlo affinché il tuo avversario non ti considerasse un furbetto da quattro soldi.
E quasi sempre anche lui si comportava allo stesso modo; mentre un colpo dubbio non lo voleva nessuno, sembrando fosse quasi una carità.
Roba da piangere (o da ridere, a seconda dei tempi e delle sensibilità personali), comunque sempre molto deamicissiana e formativa.
Morale finale alla Fedro o alla La Fontaine: fiorettisti e soprattutto sciabolatori d’oggi non lamentatevi troppo in pedana, perché almeno metà del cammino che vi porta alla stoccata lo fa l’apposita macchinetta magica!
Campionati, trofei, coppe e similari
Lo schermitore, come lo sportivo in genere, non può sfuggire alle gare: è una necessaria sfida con se stesso, prima che con gli altri.
Del resto ogni assalto, anche quello fatto in sala, è una piccola battaglia e, a ben pensare, addirittura ogni singola stoccata è una competizione in miniatura.
Ogni episodio significativo sulla pedana ha una sentenza: o io o l’altro, con la nota eccezione della patta del colpo doppio nella sola spada.
Sentenza del resto sempre appellabile, almeno sino all’ultima stoccata prevista dal punteggio o sino all’ultimo secondo prima dello scadere del tempo concesso.
Le gare, piccole – medie o grandi che siano, sono quindi indispensabili verifiche del cammino percorso da ogni tiratore, ognuno, ovviamente, nella dimensione in cui occasionalmente o volontariamente si trova.
Agl’inizi degli anni di cui vi narro di gare non se ne disputavano molte, anzi ce n’erano veramente pochine, in verità una vera penuria.
Campionati regionali, campionati nazionali, qualche Coppa qua e là, alcune gare a squadra, tre gare internazionali di un certo rilievo, come vedremo tra breve; molte di queste competizioni erano per di più riservate agli schermitori seniores, per cui da giovincello ti allenavi, ti allenavi e ancora ti allenavi.
Chi possiede ancora qualche numero della rivista federale “Scherma” di quel periodo sa che le pagine finali erano riservate ai risultati delle gare: appena arrivava il giornaletto andavamo subito per leggere i nostri nomi.
Non eravamo moltissimi a partecipare all’attività agonistica e i nomi dei partecipanti c’erano tutti, anche quelli che erano usciti al primo turno.
A qualcuno bastava anche questo (chi si accontenta gode e, soprattutto, fin che c’è gara, c’è speranza!).
In qualche regione le schiere dei tiratori erano veramente ridotte ai minimi termini: ricordo di avere visto con questi miei occhi un solo partecipante ad un campionato regionale, di cui ovviamente risultava vincitore senza colpo ferire.
Una volta (non avendo la stessa fortuna) commentavamo tra ragazzi un po’ ironicamente queste cose in sala e un maestro ci disse candidamente: Lui c’era, gli altri no!
Che mancassero per paura, mal di pancia o altro non era importante e non dipendeva certamente da lui; lui c’era ed era pronto a battersi per il titolo, gli altri no.
Il ragionamento non fa una grinza e la cosa, lo ricordo perfettamente, ci colpì non poco; noi alle gare saremmo andati anche con quaranta di febbre.
Di anno in anno, come funghi, le gare cominciarono a spuntare: i campionati nazionali furono disputati su più prove, fu reintrodotto il campionato nazionale a squadre (per un certo numero di anni si procedeva con la sola sommatoria delle classifiche individuali finali), nacquero soprattutto tante gare rivolte ai più giovani, che quindi avevano l’opportunità di fare esperienza.
Nasci qui, nasci là oggi siamo ad una vera e propria inflazione di gare (nascessero così i porcini nei boschi): uno schermitore potrebbe partire e stare in trasferta per un anno intero, balzellando di competizione in competizione, e qualcuna gli sfuggirebbe comunque.
Per l’amor di Dio, meglio l’abbondanza che la carestia!
Do un po’ di particolari sulle gare.
Innanzitutto la partecipazione alle gare era a titolo gratuito, così gratuito che non ci siamo mai posti questo problema.
Pagare alle gare? Ma scherzi, vero?!
Poi c’è la questione del prestigio della gara: ci sono campionati, ci sono coppe e trofei.
Il top era nei campionati, perché c’era in palio una cosa importantissima, che prevaricava sicuramente il premio materiale, coppa o medaglia che fosse: il vero tesoro era costituito dal titolo, il titolo di campione di un qualcosa; non so, regionale, nazionale, per età o per categoria.
Vuoi scherzare, essere campione…
Vuol dire che per circa un anno, sino a quando la gara che hai vinto non verrà nuovamente disputata, il campione sei tu e nessun’altro (una specie di concorso di mis Italia).
Entri in sala ed i compagni pensano: ecco il campione…; vai ad una gara e gli altri ti vedono e pensano: ecco il campione…
Magari gli altri non ci pensano affatto, ma l’importante è che ci pensi tu!
Sarà, ma questo significato etereo della vittoria, il titolo, questa gloria ad orologeria, è sempre stata una gran bella cosa.
Dipendesse da me farei più campionati, di qualsiasi ordine e tipo; tanto non farebbe male a nessuno!
Naturalmente più la gara era di prestigio, più medaglie d’oro come premi c’erano in palio; poi si scalava all’argento anche se di ottimo conio; infine si scadeva nel bronzo o quello che era.
Le coppe erano un argomento a parte: avevano per noi un valore aggiunto in quanto, marcatamente più tridimensionali, erano visibili ed ostentabili anche da molto più lontano nelle nostre camerette di ragazzi.
Inoltre ci si poteva versare champagne (leggasi coca cola o aranciata) e brindare alla vittoria, novelli Ebe e Ganimede. Inconsulti gesti antigienici al massimo, ma di grande coreografia.
Tornare dalla gara anche con una medagliuccia era considerato ovviamente l’obiettivo di minima.
C’era il vincitore; il secondo classificato (il vice vincitore, che se non c’era il primo avrebbe vinto lui!); il terzo classificato (che almeno era montato sul podio, fisicamente o anche solo idealmente); c’erano i finalisti, tutti premiati e contenti; i semifinalisti, che pensavano: la prossima volta ce la farò; c’era poi il limbo di tutti gli altri.
Addirittura c’era in molti casi anche la medaglietta di partecipazione, derivazione culturale buonista del messaggio imperante dell’epoca: l’importante è partecipare (bella illusione e/o presa in giro!).
Poi c’erano coppe e trofei, ma questi non erano collegati tra loro in circuiti di punteggio, erano gare isolate e basta, singoli episodi fine a se stessi.
Mi ritorna in mente (quasi battistianamente) che all’estero impazzava la moda dei premi con la formula tavolone: tanti cadeaux materiali sparsi, magari orologi (anche se non di marca svizzera), stereo (piccoli, ma stereo), quadri (magari di qualche pittore sconosciuto), soprammobili e quanto di più strano si possa pensare (come nelle pesche di beneficenza delle parrocchie).
Il primo classificato sceglieva secondo i propri gusti, poi toccava al secondo, al terzo e così via; agli ultimi magari vere schifezze pacchiane, ma sempre premi.
C’era un’altra grossissima differenza: la formula di gara.
In quegl’anni imperava il girone all’italiana (uno contro tutti, tutti contro tutti), dall’effettuazione del primo turno eliminatorio sino alla finale per il primo posto.
Dapprima le finali erano ad otto partecipanti: contemplavano quindi ben ventotto assalti, una specie di piccola guerra. Si cominciava ad una certa ora, ma non si sapeva con certezza quando sarebbe finito (certe volte a notte fonda).
Prudentemente i finalisti furono portati a sei e le cose, con solo quindici assalti da disputare, andarono meglio; si arrivava comunque a tardi orari vespertini.
La gara era alla distanza, chi vinceva più assalti aveva più chances.
Ma c’era comunque il pericolo del pari numero di vittorie, che portava allo spareggio (barage per i raffinati!).
Se ti andava bene assistevi ad un solo assalto, in pratica un’eliminazione diretta dei tempi attuali!, a tre o addirittura a quattro; e si ricominciava quasi di nuovo!
Per rendere meglio l’idea, citerò una canzone di un certo successo cantata in quegl’anni da Jonny Dorelli: l’eternità.
Le gare a squadre
Lo sanno tutti che la scherma è uno sport individuale, ma memori della storica tenzone tra Orazi e Curiazi, si è cercato di dare allo disciplina una dimensione più allargata di scontro tra schermitori organizzati in schiere; più semplicemente si è pensato alle gare a squadre.
Nel periodo che trattiamo la formula in auge era quella dello scontro individuale tra i singoli componenti le due diverse compagini: ciascuno degli contro tutti gli altri.
Si era partiti addirittura da incontri quattro contro quattro (evidentemente c’era ancora lo strascico dei tre moschettieri più D’Artagnan!).
Erano in totale sedici assalti che si trascinavano per un tempo indeterminato, cose da pernotto in tenda canadese.
Visto poi che con questa formula di gara gli schermitori praticamente invecchiavano tirando, si decise di passare alla più agile compagine di tre contro tre; quindi nove assalti gestibili in media nell’ora di combattimento totale.
Ogni vittoria andava ad incrementare il proprio relativo tassametro e, giunti al fantomatico quinto successo, i giochi erano matematicamente fatti e si poteva, a seconda delle fasi della gara, continuare per la definizione dell’aliquota del girone preliminare o interrompere direttamente l’incontro nel caso di scontro ad eliminazione diretta.
Arrivederci e grazie!
Invero c’erano altre formule di gara anche più solleticanti, quelle fatte a staffetta , cioè basate sul concetto di un punteggio progressivo che doveva essere incrementato mano a mano dalle stoccate che si riusciva a mettere negli assalti che si avvicendavano tra i diversi concorrenti. Fino all’ultimo c’è speranza e magari lo Zorro di turno può fare anche il miracolo di una rimonta strepitosa.
Un mio maestro, giocando a fare l’oracolo, disse: roba da una gara lui e lei; mandateci Mennea a fare le staffette; la formula non sicuramente avrà successo.
Difatti…
Le gare internazionali
Come vi ho già detto all’epoca già le gare ordinarie andavano cercate col lanternino o col bastoncino da rabdomante, pensate quelle internazionali!
Intanto c’era ancora un certo muro, molto selettivo, che impediva la libera circolazione delle persone; in Europa c’era ancora l’obbligo dei passaporti tra tutti gli stati e per muoversi era tutto un rinnovare e timbrare.
L’attuale circuito della coppa del mondo era ancora nella mente di Dio e per ogni specialità bastavano le dita di una sola mano per contare le gare internazionali importanti.
In Italia all’inizio ce n’erano solo tre, una per arma: la Coppa Giovannini di fioretto a Bologna, il trofeo Luxardo di sciabola a Padova ed il trofeo Spreafico a Milano.
A queste grosse manifestazioni partecipavano anche le rappresentative dei paesi dell’est europeo.
Noi giovani, solennemente bastonati nelle nostre prime uscite, facevamo una speciale classifica riferita agli avversari incontrati in pedana: io sono a un russo e un polacco, tu? Io a un ungherese ed un romeno.
A questa specialissima borsa francesi, tedeschi, belgi e similari valevano meno; svizzeri e austriaci quasi nulla. I Sanmarinesi non avevano alcuna quotazione.
Scherzi a parte era entusiasmante incrociare il ferro con gli atleti oltrecortina: se ne dicevano così tante in giro che vedere un marziano o un saturniano atterrare sulla Terra sarebbe passato quasi inosservato.
Tiravano da Dio: facevano affondi lunghi il doppio dei nostri, quando muovevano il loro ferro non lo vedevi nemmeno, in difesa erano dei muri invalicabili e quando attaccavano non restava altro che raccomandare la propria anima a Dio.
Con loro perdevamo e sonoramente, quindi alzare un po’ la loro fama non era cosa poi così disdicevole anche per noi.
Achille, prima di Paride,chi l’ha mai battuto!
E sappiamo tutti che è stato aiutato da una dea; per giunta arco e freccia contro una spada!
Le gare internazionali rappresentavano poi per noi giovani la possibilità di ricchi commerci: questo giubbetto elettrificato l’ho preso con solo quattromila lire; tre lame di spada per diecimila lire, regalate! Una maschera praticamente nuova per quarantamila.
Erano affari, ma soprattutto per quelli che vendevano!
I materiali erano senz’altro più scadenti dei nostri e talvolta addirittura incompatibili come ad esempio gli attacchi per il fioretto.
Un mio compagno mi mostrò fiero un passante di fioretto nuovo, nuovo e “rubato” per tremila lire; ma non aveva l’innesto a baionetta come i nostri, bensì un normale spinotto a due contatti. Fu costretto l’anno dopo a comprare anche un fioretto idoneo! Raccontò la storia solo a me.
Poi cominciarono ad organizzare anche trofei per i giovani e a rompere il ghiaccio fu per la specialità della spada la Coppa Città di Genova: un paio di francesi, quattro tedeschi, un monegasco, un lussemburghese ed un olandese (probabilmente quello volante visto che eravamo in una città di mare!).
Non era molto, ma abbastanza per cominciare.
I genitori alle gare
A metà anni sessanta ci si accostava alla scherma in età abbastanza più avanzata di quanto non accada oggi.
E’ vero che c’erano già le categorie dei Maschietti e della Bambine, ma la Federazione aveva appena lanciato il Gran Premio Giovanissimi di Roma e i partecipanti erano veramente tre gattini e tre gattine.
In genere si cominciava quando si frequentavano le scuole medie: dai dodici ai quattordici anni.
Di gare riservate a queste categorie, come abbiamo già avuto occasione di dire, ce n’erano non poche o pochissime, ma in verità solo due: il campionato regionale ed il campionato nazionale. Niente coppe, coppine, trofei o trofeini.
Gli episodi agonistici erano così isolati che la gente non aveva nemmeno il tempo per prenderne quasi coscienza: i ragazzi arrivavano, facevano un paio di assalti, magari tre; uno vinceva, uno perdeva, faceva la sacca e ritornava a casa. I riflettori non facevano nemmeno in tempo ad accendersi che già erano spenti.
L’ambiente poi condizionava non poco: nessuno alzava la voce più del necessario, le contestazioni, se mai c’erano, erano civilissime e spesso si risolvevano bonariamente; i presidenti di giuria erano, a ragione o a torto, incontestabili e la gente, ancora sufficientemente istruita, capiva al volo che non poteva sostituirsi a loro; i maestri tenevano moltissimo alla loro reputazione, soprattutto anche a quella non professionale; i torti, perché i torti nella vita ci sono sempre stati, venivano incassati con sobrietà (tanto vanno incassati comunque!).
Direi che c’era in giro tanta buona educazione; al solito con le dovute eccezioni, che in quanto tali si ritorcevano direttamente e manifestamente a danno di chi educato non era.
Non un mondo perfetto, ci mancherebbe altro, ma un mondo che ci teneva a farlo sembrare.
D’altra parte, almeno sino allo scoppio della contestazione studentesca del ‘68, nelle scuole il professore era il professore e nelle sale di scherma il maestro era il maestro.
A nessuno, dico a nessuno, sarebbe venuto in mente di invadere il campo di un insegnante, di lettere, di matematica o di scherma che fosse.
Unicuique suum, a ciascuno il suo, è un detto calzante a questo proposito: a meno che una laurea o un diploma di maestro di scherma non lo si compri al mercato centrale.
Quindi nel nostro ambiente il rispetto per il maestro era assoluto ed è rimasto tale sino a quando le persone hanno conservato una minima e pudica porzione di ritegno.
Ci si vergognava quindi a mettersi in mostra con contestazioni villane e fuori luogo, che spesso portano a figure cacine (lo dite anche voi?); si preferiva lasciare ai professionisti l’esercizio delle loro arti.
Sul rapporto genitori figli consumato alle gare s’intrometteva il maestro, vero padre putativo della situazione, che teneva tutto sotto controllo e che godeva della massima fiducia di tutti, anche quando il pargolo in questione perdeva.
La scherma a quei tempi era ancora diversa dal calcio, dove, allora come oggi, su cinquantacinque milioni d’italiani tutti e cinquantacinque sono commissari tecnici della nazionale.
La presenza dei genitori alle gare quindi era una presenza discreta, non dico muta, ma poco ci manca: i genitori ancora confessavano di capire poco di tecnica e di tattica schermistica e soprattutto si fidavano ciecamente del presidente di giuria (o almeno di fronte ai loro figli facevano finta di farlo).
E tutti ci guadagnavano.
Le trasferte
Poche gare in calendario, poche trasferte, anzi ancora meno, visto che alla fine vuoi per un motivo, vuoi per un altro qualche appuntamento finiva sempre per saltare.
Poche trasferte però tanti solidi ricordi, appunto perché legati ad eventi piuttosto rari, quasi da morte di Papa.
Oggi spostarsi, almeno in un certo raggio, vuol dire prendere l’auto e partire: a 18 anni e un giorno tutti (o quasi) posseggono un’autovettura e anche di buone prestazioni.
Prima non era così: solo i più socialmente fortunati a circa vent’anni, dopo che avevano fatto scuola guida con l’auto del padre (le madri ancora erano poco patentate), potevano sperare nella famosa cinquecento Fiat, naturalmente usata, anzi usatissima.
Lanciata, arrivava a sfiorare gli ottantacinque chilometri l’ora con favore di vento e in assenza di salite ardite; quindi, se dovevi transitare da qualche passo appena collinare, la media crollava miseramente.
Per andare a fare una gara a Napoli, ad esempio da Milano, dovevi partire un paio di giorni prima, senza contare il dramma delle sacche da scherma.
Il rimedio, ovvio, era il portapacchi; ma questo andava ancora ad incidere sulla velocità di spostamento, che diventava da bradipo.
L’aereo costava troppo, in nave ci voleva il mare, restava il buon treno, rigorosamente di seconda classe.
E qui una rivelazione per i giovani d’oggi: le credenziali.
Parola ambigua, di vago sentore diplomatico, che invece aveva un’enormee benefica portata economica.
La credenziale era la possibilità di fruire della riduzione del cinquanta per cento per i trasferimenti effettuati tramite mezzi pubblici: in treno (per tutti), in nave (solo per gli schermitori delle isole), in aereo (idem come prima e autorizzati).
Lo sconto era valido solo per attività sportive, ma come potete immaginare in un Paese di furbacchioni come il nostro l’uso era alquanto elastico.
Compilavi il modulo: dal tal posto al tal’altro (già il fatto di non fare andata e ritorno poteva destare un legittimo sospetto), mettevi la motivazione (generica) e partivi felice.
I treni erano quelli che erano: poca pulizia (il termine cesso deve essere stato coniato appositamente per indicare i gabinetti delle carrozze!), lenti come lumache (forse di più), il più delle volte affollati e pieni come saporiti insaccati, fredde e calde sino all’impossibile (in effetti sul marchingegno di seconda classe la manopola che si utilizzava per mitigare l’inospitale clima indicava onestamente solo “caldo” e “ freddo”).
La prenotazione, di rito oggi, si poteva fare press’a poco solo sull’Europa – Express( mi ricordo questo nome perché quando giocavo col trenino elettrico Rivarossi questo locomotore era (ed è restato) il mio sogno proibito.
Quindi ti presentavi alla partenza (e alla ripartenza del ritorno) sempre con una certa agitazione addosso, anche perché le sacche da scherma sono sempre state degli enormi orpelli da trasportare.
Detto fra noi chi riuscisse a brevettare le armi telescopiche, quelle da potersi accorciare ed allungare con una semplice pressione delle mani, diventerebbe miliardario!
Allora tattica schermistica.
Uno di noi, privo di sacca, era delegato alla conquista dei posti migliori: prima doveva guadagnare con abile appostamento sul binario un buon numero di accesso al predellino.
Sì, il predellino: quella scalata degna di una guida alpina che si doveva compiere per poter salire al piano delle carrozze; ci sono volute decine d’anni, ma alla fine si sono accorti che, non potendo abbassare i treni, potevano alzare necessariamente il marciapiede. All’estero l’avevano fatto da anni, forse da subito!
Quindi il compagno privo di pesi e d’ingombri, degno erede dei conquistadores dell’America centrale, veloce e sgusciante come un folletto si precipitava sui posti liberi, mettendo berretti, giornalini, fazzoletti e quant’altro a simbolo dell’avvenuta presa di possesso del posto. Il Diritto Internazionale credo conceda in tutto il mondo questa deroga procedurale solo all’Italia!
Ed ora altre notizie sulle carrozze degne di essere utilizzate per una voluminosa “Storia del Treno”.
Prima c’erano gli scompartimenti, ovvero delle sezioni, degli sgabuzzini dotati di porta separatrice per sei od otto viaggiatori, a seconda che si trattasse di prima o di seconda classe. Da ciò si desume anche facilmente che quest’ultimi viaggiatori sono più portati alla socializzazione! I corpi sono così vicini gli uni agl’altri che potrebbero risparmiare qualche sedili e fare viaggiare le persone una in collo all’altra!
La gioia pura era trovare uno di questi scompartimenti vuoti, ma anche se c’era una persona di solito, dopo che era arrivato tutto il battaglione degli schermitori, spontaneamente abbandonava il campo. Chissà perché?!
E allora musica a tutto volume da mangianastri paragonabili a magnetofoni degli anni venti e fuori le carte per innocentissimi poker ovviamente senza fumo ed alcolici, per piatto caramelle o similari, sì caramelle!
Meglio stendere un pietoso velo sulla nostra emancipazione da giocatori d’azzardo e continuiamo con i treni.
A proposito, vi siete accorti di un’incongruenza?
Le vecchissime carrozze, quelle veramente vecchie che credo di aver preso solo un paio di volte nella mia vita, avevano tante porte esterne quanti erano gli scompartimenti. Entravi, uscivi e manco sapevi chi era montato poco più a sinistra o poco più a destra. Quelle con le panche di legno, per sederi veri!
Poi, finalmente capirono che le entrate – uscite potevano essere ridotte a due, poste logicamente ai due lati della carrozza con stretto corridoio comunicante.
L’evoluzione, degna del migliore Darwin, oggi ci ha regalato la carrozza – pullman, nome inquietante che getta profondi dubbi sull’abitacolo del pullman: forse pullman pullman?!
Fatto sta che credo ci sia questo proposito un palese dubbio di costituzionalità (si fa così per dire): più ampliano la portata della legge sulla Privacy, più ci fanno viaggiare gomito a gomito!
Ma ritorniamo (e volentieri) a noi schermitori, che, stazza personale a parte, ci portavamo sempre dietro quella sgraziata borsa, chiamata affettuosamente sacca delle armi.
Il problema non era per le vecchie carrozze dove abbondavano porta valige aerei, porta pacchi, porta quel che vuoi; il problema è per i treni d’oggi dove a stento riesci ad entrarci a malapena tu.
E’ per questo motivo che gli schermitori sui treni sono rari al pari dei pinguini nel deserto del Sahara!
Questa poi ve la devo proprio raccontare.
Ritornavamo da una gara effettuata in un certo paesetto del centro – Italia, dal quale transitavano solo treni lentissimi, che per burla le Ferrovie dello Stato denominavano accelerati! Eravamo riusciti a trovare posto solo nel corridoio, che i più anziani di voi si ricorderanno che era formato molto small.
C’erano dei seggiolini retrattili e quindi due o tre di noi, a turno, potevano anche sedersi scomodamente. Le sacche giacevano sparse per terra, impedendo il passaggio anche ad una formica.
Ed ecco che si avverte il suono di un campanellino, un trillo argentino e gioviale che, invece, preannunzia una tragedia greca: il carrellino bar deve transitare!
Descrizione fedele: noi, appiattiti contro i finestrini, con le braccia alzate per tenere le sacche per aria, il simpatico carrellino che sfiorandoci ci faceva il solletico e convulse risate a crepapelle.
Inoltre e per di più carrellino (sempre lui) fermo per cinque minuti davanti alla porta dello scompartimento dove evidentemente c’erano dei sopravvissuti all’attraversamento di un deserto: acqua minerale, panini, caffè e, se ci fosse stata la torta della nonna, avrebbero preso anche quella!
Uno schermitore, tranne che quando in pedana con la sua punta fa una finta, non mente mai. Credetemi, è tutto vero.
E quell’altra volta che saliti di corsa sul treno a Bologna trovammo posto solo nella toilette (in treno si chiamava anche, un po’ poco bellicosamente, ritirata); va beh! Meglio che restare a piedi.
Si, ma avete mai mangiato delle lasagne (le avevamo trovate miracolosamente nel cestino da viaggio) in un luogo del genere!
Poi per le trasferte più lunghe c’erano le cuccette (mai termine fu più appropriato); come già detto viaggiavamo solo in seconda classe e le cuccette era ben sei per scompartimento, stretti loculi senz’aria dove si sentivano rinchiusi anche i malati di agorafobia, cioè quelli che hanno il terrore degl’ampi spazi.
Ci emancipammo dal treno quando il padre di uno di noi ebbe uno slancio di generosità: vi presto la mia macchina. (con quelle nostre un sgangherate avevamo un raggio d’azione poco superiore a quello di un buon ciclomotore!).
E fu la libertà e la vera indipendenza!
Ma le spese sono le spese ed il treno era sempre economicamente più vantaggioso; quindi fummo costretti a rivedere le spese di pernottamento (per il cibo andavamo avanti a panini e pizze).
Questo albergo costa troppo, meglio quella pensioncina… quella volta però esagerammo: era in pratica un albergo ad ore, dove si vedevano le coppiette entrare ed uscire con una certa spasmodica frequenza. Per vari motivi quella notte dormimmo pochissimo!
Poi c’era la speciale classifica dei luoghi di gara.
Lo sapete tutti, non fate i furbacchioni: gli schermitori sono tra gli sportivi quelli più scaramantici e superstiziosi.
Napoli, Roma e Milano mi portano bene! A Torino invece mi è sempre andata male! A Genova? Ci vado anche a piedi a fare una gara!
E così, con flussi ed influssi paranormali, facevamo la nostra personale geografia della buona e della cattiva sorte (eppure io ci credevo e ci credo tuttora!).
Le trasferte, forse la cosa che, dopo il tirare liberamente su una pedana, ricordo con maggiore affetto e nostalgia.
Quante risate, quante piccole paure e tensioni, quante emozioni nuove, quanto casino fatto con i compagni dell’età più bella (il copyright della frase è ovviamente del Leopardi).
Le trasferte, poi, scandirono i tempi della nostra emancipazione giovanile.
Prima dai nostri genitori, perché venivamo affidati in quelle occasioni al maestro, che il più delle volte si dimostrava più un nostro compagno più adulto che un mastino da controllo.
Poi anche dallo stesso maestro, regalandoci quella meravigliosa sensazione di autogestione completa (la famosa libertà), che è stata l’anticamera della nostra vita da adulti.
Dovrei ricominciare a fare le gare… solo per poter fare ancora le trasferte!
Antiquariato
Dopo tutti questi discorsi di sentimento (ché non vorrei procurare troppa tristezza od uggia!), torniamo per un istante alle cose che si toccano, quelle che popolavano il nostro mondo di schermitori dell’altro secolo, privo di tecnologia, di computer e cose affini.
Gli oggetti di cui mi accingo a parlarvi non li trovereste non dico dall’antiquario, ma nemmeno dal rigattiere.
La storia li ha condannati all’anonimato più completo e non avendo alcun valore venale (forse ormai nemmeno affettivo) sono tornati evangelicamente ad essere polvere.
Avverto che la vostra curiosità sta crescendo a dismisura e non voglio certo farvi soffrire più del dovuto, tiriamoli quindi fuori dai nostri ricordi questi oggetti scomparsi.
Il primo è costituito dalla tappeto di ferro dove tiravamo di scherma.
Si! Avete capito bene, tappeto, stuoia! Non proprio un bukara, ma sempre tappeto.
Oggi ci sono gli elementi componibili: le pedane si smontano, pezzo per pezzo, e quindi sono facilmente trasportabili nei vari luoghi di gara.
Prima invece c’erano questi tappeti metallici che venivano svolti da appositi grossi rulli, a loro volta fissati con dei tiranti ai due estremi longitudinali.
Erano color oro sporco e mi ricordo che facevano perfetta pendant con il colore dei giubbetti elettrici del fioretto, gli unici esistenti all’epoca.
Questi tappeti erano abbastanza lisci e grazie alla polvere che si accumulava facilmente su di essi risultavano abbastanza scivolosi e garantivano agli attacchi un effetto acquaplaning, molto simile a quello dei tennisti che giocano sulla terra rossa.
C’era anche il problema di tenere bene aderente a terra le parti laterali e questo venivano ottenuto usando dei nastri adesivi.
Nelle sale rappresentavano in genere la pedana buona, quella per le finali del campionato sociale o quella riservato alle lezioni del maestro, almeno sino a quando, data la scarsità congenita degl’impianti, gli veniva gentilmente chiesto di continuare da un’altra parte sul nudo terreno.
In questo caso le pedane erano stabili nel senso che l’ancoraggio laterale era assicurato da una serie infinita di piccoli chiodi dalla testa larga, quelli usati per le scarpe. In effetti mi sembra di ricordare che quando l’usura cominciava a produrre i suoi effetti, soprattutto lungo i bordi, il nostro tecnico delle armi andava a rifornirsi dal ciabattino che aveva la bottega vicino alla nostra sala!
Tirare con una certa continuità su questa pedana non era cosa da tutti i giorni: era una cosa prestigiosa che capitava quando molti compagni erano a qualche gara oppure quando c’era in giro l’influenza.
Mi appariva lunghissima e soprattutto larghissima (ecco perché i trattati avevano teorizzato lo scarto laterale e l’inquartata).
In genere era sopraelevata, nel senso che sotto c’era una pedana di legno, che rendeva molto piacevole il tirarci sopra; o meglio evitavamo le tallonati e le vibrazioni alla cervice che invece si cuccavamo sulle stuoie stese sul nudo terreno.
Era tanto bello saltellare sul morbido e rimbalzare insieme con forza e leggerezza durante l’esecuzione del passo avanti affondo a balestra, non solo utile per le azioni dirompenti, ma anche dal nome molto simpatico.
Quanta forza abbiamo sprigionato su quella pedana con le nostre giovincelle gambe, altro che energie rinnovabili e compatibili!
Passiamo ora ad un altro oggetto – culto per noi schermitori più che attempati e oggetto misterioso di origini UFO per i giovani.
Alla fine della pedana dorata c’erano due grossi candelabri poggiati per terra, due specie di baldacchini color alluminio vivo: non erano alari, bensì porta – rullo.
Alti una sessantina di centimetri costituivano un pericolo costante per l’incolumità dello schermitore che sull’incalzare veemente dell’avversario si vedeva costretto a retrocedere con una certa celerità.
Gli spiritosi dicevano che l’avvertimento che veniva prima dato dal presidente di giuria rispetto al limite posteriore non era tanto dovuto alla stoccata che si poteva perdere arretrando ulteriormente, ma soprattutto a questi due respingenti colossali; per cui l’originale frase “lei è a un metro” in origine probabilmente doveva continuare… “dallo stanfernone”!
Poterne trovare oggi un paio e poterli mettere ai lati del caminetto della nostra casa di montagna!
Mettiamo via questi porta rullo e parliamo ora di un oggetto talmente incredibile, che all’epoca deve essere stato anche portato come prova dell’atterraggio dei marziani sulla terra: la macchina segnalatrice delle stoccate di spada.
Oggi, comodo comodo, vai sul tavolino accanto alla pedana, accendi la macchinetta, lei ti fischia un po’, la selezioni sull’arma che stai impugnando e cominci tranquillo a tirare.
Prima non era esattamente così.
Sappiamo già che gli sciabolatori erano nudi come vermi ed i fiorettisti avevano una segnalatrice Carmimari (eccola in una rara foto), una macchinetta di color grigio ghisa, bassina e piatta, con delle calottine di plastica curve, dove le stoccate tanto desiate apparivano o non apparivano, accompagnate da un rispettoso e molto sintetico segnale acustico che emetteva un suono tipo sdleng.
Gli spadisti, almeno quelli che tiravano sulle pedane che non avevano ancora le nuove macchinette da commutare su fioretto o spada, si beccavano un cassettone d’acciaio con sopra due cupolotti di vetro bianco smerigliato (di questo ingombrantissimo aggeggio se ne sono perse completamente le tracce, anche i disegni).
La dimensione appariva esagerata e testimoniava inequivocabilmente che quando il guazzabuglio elettrico era stato concepito né i transistor, né i microcircuiti elettronici erano stati nemmeno presi in considerazione dalla migliore Fantascienza.
Il funzionamento, a differenza delle macchinette attuali dove è necessario avere una laurea in Ingegneria preferibilmente elettronica, lo poteva capite un bambino di un giorno: c’era un unico pispolino che al centro usciva all’infuori.
A cosa serviva? Te accorgevi la prima volta quando uno dei due spadisti toccava: cominciava a scampanellare in modo così indecoroso che l’unica speranza di farlo smettere era affidato al ricorso appunto a quell’unico appiglio esterno.

Il decibel, l’unità di misura del suono, non doveva ancora essere stato codificato e non c’era quindi ancora alcuna legge o ARPAT a tutela del silenzio o preteso tale.
Quando toccavi e si accendeva la tua lampadona lo sapeva tutta la sala ed eri soddisfatto; ma, siccome tutto il mondo della scherma è simmetrico, tutta la sala veniva aggiornata anche quando, meno simpaticamente, eri tu il toccato.
Mi ricordo anche che in una sala uno di questi apparecchi, accusando tutti i suoi progressivi acciacchi, produceva (chissà come e perché) due tipi diversi di suono a seconda di chi toccava.
Così il maestro, che aveva adocchiato chi era salito in pedana, pur dietro alle colonne che la nascondevano, spesso interveniva dicendo: Stefano sei un pirla (e così avete un indizio per capire in quale città mi trovavo)… tocca sempre Gianluigi!
Potenza dei maestri!
Le donne e la scherma
Io sono un uomo, ma preciso subito che parteggio per le donne; non proprio quando desidererebbe forse mia moglie Elena, ma spero comunque quanto basti per non suscitare le ire delle mie pazienti lettrici.
La situazione, soprattutto con la mentalità d’oggi, era abbastanza anomala: noi uomini, arrivati ai tredici anni e approdati quindi alla categoria federale degli allievi potevamo anche scegliere di passare alla sciabola o alla spada, invece le nostre colleghe dovevano essere monogame, cioè votare eterno ed unico amore al fioretto.
Insomma fioretto, fioretto e fioretto; qualcuno si affannava anche a giurare che le amazzoni, la vergine Camilla di virgiliana memoria e la stessa Giovanna d’Arco combattessero con il fioretto in mano, cosa che, lo sappiamo tutti, è un bel falso storico. Una vera ingiustizia, soprattutto per il fatto che gli uomini potevano addirittura tirare in due specialità (i famosi bi – arma): uno sberleffo in più al gentil sesso.
Comunque a questo proposito mi fa ancora sospirare un ricordo: da cosa mi accorgevo, entrando in sala, che quella sera tale schermitrice carina o tal’altra erano presenti? Naturalmente dallo sfarfallio dei giubbetti elettrici dei miei compagni che mi avevano preceduto: avevano opportunamente buttato alle ortiche sciabole e spade e si dilettavano in punta di fioretto. Che cavalieri!
Poi arrivò un forte vento e le cose cominciarono a cambiare.
Nei primi anni novanta alle colleghe fu permesso di impugnare la spada: Assomiglia così tanto al fioretto, che forse nessuno ci farà caso, disse qualcuno; come se la coccia più grossa della spada potesse sembrare una tonsilla ingrossata, ma sempre tonsilla.
La sciabola no! Per ora no! E’ troppo poco femminile con i suoi fendenti e traversoni.
Ma il successo della spada fu però tale che non si poté fare a meno di dire: “Ma sì, non c’è due senza tre; proviamo anche con le sciabolate”.
E nei pressi del terzo millennio, dopo tutto il gran daffare che il movimento femminista aveva fatto nel mondo, fu parità completa.
Ricordare oggi questa lunga e perigliosa rivoluzione culturale (quella di Mao al paragone fa impallidire!) è importante per un fatto: inviterei qualche bel galletto, quelli dalla cresta ben alzata, a sfidare qualche brava collega (volevo dire gallinella, ma non vorrei essere frainteso); poi verificherei il risultato finale del match.
Le distanze sono senz’altro meno siderali di quanto va magari dicendo in giro qualche bel pollacchione (ormai avete capito che mi piacciono gli animali da cortile!); ricordiamoci soprattutto che la nostra disciplina, quella vera, mette in mano a chi se ne intende, tante e poi tante armi tecnico – tattiche da riuscire a prevaricare anche marcate differenze di fisicità.
Mai sentito parlare della finta? Un legamento eseguito con i gradi giusti può essere ribaltato solo dal più muscoloso dei Macisti? E quella bella uscita in tempo che è la contrazione? E la passata sotto (cito anche l’inquartata perché altrimenti si offende)? La forza e l’avvenenza fisica sono un vantaggio, ma non sempre determinante.
Chi ha la fortuna di avere in sala molte compagne con cui incrociare il ferro sa benissimo che la categoria femminile si divide grosso modo in due sottocategorie: quella che s’incontra per civettare e alla quale spesso si offre con malcelata intenzione la vittoria sulla pedana e quella invece dalla quale è bene stare alla larga, perché è costituita da personcine da prendere con le molle.
Quindi viva le donne fiorettiste, sciabolatrici e spadiste.
Cose da gentiluomini
Ognuno di noi, volente o nolente, si ritrova a vivere in grandi afflati del pensiero e del comune sentire: così c’è stato il Classicismo dei greci e dei Romani, poi i Secoli bui del Medio Evo (però ora gli storici ci stanno ripensando a tante critiche sparate a vanvera in precedenza), il Rinascimento, il Neoclassicismo, il Romanticismo, il Decadentismo, il Futurismo, il modernismo, il postmodernismo e… chissà cosa ci aspetta (e che fatica)!
Nel nostro ambiente si fa molto prima: scherma da gentiluomini e da meno gentiluomini.
Eh si! Questa volta proprio non ce la faccio a lasciarmi andare al rimpianto!
Oggi si monta in pedana e arretri… trac! Toccato perché sei uscito dal limite posteriore; il tempo regolamentare è finito all’improvviso… trac! Perdi perché sei in svantaggio.
Ma come?! Almeno potevate dirmi qualcosa, avvertirmi del pericolo! Che gentiluomini siete?!
Appunto.
Precisiamo che queste regole ci sono sempre state ed indubbiamente servivano a contenere ogni assalto in termini accettabili: il tempo e lo spazio sono sempre serviti come contenitore dello scontro schermistico sportivo.
Una cosa però è una brocca, una cosa un bicchierino!
Mi rifaccio a studi statistici che ho trascritto su un’altra mia fatica letteraria, invero un po’ più tecnica di quella che state leggendo: ipotizzando un risultato finale di cinque a due, tenuto conto di corpo a corpo, rimesse in guardia e interruzioni varie ogni schermitore ha a disposizione una ventina scarsa di secondi per concludere un assalto di girone all’italiana a cinque botte. Anche per gli assalti di eliminazione diretta alle quindici stoccate tutto è in proporzione.
E vero che non c’è alcun obbligo di arrivare al risultato indicato come finale e lo scontro può fermarsi anche con il vantaggio di uno dei due contendenti, ma la verità, soprattutto per le gare di minor livello tecnico, è che, a mio parere, si è innestato un fattore ansiogeno suppletivo all’assalto, che proprio non ne aveva bisogno.
Cosa si sgolano a fare i maestri a dire: studia l’avversario e aspetta il momento più propizio per attaccare.
E allora perché gentiluomini e meno gentiluomini?
Ora ci sono i due” trac” ricordati poco sopra, prima c’era il formalissimo: Lei è al metro (nel fioretto) o ai due metri (nella sciabola e nella spada); e l’altrettanto formale: Avete ancora un minuto per finire l’assalto.
A parte le dimensioni fisiche diverse, diverso lo stile, direi diversa la filosofia che stava dietro gli avvertimenti: innanzitutto il fare scherma era meno compresso ed i limiti, sui quali c’era comunque il richiamo, apparivano come ineluttabili e non come parte necessaria e integrante dello scontro.
I limiti permanevano, ma apparivano come nobilmente sfumati e non mezzucci terra terra per sbrigarsi e andare prima a casa.
Certamente gli assalti in media duravano statisticamente in più, ma all’occasione potevano essere centellinati dal pubblico competente (e vissuti intensamente dagli stessi protagonisti) e non trangugiati come ora fa magari una percentuale di pubblico non competente.
A mio parere, elevato numero di partecipanti e preoccupazione per i costi hanno troppo condizionato l’alveo dell’assalto; e non scordiamoci che l’eliminazione diretta (addirittura senza ripescaggio) in uso oggi è clamorosamente più veloce dei gironi all’italiana di prima.
E, a proposito di gentiluomini, che dire del touché, cioè della spontanea accusa che fa lo schermitore raggiunto da una stoccata dell’avversario.
Sono questi gesti che possono oggi essere apprezzati, capiti e condivisi in questa Società contemporanea tutta impostata al pragmatismo e all’arrivismo più sfrenato e inquinata anche nello Sport dal Dio Denaro?!
La risposta è ovviamente, no!
Ma io credo, proprio per questo, che l’importanza dei buoni semi in questi periodi di estrema siccità sia non più un fatto di stile, ma invece di sopravvivenza di un’idea comportamentale diversa, di un valore etico alternativo e di controtendenza di cui andare fieri.
Qualcuno non capirà, qualcuno, sorridendo, magari ti compatirà, ma la cosa non ti deve sfiorare minimamente perché essere schermitore non significa essere campione vincente sull’avversario e alle gare; essere schermitore, per chi ancora non l’avesse capito, è essere vincente su se stesso (la più brutta bestia d’avversario che si può incontrare nella vita!).
Poi diciamocelo con sincerità, accusare la stoccata non vuol mica alzare la mano ad ogni spron battuto: facciamolo qualche volta, in occasione delle stoccate più belle e più nette del nostro avversario, insomma quando lo deve fare un gentiluomo (e ridagli!).
Mea culpa, mea maxima culpa!
Ammetto: sono stato parziale nei miei giudizi, molto parziale.
Ma, se permettete, trattasi di cosa molto importante per chi insegna: il touché non si può imporre a nessuno, ma si deve solo riferire che esiste. Poi, liberamente, ciascuno lo applica o non applica a suo modo.
E’ solo un seme che si lancia nel vento nella speranza che attecchisca e non muoia.
Lo bello stile
“Lo bello stile che m’ha fatto onore”, diceva Dante Alighieri, ma sappiamo per certo che non si riferiva alla scherma.
Avere stile dicono che significhi curare l’esecuzione di un movimento in rapporto ad una norma di correttezza e/o di eleganza.
A questo proposito sulle pedane di scherma due erano i limiti esistenziali possibili : le cosiddette belle statuine e i temutissimi scarrafoni.
Dio ci guardi dai secondi, che, oltre che essere evidentemente brutti, erano anche proprio per questo oggetto di tremendi strali degli osservatori specializzati: ma quello di chi è allievo?
Fango non solo sullo scarrafone, ma anche e soprattutto sul suo maestro, che agli occhi dei contemporanei era responsabile di tanto spettacolo antiestetico.
Ma di questo parleremo in dettaglio nel prossimo capitoletto.
Dall’altro lato c’erano le famose belle statuine, schermitori che stavano in guardia perfetta (pagina dodici, rigo quattordici, disegno numero cinque del trattato di scherma), ma che costituivano di fatto per l’avversario un puro bersaglio, neanche un po’ difficile da raggiungere. Un massacro degno dei peggiori film western sugl’indiani d’America.
Belli e stupidi, come se fossero attricette formose tutte curve e senza cervello come c’incalza l’iconografia cinematografica e televisiva più o meno contemporanea.
Una doxa evidenzierebbe che a quei tempi molti potenziali schermidori hanno smesso di frequentare le sale per non cadere in una di queste due trappole esistenziali! Belle statuine o scarrafoni.
Ma nelle sale di scherma prevaleva ancora un certo amor proprio, una specie di pudore professionale, che era basato su un vero e proprio “nihil obstat” che il maestro doveva concedere per la prima uscita alle gare esterne, considerata alla stregua del ballo delle debuttanti. Ci mancava solo che ti controllasse la divisa, il trucco e ti pettinasse!
Il cordone ombelicale col maestro era ancora saldo ed intatto e valeva il detto: fammi vedere come tiri e ti dirò che maestro hai.
Era ancora il tempo in cui il diritto di giocare sull’erba dei giardini era vessato dal cartello vietato calpestare le aiuole e il tempo in cui all’entrata degl’insegnanti la classe si alzava (ora probabilmente si alza solo il pubblico delle aule giudiziarie nei telefilm americani!).
Un mondo, capite, fatto d’estetica e di buone maniere, compattato da un insieme di usi e costumi tradizionali e soprattutto da una fitta selva di divieti, non necessariamente scritti.
Come fa in questo tipo d’ambiente uno schermitore a montare sulla pedana e a dare triste spettacolo di sé stando in guardia tutto storto, con un piede di qua e uno di là, con una spalla su ed una giù?!
Picasso era già vivente e produttivo, ma la mente degli schermitori era ancora ai volti e alle fattezze del Rinascimento fiorentino.
Poi una vera e propria rivoluzione, non ricordo bene se d’ottobre o di un altro mese!
Per incrementare la famiglia schermistica venne istituito un bonus di classifica di Gran Premio delle Società per la semplice partecipazione numerica alle gare, a prescindere dalla classifica di merito: una vera e propria politica di espansione demografica, una specie di assegni familiari per le Società di scherma.
Cittadinanza romana per tutti e Todos Caballeros, come c’insegna la storia.
Siccome pecunia non olet ci fu una corsa (tipo cercatori d’oro) a mandare alle gare tutti quelli che capitavano a tiro, amici, parenti stretti, affini, collaterali, condomini dello stesso stabile, persone casualmente conosciute per la strada!
E quello quanto è che tira? Neanche un mese, diceva ora orgoglioso il maestro; figurati, il mio, quello lì, l’ho pescato cinque minuti fa fuori del palazzetto!
Beh! Forse ho un po’ esagerato, ma voi avete senz’altro intuito cosa accadde.
Peggio stavi in guardia, più era tuo diritto personalizzare la scherma ed il maestro ora era diventato improvvisamente rispettoso delle tue peculiarità.
Lo bello stile era ormai un valore messo in soffitta, non necessario, quasi un inutile orpello esistenziale.
Ci credereste che sino a quel momento in alcune gare, oltre la normale premiazione in base alla classifica di piazzamento finale, esisteva ed aveva un valore tutto particolare anche un premio destinato all’atleta che aveva dimostrato più stile?!
Era una prova tangibile dell’esistenza dei due poli di riferimento dello schermitore ideale: uno pragmatico, l’altro ideale.
A onor del vero devo dire che alcuni dei miei maestri, in piena controtendenza, avevano già applicato l’intelligente e sobrio principio in medio stat virtus; continuarono semplicemente a fare quello che avevano fatto prima, senza alcun strepito o bercio rivoluzionario.
Ora capisco il senso delle parole di un paio di miei maestri: indicando la macchina segnalatrice delle stoccate con la punta dell’arma che avevano in mano, incalzavano Tutti riescono a far accendere quella lampada (magari, pensò ciascuno di noi!), ma una cosa è farla accendere e una cosa è come farla accendere. Non accontentatevi della gente che vi batte le mani perché avete toccato, se avrete toccato con una bella stoccate ve le batterà più forte.
Divenuto maestro di scherma, dopo tanti anni, ho capito a questo proposito una cosa: rispettare un canone estetico nella nostra disciplina non è un atto puramente formale, ma sostanziale.
Pensiamo ad esempio alla guardia: una cosiddetta bella guardia facilità la capacità di spostamento sulla pedana e potenzia al massimo sia l’attacco che la difesa.
Il maestro che ci rivolgeva quelle parole non aveva quindi la testa fra le nuvole per inseguire chissà quali ideali, bensì aveva i piedi saldamente posti a terra.
In fin dei conti credo che in effetti ogni schermitore sia sulla pedana il compromesso tra ciò che vorrebbe e dovrebbe essere e ciò che invece riesce ad attuare: è l’eterna lotta con i propri limiti che esalta ogni vero sportivo.
Lo scarrafone
L’altra faccia della luna, quella che sta dietro a quella dello bello stile, è quella dello scarrafone.
La fonetica della parola non fa presagire niente di buono, eppure possiede anche un qualcosa di vagamente ironico e sottile.
Chi non conosce il detto campano ogni scarrafone è bello a mamma soia?!
Gli occhi della mamma, è naturale, riescono anche a deformare la realtà e ogni figlio, magari brutto come un rospetto, diventa bello come un principe, anche senza il celebre bacio della principessa di turno.
Ma i maestri di scherma non sono madri pietose, anzi il più delle volte impersonano perfettamente il ruolo di padre-padrone, come quello del celebre romanzo di Gavino Ledda.
Ecco perché i loro allievi, adottati quali figli sportivi, non li devono fare minimamente sfigurare.
Un maestro mi disse un giorno: siete tutti mie creature e vi ho forgiato io.
Fortunatamente avevo già fatto catechismo per tre anni e riuscii a dimensionare questa perentoria affermazione.
Ma una cosa avevo capito: che un allievo si ricollega direttamente ad un maestro e, se un maestro oltre che bravo era anche fortunato, si poteva ricollegare un maestro ad un gruppo di allievi.
Era una questione di stile, come abbiamo visto nelle pagine precedenti.
Scarrafone era di conseguenza un insulto feroce, quasi un marchio impresso a fuoco sulla carne come il giglio di Francia con cui erano segnalate le donne di malaffare, come Milady nei tre moschettieri.
Il primo valore che veniva ricercato nelle sale di quei tempi non era sicuramente quello dell’affermazione agonistica; prima ce n’era un altro molto più importante e pregnante: quello di non essere scarrafoni.
Potevi non vincere un assalto e mettere solo poche stoccate, ma eri lo stesso gratificato dall’ambiente: non eri uno scarrafone.
Ma scarrafoni, purtroppo, si nasce e non esiste nessun lifting per rimediare.
E allora?!
Allora, niente! Chi non riusciva ad evolversi restava a tirare in sala e alle gare non andava; i compagni e gli amici facevano finta di nulla e volevano bene anche a lui, che era più sfortunato e scarrafone.
Veniva nascosto tra le mura domestiche e non faceva male a nessuno, anzi allenava gli agonisti che avrebbero avuto la sventura di incontrarne uno della stessa specie in pedana.
Queste erano le leggi morali non scritte, ma esistenti in buona parte delle sale da me frequentate in quel decennio di cui trattiamo.
Nei tempi in cui scrivo un’attività sportiva si fa esclusivamente per gareggiare nel 99,99999% periodico dei casi: tutti, dai bambini appena nati ai vecchietti arzilli (sigh!), hanno le loro gare, ci mancherebbe altro!
Ma le gare sono impietose e uno scarafone non ha speranza: batosta oggi, batosta domani… forse è meglio smettere, anzi smetto di sicuro.
E la scherma? Il suo fascino, i suoi interessanti molteplici aspetti tecnici e tattici, i compagni di sala?
Ai miei tempi c’era la possibilità di essere scarrafone e continuare a frequentare tranquillamente la sala.
Eppure di scarrafoni, che non sanno di esserlo o fanno finta di niente, alle gare di oggi se ne vedono a bizzeffe!
Il pubblico
E ci ostiniamo a dire che la scherma è uno sport spettacolare! Come si fa a insistere a crederci se non c’è mai un pubblico numericamente soddisfacente?!
Forse è meglio consolarsi col nome di una collana di testi che avevo all’università: multa paucis, molte cose per pochi.
Perché questa elezione ci dà così fastidio?!
Non siamo noi che non cerchiamo di attirare le persone alle gare, sono proprio loro che non ci vogliono venire.
E se provassimo con le catene?!
Anni fa un mio maestro, provocatoriamente, propose di invertire la situazione: non far pagare il pubblico per assistere alle gare , ma pagarlo per riempire gli spalti.
Fotografia del nostro pubblico: babbo (più diffusamente papà), mamma, nuovi genitori in caso di divorzio, sorelle e fratelli che ancora non possono uscire da soli, un paio di zii, un cugino incastrato, nonni senza carrozzina, un curioso, due che credevano che ci fosse una partita di pallacanestro, cani al guinzaglio (gatti niente perché non si portano a spasso).
Una desolazione!
Ma per fortuna ci sono i proverbi a soccorrerci: pochi, ma buoni.
Infatti sono tutti grossi intenditori: sanno perfettamente che il proprio protetto ha sempre ragione e, quando il presidente di giuria non gliela dà, vanno giustamente su tutte le furie e danno in escandescenze. Per me fanno benissimo; anzi farei arbitrare direttamente loro per stare più sicuri e tranquilli!
E il pubblico televisivo?
In occasione delle Olimpiadi dicono che davanti al video siano in milioni; ovvio e scontato in questa specie di Ramadan sportivo collettivo: ogni quattro anni i nostri azzurri garantiscono medaglie a carrettate.
Per i mondiali sempre titoli a bizzeffe, ma, essendo una manifestazione isolata, il richiamo per gli esterni alla nostra disciplina è vicinissimo allo zero.
Questa gente, questo pubblico, non vuole vedere la scherma, vuole vedere solo vittorie quasi sicure.
La scherma alla televisione la seguono solo gli schermitori (e non tutti); ma non lamentiamoci troppo, perché prima, nel famoso decennio, per vedere in video un fioretto, una sciabola o una spada doveva nevicare a ferragosto.
Zocca
Oggi il nome citato nel titolo vuol dire due cose: ridente ed accogliente paesino dell’Appennino modenese (da wikipedia) oppure, per gli appassionati di un certo tipo di musica leggera, glorioso paese natio del Vasco nazionale, Vasco Rossi, il cantante.
Ma per i più attempati come me il nome ha due significati: esserci stato con la scherma o averlo solo sognato.
Svelato subito il mistero: la Federazione verso la metà degli anni sessanta aveva pensato ad una specie di campo estivo per i piccoli schermitori, un posto dove stare al fresco e dove cercare di perfezionare la propria tecnica.
In quegl’anni, anche da quindicenne, i genitori ti tenevano buono con un gelato ed una coca – cola (e neanche tutti i giorni); figurati come poteva apparire per uno schermitore quindicenne andare da solo (senza genitori) e con altri schermitori a fare scherma d’estate in un posto magari distante da dove abitavi e che sicuramente non avevi mai visto.
Un’avventura all’Indiana Jones, anche se ancora il personaggio non era stato portato sugli schermi.
Ma i posti erano limitati e soprattutto di soldi in giro non ce n’erano poi così tanti.
Da qui il mito, altro che Atlantide!
Ore e ore a sentire i compagni più fortunati che avevano avuto l’occasione di andarci: dormire tutti insieme in camerate di una decina di letti, mangiare tutti i giorni e a tutti i pasti al restaurant (che poi in realtà era una trattoria alla buona), fare scherma, giocare o imparare a giocare a tennis e la sera libera uscita per tutti, come i militari. Scordavo: c’era anche una piscina per sguazzarci dentro.
Tra Disneyland e Zocca, avremmo tutti scelto Zocca!
Arrivò, finalmente, il giorno del mio turno e cominciò la mia personale avventura: da Firenze mio nonno Gino mi portò in treno sino a Bologna dove era fissato il raduno.
Salimmo sul pullman che ci stava aspettando e curva dopo curva salimmo sull’Appennino sino a Zocca.
Prime accelerazioni di battito cardiaco: in quel turno per necessità logistiche il corso faceva coabitare schermitrici e schermitori insieme e fortuna volle che ci fossero anche alcune compagne conosciute al Gran Premio Giovanissimi del precedente mese di aprile.
Ricominciarono i pruriti!
Della mia sala non c’era nessuno, ma la prima sera ci conoscevamo già tutti, senza alcuno sforzo e alcuna timidezza: eravamo tutti schermitori.
Alloggiavamo in una scuola (la cosa ci procurò inizialmente un certo effetto), la cui entrata si affacciava su una grande piazza (o almeno la ricordo tale); uscendo, sulla destra, c’era una lunga ringhiera con un vasto panorama, ma non saprei dirvi cosa si vedeva: a quell’età i panorami si guardano ben poco!
Dall’altra parte, lungo la strada principale del paesino, si trovava un bar con un flipper, due calcio balilla ed uno strano gioco consistente nel far entrare in una specie di canestro una pallina, sospingendola con dei getti d’acqua comandati da due pistoline laterali.
Questa era la nostra Las Vegas e lì finirono tutti i nostri capitali, fatta eccezione per qualche gelato e un paio di gazzose (costavano meno della Coca – cola!).
L’attività era divisa in due parti, con dei turni: chi faceva scherma la mattina il pomeriggio faceva un’attività alternativa e viceversa.
Sul modulo d’iscrizione mia madre mise una X sul corso di nuoto, così imparerai finalmente a stare a galla, mi disse; il tennis (l’altra attività opzionabile) lo farai un’altra volta.
Ma l’amore materno non poteva sapere che, per il gioco dei turni, il mio corso di nuoto cominciava alle nove del mattino.
Non preoccupatevi, per me alzarmi la mattina presto non è mai stato un problema, anzi.
La questione era la temperatura dell’acqua della piscina (ovviamente non riscaldata) di un paesino di montagna, sito press’a poco a 800 metri di altitudine.
Alle nove di mattina c’erano i ghiaccioli nell’acqua: roba da cappottino, guanti e sciarpa.
Pensai che non volevo fare la fine del Titanic o dell’Andrea Doria e chiesi di passare dal nuoto al più temperato tennis.
Sono lezioni collettive e siete tanti, mi disse il direttore del centro!
Fa lo stesso, mi affrettai a dire.
Comunque il quel corso ho imparato almeno due cose: che le palline da tennis sono tonde e che la racchetta non s’impugna dove ci sono le corde.
Nel juke – box gettonavamo spesso Sognando la California dei Dik Dik e tornando a casa mi comprai il 45 giri, rigato a bestia, ma ce l’ho ancora.
Durante il soggiorno a Zocca fui anche costretto a cambiare alcune delle mie secolari e apparentemente inattaccabili abitudini: la mattina, da sempre, facevo colazione con caffellatte e una vagonata di biscotti, possibilmente molto dolci.
Il corso però era un po’ spartano e contemplava solo un grosso panino già tagliato e spalmato con burro e marmellata.
Il primo giorno sdegnosamente lo rifiutai, ma dal secondo in poi fregavo anche quello del compagno del turno successivo al mio.
I quindici giorni del turno passarono purtroppo in fretta e salutandoci ci promettemmo reciprocamente contatti ed amore eterno.
Poi, come quasi sempre accade nella vita, probabilmente nessuno scrisse nulla a nessuno, neanche una cartolina.
Chissà come sarebbero andate le cose se già a quell’epoca avessimo avuto a disposizione face book, e – mail ed SMS al telefonino!
Venti anni precisi dopo ci sono tornato a Zocca; con i quattro quinti della mia attuale famiglia (in verità c’era anche mia figlia Carlotta, in gestazione): dovevo frequentare il corso di maestro di scherma, che veniva organizzato proprio lì.
C’era ancora la stessa scuola, la stessa ringhiera con il solito panorama (che ora più di una volta mi fermavo a guardare con mia moglie), lo stesso bar che però non aveva più quei giochi arcaici di una volta , ma solo quelle diavolerie a cui già si dedicavano per ore i miei figli.
La mia Zocca, quella che non scorderò, era quell’altra.
I professionisti e la scherma
So bene che sto entrando in un campo minato e quindi starò ben attento a dove mettere i piedi.
All’inizio del decennio che, sotto la mia guida, stiamo visionando insieme i professionisti erano i… maestri.
Chi, dopo essersi preparato, si presentava all’Accademia di Napoli e superava l’esame teorico – pratico entrava a far parte di questa schiera particolare e di conseguenza gli erano interdette tutte le gare ordinarie.
Agonisticamente c’era un annuale Campionato Nazionale Maestri alle tre armi e ogni tot anni un Campionato Mondiale.
Il ragionamento, tout court, era: guadagni con la scherma, sei un professionista; hai un tuo mondo, non puoi mettere più piede nell’altro.
Il criterio era quanto di più oggettivo e chiaro potesse esserci: più che iscriversi personalmente ad un concorso e passarlo!
Un mondo tutto a parte quello della scherma: niente pubblico pagante, pochi sponsor (da quando furono inventati), pochissimi soldi in giro.
Un professionista ci doveva essere e quindi beccavano chi, sicuramente più per passione che per le due palanche che gli davano, offriva il suo petto agl’allievi.
In effetti, almeno in Italia, maestri che potevano permettersi di vivere di sola scherma se ne potevano contare al massimo su un paio di mani; ce ne potevano essere anche altri, ma, di fatto, dovevano poi fare i barboni o i mantenuti.
Poi all’epoca c’era una partizione che, sbagliato o giusto che fosse, dava un diverso significato al termine professionista del mondo dello sport in generale.
Qui sabiniani e proculiani si dividono, ma, lo assicuro, il professionista appariva agli occhi dello sportivo praticante come uno che avesse venduto l’anima al diavolo, non per barattarla con l’eterna giovinezza come fece Faust, ma solo per denaro.
Bella forza, si diceva in giro, lui si allena tutti giorni e gli altri lavorano e studiano e quando fanno sport sacrificano il loro tempo libero.
Poi il dio denaro come al solito produsse le sue distorsioni: non più il singolo individuo, ma le società, i manager, gli sponsor intuirono l’incredibile business che lo sport poteva garantire loro.
La gigantesca macchina fu fatta partire.
Il gioco era fatto: ormai tutti vogliono (e chi può dargli torto!) essere quel giocatore di calcio, quel tennista, quel nuotatore o quel vattelappesca.
Gratis? E no!
Pagaci questo e quel biglietto profumatamente, abbonati a quel canale altrimenti non vedi più quello che ti piace, bevi quest’acqua minerale perché la beve il tuo campione preferito, compra e metti le mutande che mette il campione mondiale e… chi più ne ha, più ne metta.
Come appare oggi un professionista: sicuramente non più come un traditore di un ideale sportivo, ma solo ed esclusivamente come un ganzo (come si dice qui a Firenze) che vive da ganzo e fa il ganzo.
E nella scherma (e negli altri sport similari)?
Niente sghei da botteghini o da diritti televisivi, quindi?
Quindi posto fisso, quello che per tanti giovani lavoratori e solo un miraggio: esercito, aeronautica, carabinieri, polizia, guardia di finanza, forestale; mancano pompieri e vigili urbani., speriamo che aderiscano anche loro.
Discreta invenzione; invero solenne copiatura dai paesi dell’est che avevano escogitato lo stratagemma anni e anni addietro.
Intanto i maestri, che erano usciti per la porta, rientravano dalla finestra, essendo riammessi ad una serie di gare anche piuttosto importanti.
Se non l’avete ancora capito io sto dalla parte di chi, spensieratamente, fa attività sportiva, anche agonistica.
E se ce l’ho con il professionismo in genere è per il tipo di messaggio che lancia soprattutto ai più giovani o a quelli che hanno i genitori più cretini: vieni a fare sano sport, fai questo e fai quello e diventerai come me ed avrai tutto quello che ho io.
Ma se qualcuno poi continua ad illuderli che possono diventare questo o quel campione, ma chi resta su cento allievi in sala? Forse uno?
Attirateli pure con i campioni, ma poi fate scomparire questi specchietti per le allodole che non possono essere loro la unica e vera meta; cercate invece di accendere in loro la passione e l’amore verso la nostra disciplina.
Il campione verrà fuori comunque e le sale dovrebbero essere un po’ più affollate.
Fare lo sportivo professionista è invece solo un lavoro, sicuramente meglio di tanti altri, ma sempre lavoro.
Ora che mi sono tolto il sassolino dalla scarpa, sto meglio! Molto meglio!
Non voglio fermare il tempo e riportarlo indietro (magari potessi farlo!), vi sto solo raccontando come stavano le cose prima.
Lo spogliatoio
Quando c’era (non so se vi ricordate che vi ho detto che per anni mi sono cambiato nel bagno di una scuola) era una fortuna; se poi c’era anche almeno una doccia, la fortuna diventava incalcolabile.
L’armadietto personale per tanti anni non è stato nemmeno un miraggio, semplicemente perché non si pensava che il concetto dei depositi bagagli delle stazioni potesse essere felicemente applicato anche alle sale di scherma.
Quindi per lo schermitore molto spesso il bagaglio era obbligatoriamente al seguito: quando ero a Milano e le distanze erano abissali, il mio fioretto e la mia maschera (assieme a tutto il resto) devono avere percorso centinaia di chilometri di anda e rianda tra la mia cameretta e la sala di scherma.
In sala in verità c’erano le famose panoplie, cioè le strutture che permettevano di lasciare sul posto almeno maschera ed armi (rigorosamente incrociate), ma il deposito era molto rischioso, in pratica come lasciare incustodita sul tavolo una scatola di cioccolatini in una casa di golosi.
Ladri in sala di scherma non ne ho mai visti; cleptomani tanti, insaziabili e soprattutto impuniti.
Allora gli spogliatoi erano (ahimé) frequentatissimi dai maestri: entravano, facevano un giro di perlustrazione cercando chissà cosa, commentavano prendendo in giro qualcuno e uscivano.
Ne avevo uno dall’olfatto particolarmente sviluppato: evidentemente approfittava della lezione per usmarci tutti, ad uno ad uno e, se a suo naso non qualcuno non era a posto, soleva presentarsi nello spogliatoio con una sciabola per convincerlo a fare la doccia, spontaneamente!
Vi assicuro che è riuscito a farla fare anche a chi non aveva né accappatoio, né asciugamano; tanto sei già sudato, diceva.
Inutile dirvi che i più timorosi facevano la doccia anche prima di venire a scherma, si candeggiavano e si profumavano al mughetto!
Poi c’erano i timidi (mai fare intravedere ad un maestro di scherma di essere timido!), quelli che nello spogliatoio non si toglievano mai le mutande, quelle di marca CAGI per intenderci.
Stessa procedura: sciabola in mano, obbligo di strip tease di fronte a tutti (faccia rossa) e doccia, sempre con o senza possibilità di asciugarsi.
In quel periodo, con quel maestro, fummo senz’altro la sala più profumata del mondo!
Questo per noi ragazzi, in quanto ovviamente l’ingresso nello spogliatoio femminile era interdetto (almeno questo!) anche al maestro.
E le ragazze in questo erano fortunate, perché in quegl’anni di maestre di scherma ce n’erano forse due in tutta Italia, ma non le vedeva nessuno perché si erano già pentite di avere preso il titolo. Roba da mascoli, si dice a Catania.
Mi riaffiora un altro ricordo.
C’era un maestro fissato sul tempo che si poteva perdere nello spogliatoio: neanche fosse la finale dei centro metri olimpici, sembrava che tutte le volte che uno di noi entrava nello spogliatoio facesse partire un cronometro.
Ehi! Ma cosa fate là dentro?! Devo venire io?!
Ma cosa credeva facessimo?!
Sesso e droga erano ancora dei tabù, quindi poteva dormire fortunatamente tra due cuscini.
Chissà cosa aveva in testa. (forse un orologio a cucù).
So solo che qualcuno dei miei compagni, esasperato, veniva già con la divisa indossata sotto i vestiti (alla James Bond); ma non serviva a niente: tu! Dove sei stato questo tempo?!
Il decalogo dello schermitore
In questi tempi di completa e totale deregulation sociale, dove si arriva a mal tollerare anche la legge scritta, non dico gli usi e costumi, io vi parlerò o vi rammenterò che tempo fa qualcuno ebbe l’ardire di compilare addirittura il decalogo dello schermitore (chissà mai perché le regole comportamentali sono spesso dieci!).
Le regole appaiono in bell’ordine in un trattato del 1966, esaminiamole frase per frase, quasi parola per parla.
I Ricordati che sei il rappresentante del più nobile di tutti gli sport : esso affratella nello stesso ideale gli schermitori di tutto il mondo.
Si tratta dell’esordio e quindi siamo in presenza dell’enunciazione del valore più generale e omnicomprensivo.
Gongoliamoci un po’ per il fatto di essere il più nobile di tutti gli sport.
Intanto queste mie righe non so da quanti schermitori saranno al fin fine lette; certamente da nessun tennista, calciatore o sciatore.
Quindi concediamo pure qualcosa (e anche un po’ di più) al narcisismo: siamo tutti in famiglia.!
II Pratica il tuo sport con disinteresse ed assoluta lealtà.
Il concetto di disinteresse cozza clamorosamente con il comune sentire e vivere dei giorni nostri, ma abbiamo sempre la scusa che ad inventare il professionismo nella scherma, come abbiamo ricordato poco sopra, non siamo stati noi; e per poter competere con queste birbe, obtorto collo, abbiamo dovuto adeguarci. La colpa è soprattutto degl’altri e in minima parte nostra.
Anche il concetto di assoluta lealtà oggi non è solo un impegno ideale e formale: ci sono le misure antidoping anche per noi e ci sono i cartellini multicolori per le infrazioni commesse sulla pedana.
III Sulla pedana e fuori comportati da gentiluomo, da sportivo e da uomo sociale.
Questa è l’auspicio di maggiore portata morale, perché prevarica il comportamento sportivo, lo oltrepassa e raggiunge la sfera sociale dell’uomo – atleta.
E’ un ideale altissimo, che pretende e addita lo schermitore come quasi un superuomo niciano, ovviamente nel senso buono del concetto: un modello decisamente e tristemente ormai purtroppo fuori moda.
IV Non discutere di scherma se prima non hai imparato la scherma ed i suoi regolamenti.
Come cambiano i tempi ed i costumi: all’epoca la regola aurea era stata pensata e trascritta esclusivamente per gli schermitori, oggi vale invece soprattutto per i papà, le mamme e gli accompagnatori!
Ma questo dipende anche dall’atteggiamento dei maestri, che sempre e comunque dovrebbero garantire (magari con una fidejussione) per il comportamento di allievi e genitori.
In primis pretendendo un limite alla manifestazione di un pur lecito dissenso; in secundis facendo letteralmente imparare quasi a memoria ad entrambi il Regolamento di gara.
V Impara a perdere con onore; a vincere con dignità.
La prima parte della frase, diciamolo pure, è abbastanza scontata: a nessuno piace perdere e l’impegno profuso sempre e comunque è un atto dovuto alla propria dignità personale. Si deve cercare di combattere sempre al limite delle proprie possibilità, andando magari anche oltre (ultra vires dicevano i nostri avi romani).
La seconda parte della frase, impara a vincere con dignità, mi fa venire letteralmente la pelle d’oca.
Penso agl’innumerevoli gesti sconsiderati di gioia con cui oggi il vincitore di un qualcosa (di un qualsiasi qualcosa, magari anche di una gara di sputi!) saluta la sua vittoria.
Volti trasfigurati in smorfie che terrorizzerebbero una pantera, pugni chiusi minacciosi anche per un campione di pugilato, urla raccapriccianti da film sui licantropi.
E tutti giù ad imitarli, grandi e piccini, anche nella ormai citata gara di sputi! (Ormai l’ho detto e fatemela passare!)
Cosa deve quindi esprimere un atleta vittorioso? Contrizione, tristezza, rammarico, pentimento, forse compartecipazione al dolore dell’avversario che ha appena sconfitto?
Ma per piacere!
Deve esprimere gioia, gioia pura e può farlo come più gli aggrada: capriole degne di un saltimbanco, gesti folli che farebbero impallidire la fantasia di un giullare, baci – abbracci e bacini sul collo dei compagni; ma sempre, comunque col sorriso sulle labbra.
Sai l’atleta deve essere aggressivo, mi dicono.
Certo, capisco. Anzi perché non lo tieni senza mangiare per un giorno prima della gara, come fanno i cacciatori con i loro cani?! Da incazzati rendono di più!
Pensandoci bene, con i tempi che corrono e con gli esempi che abbiamo sott’occhio, vincere con dignità e senz’altro più difficile che perdere con onore!
VI Rispetta in ogni occasione il tuo avversario, chiunque esso sia, ma cerca di superarlo in combattimento con tutte le tue energie.
Siamo ora proprio al centro della questione: il rapporto con l’avversario, contenuto attorno al quale ruotano tutte le altre considerazioni.
La lotta deve essere totale, ma in tutti i casi e in tutte le situazioni va affrontata con serenità e fermezza, senza alcun distinguo, né di superiorità, né d’inferiorità.
Stiamo parlando della cosa più importante, sotto certi aspetti anche più importante del risultato finale, siamo all’essenza di ciò che sta accadendo sulla pedana, siamo cioè al puro contendere.
VII Ricordati che sino all’ultima stoccata il tuo avversario non ha ancora vinto.
Questo è un richiamo esplicito al fatto che lo schermitore deve essere un combattente sempre e comunque (e chi meglio di lui!): la situazione di punteggio, pur da interpretarsi tatticamente, non deve costituire nessun tipo d’orpello.
Anzi uno svantaggio deve produrre un effetto positivo: maggior ragionamento, raccolta delle residue forze fisiche e psichiche, maggiore incisività.
L’avversario che è in testa deve trovare la strada in salita e non in discesa.
VIII Accetta serenamente la sconfitta piuttosto che approfittare di una vittoria ottenuta con l’inganno.
Rieccoci ancora al nocciolo della questione psicologica, l’esito dello scontro.
Perdere non è un dramma, ma un evento possibile, anzi ricorrente visto che nessuno mai, anche i grandissimi campioni, vince o vincerà sempre.
Non credo che al mondo esista qualcuno che non desidererebbe vincere quando compete per un qualcosa; ma questo ha valenza per il prima e il durante, cioè mentre combatte per affermarsi; per il dopo non esiste altro che accettare serenamente l’esito della contesa. (che altra alternativa può esistere).
Certe volte si usano sostanze dopanti o addirittura il denaro per falsare l’esito delle gare: mai (o quasi) nessuno che si penta e che ammetta il tradimento di certi valori.
Chi è beccato in un illecito si difende strenuamente anche contro l’evidenza dei fatti e trova anche coorti di sostenitori, che invece di condannare la cosa e prendere da lui giusta distanza, lo difendono a spada tratta anche non sapendo nulla della cosa o avendo come fonti quelle interessate e corrotte.
Sono le persone, le Società sportive, i tecnici, le Federazioni, l’opinione pubblica che devono emarginare questi furfantelli, che per soldi (realizzano una vera e propria truffa!) tradiscono ciò che tutti dovrebbero difendere come prezioso bene comune: la lealtà sportiva.
IX Non salire sulla pedana con le armi difettose o con la bianca divisa in disordine.
Questo è un chiaro ed evidente appello (o monito) per i tecnici delle armi e per le mamme.
X Onora, difendi e rispetta il tuo nome, il prestigio del tuo maestro, i colori della tua società, la bandiera del tuo Paese.
Siamo arrivati al fanalino di coda del decalogo dello schermitore, quello che forse denota maggiormente l’epoca in cui fu concepito e scritto.
Invero i valori per cui uno schermitore si batte sono espressi in una specie di crescendo rossiniano per culminare addirittura nel concetto di Patria.
Ho volentieri glossato con mie personali riflessioni tutte le varie frasi che compongono questa specie di Regola Morale; ora sta a voi lettori giudicare quali di esse siano ancora attuali e degne d’applicazione sulle pedane delle sale e dei luoghi di gara.
La dieta dello schermitore
Che l’ambiente della scherma sia stato per decenni fortemente conservatore è cosa di dominio pubblico; che poi la Rivoluzione abbia ecceduto, altrettanto.
Sono i famosi strappi della storia, che fanno sbandare pensieri, persone e cose, incuranti troppo spesso della saggezza e della verità.
E cosa c’entrano questi profondi pensieri con la dieta di noi schermitori?!
C’entrano, C’entrano!
Quando ero giovane schermitore non c’era alcun dubbio: la dieta era quella del pugilatore, cioè bistecca al sangue ed insalata.
Tempi duri per uno come me che odiava (e odia tuttora) la carne ed ama invece, agli antipodi, i farinacei.
Ma per fortuna erano solo parole che qualche maestro pronunciava per dire qualcosa perché non si scoprisse che di dieta non se ne intendeva proprio nulla!
E allora…mi raccomando, bistecca ed insalata! E pochissima pasta!
Si! Si! Poi a casa ognuno faceva come voleva o almeno come gli permetteva l’arte culinaria della propria mamma.
Poi siamo italiani e all’epoca per giunta non troppo ricchi: quindi pasta e pane, pasta e pane!
Quelle cose lì facciamole fare ai pugilatori, che tra l’altro sono anche suonati!
Mia madre, laureata in farmacia, mi consigliava di mangiare zucchero durante le gare ed io lo facevo sia per ubbidire alla mamma, sia perché sgranocchiare zollette di zucchero mi piaceva tanto, mica per avere più energie sulla pedana!
Poi a qualcuno venne in mente di sbirciare la tavola dei cuginetti degli altri sport e si accorsero di quanto eravamo indietro in questo settore.
Ma come non bevi tra assalto e assalto?!
Certo che non bevo il maestro mi ha detto che l’acqua mi sciaborda poi nello stomaco. E me l’ha vietata, almeno tra assalto e assalto.
Ma no! Dai, su bevi un po’.
E beviamo, se lo dici tu!
Lo zucchero va bene, ma il sale?
Il sale?!
Si, lo zucchero perché il glucosio entra subito nel tuo circolo energetico; il sale per prevenire i crampi.
Ma io non sapevo nemmeno cosa fosse un crampo e il sale mi faceva proprio schifo.
Fa lo stesso, previeni!
Senti se invece di prendere due zollette di zucchero ed una compressa di sale, ne prendessi solo una di zucchero funzionerebbe allo stesso modo?
A ingenua domanda, nessuna risposta.
Poi il cronometro alla mano.
Se tra prestazione e prestazione c’è un lasso di tempo X allora bistecca ed insalata (sempre loro!).
Se invece il lasso di tempo è minore, diciamo Y, allora pastasciutta (possibile?!).
Se non c’è nessun istante X o Y allora zucchero e sale (mancano solo sale ed olio, poi siamo a posto!).
Scusate, una domanda imbarazzante: se devo andare in bagno, posso fare di testa mia?
E allora?
Allora perché tutto questo casino? (Si! Casino). Mangia, non mangiare, bevi, non bere, questo sì, questo no, questo è troppo, questo è troppo poco.
Io il dietologo lo farei fare alle mamme, almeno a quelle di una certa epoca, quando non c’erano merendine e intrugli vari, ma solo pane burro e zucchero, pane burro e sale (vedete che se ne intendevano già di calorie e di crampi!) e acqua della cannella o delle fontane dei giardini pubblici.
E poi le mamme, di solito, vogliono bene ai propri figli e stanno molto attente alla loro salute, fisica e anche a quella mentale.
Le categorie nella scherma
Subito dopo quelle aristoteliche per noi schermitori erano fondamentali le categorie. federali.
Tu di che categoria sei?
Ed ecco l’orgoglio, la vergogna o la speranza: di prima, di seconda, di terza o addirittura N.C.
N.C.?!
Si! Non Classificato.
Ma come nemmeno classificato?! Sei stato alla gara, hai partecipato e non ti hanno classificato!?
Proprio così.
Scusa, non capisco! Anche se sei arrivato ultimo, sarai o non sarai l’ultimo classificato!
Senti, non rigirare la spada nella ferita (si fa così per dire!),a me hanno detto che sono un non classificato.
Era una palese ingiustizia, oltre che una cosa logicamente incomprensibile, per cui, sull’onda di egualitarismo che caratterizzò i primi anni settanta, fu cancellata questa vergogna: tutti furono promossi in quarta categoria e da quel giorno vissero felici e contenti (beati loro!).
Tanto non conta niente di che categoria sei, conta come tiri! Mi diceva sovente un maestro.
Sai all’avversario che gliene frega se sei così o cosà! Non se la fa mica addosso solo guardandoti!
Ma solo i maestri ostentano saggezza (ed anche loro non tutte le volte e in tutti i casi); gli allievi invece son quasi sempre tutti bischeri e preferivano ostentare la propria categoria, profferta quasi come preziosa apposizione del nome alla foggia di un titolo nobiliare, (conte, marchese, duca, addirittura principe).
In verità, prima o poi, tutti diventavano terza categoria: bastava una giornata fortunata e qualche avversario magari col mal di pancia o col mal di denti e riuscivi ad entrare nei prima 24 dei campionati nazionali. Non dovevi certo infilare con l’arco le dodici teste di scure come aveva fatto Ulisse!
Ma il passaggio in terza categoria non era un riconoscimento perpetuo, perché nei due anni successivi dovevi conseguire altri risultati che ti consentissero di mantenere la posizione. Una specie di posteggio col parchimetro dove ogni tanto è necessario ributtarci dentro una monetina.
E se non avevi più spiccioli?
Se non confermavi la terza categoria, elementare: retrocedevi, da buon gambero, alla quarta.
Non era così drammatico come ci fanno vedere le squadre di calcio di serie A, ma la cosa non era certo piacevole: una diminutio capitis bella e buona.
La gente ti salutava lo stesso, ma capivi dal tono che era successo qualcosa: eri appunto ridiventato quarta categoria.
Tanto l’anno prossimo penso proprio di rientrare, proclamavano ottimisticamente quasi tutti; anzi così ho più chances nei quarta categoria e posso fare una bella gara e intanto in compagnia della celebre volpe guardavano il grappolo di splendida uva che pendeva sulla loro testa, troppo in alto per poter essere raggiunta.
Ma in fin dei conti e al di là dell’ostentazione, la ragione l’aveva il maestro poco sopra citato: non importa di che categoria sei, l’importante è cosa riesci a fare in pedana!
Oltre la terza, ovviamente, c’era la seconda categoria, ma riuscire ad entrarci significava smentire la famosa parabola del cammello e della cruna dell’ago: infatti solo il campione dei terza categoria, cioè colui che vinceva la relativa gara nazionale, riusciva in quest’impresa. Quasi da eroe omerico!
C’erano invero anche altre gare che ti potevano permettere il passaggio di categoria, ma erano tutte altrettanto se non maggiormente proibitive: tipo preolimpioniche (dove dovevi incontrare in un maxi girone all’italiana tutti i papabili nazionali) o gare internazionali. (dove oltre ai tuoi connazionali, dovevi sconfiggere anche Galli, Parti, Ispanici e barbari vari).
Dopo (o meglio prima) dei seconda c’erano i prima categoria, che popolavano in minuta schiera l’Olimpo schermistico.
Roba da vertigine! Gente che brandiva e muoveva le armi meglio di Bruce Lee.
Tra loro, ai margini della galassia schermistica, gli N, dove N stava per nazionali; coloro che vestivano la maglia azzurra, color del cielo.
Insomma in conclusione una bella e variegata gerarchia: dei, semidei, uomini normali e iloti (più semplicemente schiavi).
Invero si poteva anche ipotizzare in basso un altro raggruppamento; quello più infimo e negletto, una categoria solo ipotizzata da qualche vecchio maestro, che di tagliente non aveva la lama, ma anche la lingua: la categoria di quelli che avevano paura di andare alle gare. Loro erano i peggiori!
Oggi come sapete è tutto più semplice (almeno visivamente): abbiamo scopiazzato dal tennis e dal golf e con il ranking (dire classifica non è abbastanza fico!) ogni dubbio e incertezza sono cancellate: la matematica non è un’opinione.
Quindi non più domande del tipo: Ma tu di che categoria sei? Ma solo ed esclusivamente del tipo: tu che numero sei?
Forse era meglio prima: sparavi orgogliosamente un terza categoria e salvavi capre e cavoli; del resto chi sapeva quanti fossero gli schermitori in totale. Nessuno.
Oggi, magari,ti tocca dire sono il 175° e il numero ti butta un po’ giù.
Poi c’è chi per consolarsi dice subito dopo: Si, 175°, ma su 552.
Ah! Si?! Bene, bravo rispondi ed in cuor tuo provi per lui tristezza!
Poi, per essere precisi ed esaurienti, c’erano anche le categorie federali per età, che, grosso modo, ricalcavano quelle odierne.
E’ cambiato solo qualche nome qua e là per smania linguistica.
Le bambine ed i maschietti, invero termini troppo da nursery, sono diventate le prime lame; mentre i giovanetti ora sono denominati cadetti (probabilmente sotto l’influsso di qualche accademico militare o più semplicemente di letture di Dumas padre).
Per dire il vero c’è anche un’attività definita preagonistica (cosa vuol dire preagonistica se c’è già l’agonismo?!): qui gli schermitorini sono denominati pulcini, nome che indubbiamente intenerisce, ma che fa anche tanto pollaio!
Il saggio di fine anno
Qualche maestro un po’ troppo tradizionalista aveva un pallino, una mania che esplodeva in tutta la sua virulenza verso maggio / giugno: il saggio di fine anno.
La dea bendata mi ha preservato abbastanza dal partecipare in modo attivo a questo tipo di spettacolo, per cui la mia esperienza si limita ad un paio di occasioni, che peraltro mi si sono incastonate con contorni ben nitidi nella memoria.
Tutto filava liscio sino alle ultime gare di calendario, che come ho già avuto occasione di dire altrove erano abbastanza sparute e rare.
Cosa fare, come riempire tanto spazio culturalmente vuoto, come coinvolgere tutti?
Ma si! Il saggio collettivo.
Cominciavano quindi le grandi manovre: divisione in drappelli, gruppetti e sotto gruppetti, donne da una parte e uomini dall’altra (come prima nelle chiese), fiorettisti lì, sciabolatori là e spadisti laggiù per ultimi (tanto sono i più alti!).
Entrate a tempo, gestualità ritmica, coreografia d’insieme: in pratica non era scherma ma qualcosa di più vicino ad un minuetto settecentesco con le armi in pugno.
La musica miracolosamente non c’era perché all’epoca i maestri erano grosso modo tutti dei primi del novecento ed il fonografo (quello col trombone al posto degli attuali altoparlanti) che utilizzavano era difficile da spostare.
Figuranti e mimi! Non facevamo nulla di quello che ci piaceva fare, cioè tirare di scherma, ma venivamo usati solo e semplicemente come fantoccini.
Le mamme circa la pulizia delle divise ed affini erano state messe in preallarme dal maestro in persona e, colpite nel loro amor proprio, spesso per strafare le profumavano con acqua di colonia.
Il meccanismo era super complesso e variegato: un paio di coppie dovevano andare avanti e indietro con una cadenza di alcuni passi, altri, lanciando un grido, dovevano andare in affondo, altri ancora dovevano battere ritmicamente il ferro tra di loro.
Giorgio Strehler si deve essere formato a questi saggi: in effetti so per certo che esiste tutt’ora il club Piccola Scala di Milano!
Il pubblico era costituito soprattutto dalle mamme, che all’epoca stavano quasi tutte a casa a fare le casalinghe, da qualche raro babbo, libero professionista o dipendente assenteista, da fratellini sorelline (quelli maggiori, dopo la prima volta, si rifiutavano di venire).
Eravamo arrabbiati perché lo spettacolo lo volevamo fare a nostro modo, cioè tirando di scherma!
Ma i saggi sono saggi e hanno una loro valenza. Estetica.
Si! Nella bella Epoque!
Oggi, per la fortuna dei giovani schermitori, questi tipi di spettacolo (fortunatamente) non esistono più: le lotte, che abbiamo portato avanti noi giovani di allora, hanno dato i loro frutti!
Mi si consenta un piccolo gioco di parole: è stato saggio eliminare i saggi!
Le accademie
Visto che stiamo parlando d’intrattenimenti schermistici è doveroso soffermarsi sulle cosiddette accademie.
Al giorno d’oggi si preferisce pragmaticamente andare al sodo, si fa sempre sul serio e l’agonismo la fa da padrone, ovunque.
Qualche volta ci sono delle esibizioni, ma onestamente hanno usato questo termine nuovo e non se la sono sentita di usare il termine Accademie; e questo non perché il vocabolo fosse arcaico, semplicemente perché non sono la stessa cosa.
Le accademie erano davvero un’altra cosa, una cosa specialissima; in palio non c’era nulla di venale, ma qualcosa di altrettanto (se non di più) prezioso: il mostrare la propria abilità canonica nel tirare di scherma.
L’accademia era un filtro della realtà: il toccare l’avversario si dà per scontato (facile no?!), quello che si ricerca invece più attentamente è la tipologia del colpo e la sua modalità esecutiva.
I valori che i due contendenti cercano di esprimere in pedana, pur mantenendo un laconico sapore agonistico, sono di assoluto valore estetico, ovvero di rispondenza innanzitutto a posture e canoni predefiniti.
Scomodiamo pure il termine arte; tanti altri in tanti altri settori abusano a piene mani di questo termine!
Lo scontro viene svolto con il braccio armato verso l’avversario, ma gli occhi della mente sono rivolti invece al cielo, all’ideale ricerca del bello, del perfetto (o quasi) e, di conseguenza, del difficile da realizzare.
Durante un’accademia non occorre vincere, lo scopo è quello di creare un istante magico irripetibile con la propria lama ed il proprio corpo; lo scopo è quello di fare spettacolo, puro spettacolo.
E spettacolo si può fare a diversi livelli, indirizzandolo a diverse qualità di spettatori; non occorre essere eccelsi, essere campioni o giù di lì.
Ogni pubblico, in genere, ha i suoi accademici: si tratta solo di impersonare non se stessi, ma la scherma, attraverso la sublimazione, ognuno entro le proprie capacità, delle varie posture e tipologie di azioni schermistiche.
Cosa importa se sei in un esclusivo salone pieno di signore eleganti ed ingioiellate, oppure sei in uno stand sportivo inserito in una manifestazione pluridisciplinare?
In quegl’istanti tu sei l’alfiere di uno degli sport più affascinanti della storia e deve sempre e comunque dare il meglio di te.
Devi esprimere eleganza, non funzionalità; devi affascinare, non toccare l’avversario per forza.
La pedana in queste occasioni diventa una specie di palcoscenico: infatti essa non è più un’arena in cui combattono gladiatori pronti a vedersi il pollice rivolto in alto o in basso a seconda della vittoria o della sconfitta. I valori in gioco sono di ben altra natura!
E questi discorsi mi fanno venire in mente un’altra chicca, una cosa che probabilmente agl’occhi dei giovani d’oggi richiederebbe da parte mia un solenne giuramento circa la sua veridicità.
Sto parlando dei premi allo stile che in determinate gare venivano assegnati.
Avete letto bene, stile!
C’era una giuria a latere che aveva l’incarico di seguire la gara non sotto l’ottica pragmatica delle vittorie e delle sconfitte, ma anche e soprattutto da un punto di vista di eleganza e, appunto, di stile nel tirare di scherma.
Elegante (ovvio!) non perché la divisa bianca fosse fatta su misura o bombasse alla perfezione, non perché fosse candeggiata al meglio!
Eleganti dovevano essere le posture e le movenze di chi meritava il premio: equilibrio del corpo, bella guardia, leggerezza di passo, compostezza d’affondo, parate e risposte pulite, svincoli da manicure!
Beh! Lo ammetto! Forse ho enfatizzato un po’ troppo!
Comunque in questo modo, si poteva sperare di vincere il premio per lo stile migliore.
A mio modo di vedere, così facendo, si additavano contemporaneamente allo schermitore due poli guida d’ispirazione: quello pragmatico dell’ottenimento immediato del risultato (cioè della stoccata) e quello ideale della ricerca estetica (appunto lo stile).
Il Gran Premio Giovanissimi
Per quelli della mia età il Gran Premio Giovanissimi era una specie di Olimpiade, un’Olimpiade del tutto particolare perché era una gara già oceanica a quei tempi quando in quegl’anni gli schermitori erano tre o quattro gatti, scusate, gattini.
Tutta la preparazione dell’anno convergeva in questo appuntamento che laureava i Campioni nazionali di tutte le categorie dai maschietti o bambine che fossero, transitando dalla categoria giovanissimi, alla categoria degli allievi, gli anziani del gruppo.
Invero prima del periodo pasquale (il Gran Premio si teneva verso Pasqua a Roma) si dovevano disputare i campionati regionali che servivano, oltre che ad assegnare i vari titoli, sia di allenamento preparatorio, sia d’indicazione per la super gara nella capitale.
Già per quei tempi viaggiare era qualcosa, poi andare in specie a Roma era di più; era fantastico pensare che da tutta Italia, sacca sulle spalle (proprie e non di quelle del babbo, come mi capita di vedere spesso oggi) tanti bambinetti e ragazzini andassero a cimentarsi in una gara così grossa, la più grossa per loro in assoluto.
I genitori all’epoca erano rarissimi, i maestri avevano ancora molto stile e di conseguenza i presidenti di giuria non erano minacciati o presi in ostaggio psicologico da nessuno.
La prima edizione a cui partecipai nel lontanissimo 1963 fu disputata in un circolo della città, probabilmente il Club Scherma Roma, ma ho fatto anch’io in tempo a calcare quello che sarebbe stato per tempo immemore la cattedrale di questi campionati: il palazzetto dello sport all’EUR.
A quell’epoca tutto era di dimensioni più ridotte e non esisteva il gigantismo di oggi: per cui arrivare in taxi all’Eur in pratica poteva essere paragonato ad un atterraggio su Marte!
Eppure non venivamo dalla campagna, come si dice maliziosamente qui a Firenze.
Il palazzetto era (e speriamo che lo sia ancora) di forma circolare e le pedane, messe a raggiera, regalavano un particolarissimo effetto geometrico; tutte tranne una, quella della finale.
Il colpo d’occhio era di grandissimo effetto ed entrando, pur piccolo dente di un gigantesco ingranaggio, ti sentivi protagonista solo per il fatto di esserci dentro, risultato a parte
Mitico sogno la pedana della finale: poterci salire sopra, voleva dire di essere riusciti ad entrare nella élite.
Coppe, medaglie, premi vari; sì, sì! Ma la cosa più importante era un’altra: il titolo nazionale che durava tutto un anno.
Sogno, ma anche preoccupazione: a quei tempi la pedana numero uno, quella appunto delle finali, era sopraelevata vari centimetri da terra e, pur essendo larga i due metri regolamentari prescritti (e non i corridoi usati nelle gare attuali!), aveva quindi ai due lati due piccoli baratri.
Poi a peggiorare le cose c’era il solito bischero (sì, bischero!) di un mancino, che ben istruito dal suo maestro, per le sue migliori opportunità si piazzava su uno di questo baratri e lì giocavamo a fare gli equilibristi.
Ordine! Quello che a distanza di anni mi ricordo era l’ordine che regnava a questi tipi di gara.
Bella forza, penserà qualcuno, eravate tre gatti (o gattini come ho detto poco sopra)!.
Sicuramente questo è un fattore oggettivo, ma non basta da solo a spiegare l’ordine a cui mi riferisco: non era solo ordine riferito alla densità delle persone, ma un’altra cosa, più grandangolare.
La gente urlava di meno nel senso di tenere il volume della voce più basso (e questo capitava nel mondo e non solo nella scherma); la contestazione, già di per sé rara, era contenuta e più che urbana.
Ma torniamo al Gran Premio Giovanissimi, che forse è meglio!
I più fortunati che avevano la gara in un certo giorno o tutt’al più nei giorni limitrofi potevano sfilare, si sfilare come alle Olimpiadi: c’erano tanti cartelli, tale circolo o tal’altro, sala qui o sala là e tutta la delegazione dietro a marciare e a disporsi sulle pedane.
Chi ha partecipato a questa gara non se lo può scordare!
Il gran premio giovani e il dopo
Gli anni passarono (i giovani vogliono sempre mettergli fretta!): ai ragazzi la voce diventò sempre più baritonale e i peli spuntavano scimmiescamente da tutte le parti; alle ragazze fioriva il seno e cominciarono a guardarci in un modo strano (noi uomini, lo dice la scienza, maturiamo dopo).
Prima entrammo per i soliti due anni usuali nella categoria dei giovanetti (quelli che non sono ancora né carne, né pesce); poi spiccammo il volo verso l’ultima categoria per età, quella dei giovani. Erano gli ultimi tre anni, poi anche la Federazione ci avrebbe considerato uomini fatti.
Eppure in quel periodo per lo Stato si diventava maggiorenni a ventun’anni e quindi ufficialmente eravamo ancora dei bamboccioni, coccolati dalle mamme.
Maturavamo dopo (almeno lo dicevano loro), mentre oggi si matura prima; evidentemente c’è più sole!
Intanto gli anni di scherma si accumulavano sulle nostre spalle e ci avviavamo speditamente allo nostro zenit sportivo.
Ora alle gare non solo non c’erano più i nostri genitori, ma non c’erano più neanche i maestri: niente al confronto delle tre celeberrime guerre d’indipendenza.
Sentivamo che il mondo era nostro; ma lo abbiamo preso?
Chissà cosa vuol dire prendere il mondo!
Una cosa la sapevamo, perché era sotto i nostri occhi, ma, forse involontariamente, non la volevamo mettere bene a fuoco: i nostri compagni di sala più grandi di qualche anno mano a mano non li vedevi più, sparivano.
Chi andava a finire l’università in un’altra città, chi cominciava a lavorare, chi si sposava.
Sposava?!
Io no! Io non smetterò mai di fare scherma.
Questo non fu solo un mio pensiero, ma ebbi il coraggio e impudico di ripeterlo a parole più volte di fronte a testimoni!
Delirio d’onnipotenza!
Mi vien da ridere (o da piangere) a ripensare alla mia ingenuità.
Il campionato sociale
Forse ci siamo rattristati un po’ troppo e soprattutto inutilmente (fugit invida aetas, ineluttabilmente).
Rituffiamoci ancora per qualche breve riga nella scherma fatta e non parlata: potevamo scordarci i campionati sociali?!
La sale di scherma hanno una configurazione molto simile ai pollai: c’è sempre qualcuno che ha la vocazione di fare il gallo o, a seconda dell’età, il galletto.
Naturalmente più il circolo è grosso (proprio come accade appunto per un pollaio) più galli e galletti possono coesistere: nella fattispecie di fioretto, di sciabola, di spada, seniores, juniores, uomini, donne.
Ed ecco l’occasione più opportuna per le loro conferme: i tornei sociali, ovvero lotte intestine per proclamare i migliori del gruppo.
Ce n’è quindi per tutti i gusti e per tutte le capacità: è la panacea di tutte le speranze.
Quello che ricordo con maggiore rimpianto veniva disputato in una sala milanese, non molto grande invero, ma frequentata da veri appassionati: nessuno mancava all’atteso appuntamento di fine anno e il girone all’italiana che veniva disputato era veramente oceanico; occorreva più di un centinaio di assalti, ognuno dei quali combattutissimo, per concludere tutti gl’incontri tra i più di venti partecipanti.
Si cominciava quindi la domenica mattina abbastanza presto ed essendoci solo tre striminzite pedane si finiva la sera tardi, a buio.
Tutti erano soddisfatti, dal primo classificato all’ultimo: era come aver partecipato consecutivamente alla battaglia di Gaugamela, diZama, a quella di Roncisvalle, a un paio di Crociate, a Curtatone e Montanara.
Stanchi, stanchissimi, praticamente vuoti d’energia, ma ripagati dal viso soddisfatto del maestro, che, ancora una volta, era riuscito nell’impresa di far concludere tutti gli assalti.
E la sala aveva il suo nuovo Campione, il suo bel gallo.
Amarcord
La memoria, sovente, conserva nei suoi reconditi e misteriosi cassettini particolari e minuzie, che ti meravigli di ritenere ancora dopo tanto tempo. Scordi magari cose ritenute importanti, ma non queste briciole della tua vita.
Il fatto è, credo, che certe cose procurino a tutti noi un’enorme effetto proustiano della realtà: fugaci immagini, brevissimi suoni, impalpabili sensazioni.
Il mio primo amarcord mi riporta a quel giorno, un giorno qualsiasi, in cui il maestro ci chiamò e ci distribuì la nostra prima tessera d’appartenenza alla Federazione Italiana Scherma.
A quell’epoca non c’erano materie plastiche o affini, per cui il documento era poco più di un cartoncino Bristol, di un bel color giallo acceso su cui le scritte in nero risaltavano quindi ancora meglio; l’enorme spreco dell’usa e getta dell’odierna società non era stato ancora codificato, per cui, in ossequio ad un opposto principio, la tessera contemplava numerosi spazi dove poter apporre di anno in anno i bollini futuri, una specie di francobolli senza dentini con impresso i numeri dell’anno in corso.
Quel pomeriggio tornammo tutti a casa ancora più orgogliosi di essere schermitori: eravamo, come diceva la scritta, atleti.
Una reliquia religiosa non sarebbe stata portata con più rispetto e devozione!
Un paio di anni dopo (evidentemente mettevano alla prova i neoiscritti) arrivò anche il distintivo; roba da svenimento: armi, tricolore e scritta, tutto su sfondo blu oltremare.
Una sciccheria da veri esibizionisti: la tessera non poteva essere sventolata sotto il naso del primo venuto, ma il distintivo sì!
Piazzato in bella mostra doveva suscitare scalpore ed emozione in coloro che (finalmente) si rendevano conto di avere davanti a loro uno schermitore, sì uno schermitore.!
A quell’epoca per portare il distintivo FIS occorreva necessariamente indossare una giacca, nella cui asola poter incastrare la parte posteriore del distintivo; quindi roba da prima comunione, matrimoni e cerimonie affini.
Una desolante frustrazione!
Per nostra consolazione, almeno un decennio dopo, la scienza avrebbe scoperto il comodo e universale metodo per fissarlo al tessuto con puntina e molla d’incastro; ora il distintivo, a monito delle genti, potevi metterlo anche sui golf e sulle camice.
Ed ora sotto con un altro amarcord: il giornalino della Federazione.
Pur asfittico e quasi incolore, per noi assurgeva all’importanza degli articoli di fondo di un Times e per i servizi fotografici alle immagini di un numero di National Geographic.
Date le sue dimensioni, sporgeva clamorosamente dalla cassetta della posta, per cui se quel giorno toccava a noi ritirare la corrispondenza, della sua presenza ce ne accorgevamo anche da qualche decina di metri e qualche corsetta l’abbiamo fatta tutti per vedere certificata qualche nostra bella gara o per ritrovare almeno il nostro nome tra gli eliminati, magari anche al primo turno.
Ricordo che per un certo periodo i risultati agonistici erano pubblicati in fondo al giornale in un inserto color verde (credo a simbolo ironico della Speranza).
Era il nostro piccolo mondo (proprio piccolo!), dove ci prendevamo la rivincita degli odiosi spazi riservati a quasi tutti gli altri sport più noti e che qualcuno aveva interesse a far diventare sempre più noti.
Un giorno in sala, per ridere, stilammo una classifica tra gli sport più dimenticati: la scherma la mettemmo tra il tamburello e le bocce.
I giornalini Scherma li conservo ancora tutti; mi preoccupa un po’ l’ingiallimento delle loro pagine, quindi li scannerizzerò e li ricovererò su un hard disk, così dureranno per sempre!
Commiato
Il serbatoio della nostra macchina del tempo è pressoché vuoto: di strada insieme ne abbiamo fatta un bel po’; dieci anni precisi.
Per fortuna per tornare indietro è tutta discesa!
Ora che sono riuscito finalmente a fermare tutti i miei ricordi su questi fogli, ora posso anche permettermi di dimenticare!